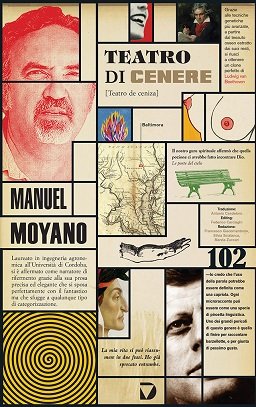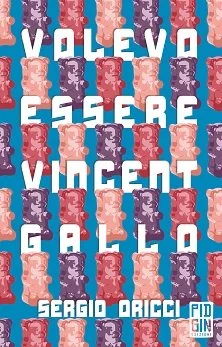Autore: María Fernanda Ampuero
Titolo: Sacrifici umani
Editore: gran vía
Traduzione: Francesca Lazzarato
pp. 148 Euro 14,00
di Beatrice La Tella
Che cos’è un sacrificio umano? Storicamente il termine fa riferimento all’atto di uccidere una o più persone, seguendo precise istruzioni rituali, in offerta propiziatoria a una o più divinità. Non c’è vendetta in un sacrificio umano, né giustizia, nessuna precisa espressione terrena riesce a contenerne la portata, nessuna legge può scandirlo al di là di un unico dogma: l’accettazione dell’ineluttabile. Forze terribili e potenti trascendono la comprensione e si può solo tentare di placarle, in una violenta ricerca di significato destinata a rimanere – almeno a livello razionale – insoddisfatta.
Che cos’è invece Sacrifici umani? Una raccolta di racconti della scrittrice ecuadoriana María Fernanda Ampuero, edita da gran via nella traduzione di Francesca Lazzarato, ma anche un piccolo, inquietante grimorio. Seconda incursione nella narrativa breve da parte di Ampuero dopo Pelea de gallos (2018) e i due libri di cronache non-fiction Lo que aprendí en la peluquería (2011) e Permiso de residencia (2013), Sacrifici umani è l’opera che la colloca in via definitiva tra le voci più importanti della narrativa latino-americana contemporanea.
Il volume è esile, si compone di dodici racconti che non superano il totale di centocinquanta pagine, ma sprigiona una grande potenza linguistica e narrativa. A farsene autentico proemio è la frase scelta come epigrafe: «Scrivere è anche benedire una vita che non è stata benedetta». La formula appartiene a Clarice Lispector, autrice che dell’assoluta intensità ha fatto la propria poetica, evocata in apertura da Ampuero come musa e nume tutelare.
I racconti di Sacrifici umani si concentrano su vite, appunto, tutt’altro che benedette. Protagoniste assolute sono figure che vivono ai termini ultimi della società: deboli, dimenticate, reiette, vittime per definizione e per definizione condannate al silenzio. È l’autrice a interrompere la maledizione e a restituire ai suoi personaggi la voce, la possibilità di esistere nel raccontarsi, sopravvivere osando pronunciarsi e così cercare forme inedite di riscatto. Le storie sono tutte vicende di marginalizzazione, spesso strutturata su più livelli. Per la protagonista del racconto Biografia, il torto da subire è doppio, in una dimensione di orrore crescente in cui può solo fatalmente avanzare:
Noi donne disperate siamo carne per il macinato. Noi immigrate, poi, siamo l’osso che si tritura per nutrire gli animali. La cartilagine del mondo. Nient’altro che cartilagine.
Altro riverbero del rifiuto investe le ragazze di Prescelte, giovani e libere ma non belle, non interessanti, non giuste, ragazze che sono soltanto esclusione e struggimento.
Volevamo, volevamo, volevamo. Eravamo puro desiderio. E pura collera. Sarebbe arrivato il giorno, sissignore, in cui tutti si sarebbero accorti di noi e avrebbero detto a chiunque fosse in grado di ascoltare: amatele. Amatele, l’ordine avrebbe percorso la terra» – in cui l’unica speranza di riscatto passa da un terrificante sabba necrofilo. O ancora le protagoniste di Sorellina, ciascuna con la sua condanna da scontare: «Le ragazzine grasse si nutrono di delusioni. Le ragazzine affamate si nutrono di impotenza. Le ragazzine solitarie si nutrono di dolore. E sempre, sempre, le ragazzine mangiano abissi.
L’abisso è un regno da incubo, humus fertile su cui germoglia ciascun racconto. Il culmine di ogni storia è in effetti una sorta di buia illuminazione, ascritta a differenti gradi di realismo: concreta come in Pietà, Edith, Lorena, in cui è più semplice trovare l’origine dell’oscurità (spesso incarnata da una figura maschile violenta o da una relazione malsana), o dall’impostazione più allegorica, in cui la narrazione si ibrida di elementi surreali costruendo una propria mostruosa mitologia popolare (come in Fischia) o si innesta su leggende ancestrali (come in Sacrifici). Ogni volta l’impatto è deflagrante, distruttivo, un’autentica riscrittura del mondo che si risemantizza alla luce della scoperta, di nuove indesiderate consapevolezze:
«In ogni vita ci sono momenti in cui si capisce tutto a un livello più profondo della propria capacità di comprensione. Le ossa capiscono, il grasso capisce, l’hamburger mezzo digerito capisce, il pancreas capisce, la bile capisce, le mucose, le membrane, i peli le unghie e ogni goccia di sangue capiscono. Capii che sotto certi aspetti i sentimenti sono simili alle infezioni: capaci di mandarti in cancrena da capo a piedi in pochi secondi, con una bocca grottesca che ti divora, un bagno interiore di mercurio, una palla di cannone. Se fossi morta me ne sarei andata sapendo che l’esistenza è puro orrore e che essere viva è puro orrore. E che quando lo sai, non puoi più non saperlo.
Scoprire la tossicità dell’emozione, del relazionarsi all’altro – il sentimento come vox media, quel pharmakon che è rimedio e veleno al contempo –, scoprire l’orrore al cuore della vita si rivela l’unica epifania possibile.
In un mondo in cui «l’età dell’innocenza è l’età della violenza», i personaggi si muovono come vittime designate verso finali scritti da sempre, forse ancora prima che l’autrice li pensasse, perché la caratteristica cruciale della vittima è per definizione l’impossibilità di opporsi, avere come unico predicato possibile l’immolazione. A partire da questi presupposti Ampuero compone dodici racconti spietati, incastri di parole che non temono l’eccesso né l’anatema. È senza paura infatti che afferma, con tutta la lucida rabbia che serve: «Dio non ama, gli uomini uccidono, la natura fa piovere acqua pulita sui corpi insanguinati, il sole sbianca le ossa, un albero lascia cadere una foglia o due sul visetto irriconoscibile della figlia di qualcuno, la terra fa crescere robusti girasoli che si nutrono della carne livida delle scomparse». Eppure, ogni tanto, qualcosa accade, l’ingranaggio della sacertà e della condanna si inceppa. L’inatteso si insinua a scompaginare il designato, perché è questa una delle facoltà ultraterrene della narrazione: muri ciechi che diventano finestre, spalancare universi dove era possibile solo la fine, accogliere ciò che è terribile e incantarlo a nuovi significati.
L’autrice realizza una raccolta composita, unita negli intenti e nelle tematiche ma variegata nella forma, nel genere, nel linguaggio. La prosa è attraversata da uno sperimentalismo vivo, ne è un esempio Biografia, col ritornello cadenzato che scandisce la storia «Guardatemi, guardatemi», in una continua richiesta di essere visti mentre si va incontro al più nero dei destini, in quello che è a tutti gli effetti un racconto di matrice horror; o ancora Sacrifici, composto soltanto da incalzanti linee di dialogo, mentre la coppia protagonista non riesce a smettere di litigare ignara di ciò che incombe su di loro; o Freak, in cui il pensiero spasmodico di due solitudini assolute che si uniscono in un ultimo gesto definitivo è scandito da soli verbi all’infinito, come un ossessivo elenco-componimento.
La vita si mescola a un paesaggio strabordante che, insieme ai personaggi, inghiotte la lingua per restituirla ora ricca ora scarna, a seconda di come l’autrice preferisce assestare il colpo, quanto vuole renderlo imprevedibile, quanto duro.
Cos’è dunque un sacrificio umano per María Fernanda Ampuero? È un momento selvaggio di scrittura – e, invocando ancora Clarice Lispector come sacerdotessa, apprendiamo che la scrittura è una maledizione, ma una maledizione che salva. È l’occasione di guardare fisso il buio lasciandosi trasformare, talvolta trovando insperate possibilità di consolazione nella ferocia.
«Splendevamo e ora siamo pieni di sangue», scrive Ampuero in un lampo di sintesi crudele.
Solo quando chiudiamo il libro ci rendiamo conto di quanto è accaduto: anche la scrittrice ha compiuto il suo rituale
.