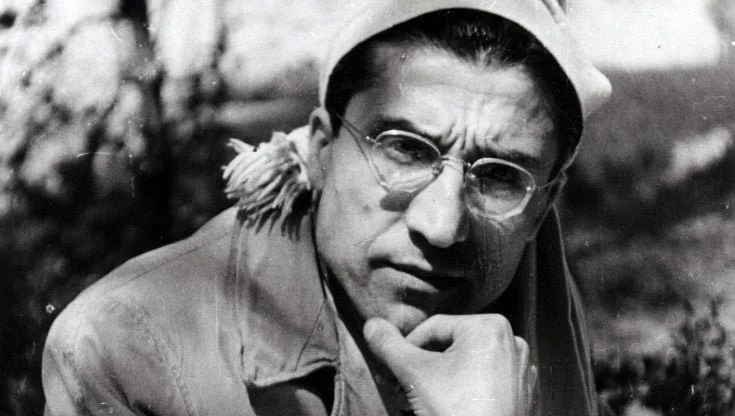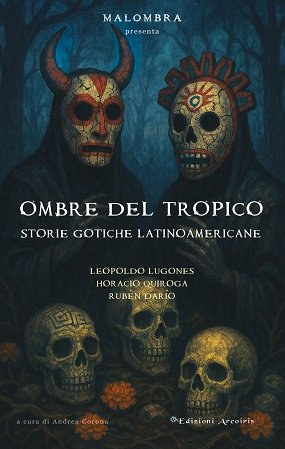La Santa di Arra
di Ippolito Nievo
I PARTE
I
Otto miglia sopra Udine a un'ora di cammino dallo stradale di Ponteba è fra due collinelle il villaggio di Arra, così romito nella sua valletta sotto l'ombra dei castagni e degli ontani, che accade talvolta passargli appresso senza accorgersene, eccettochè pel fumo azzurrognolo che sul mezzodì e dopo il vespro si dispicca a somiglianza di pennacchiera dai suoi comignoli. È un luogo di silenzio, di pace, d'umiltà, dove per secreta magia l'anima più intristita respira beatamente, e tacciono l'allegria clamorosa e lo spensierato motteggiare delle brigate, e le rughe si spianano sulla fronte del passeggiero solitario, e il sorriso, amico da gran tempo lontano, torna dolcissimo alle labbra. Una strada nuova, a ghiaia, nella quale la carreggiata, nitida e salda come marmo, è chiusa tra due strisce erbose, e queste solcate rasente le sponde da due sentieruoli, va via curveggiando tra quelle rive ombrate, tra quei cespugli, tra quelle macchie rigogliose, tra quelle acquette limpide e ciarliere; e si dilunga entro le sponde delle due chine, e torna addietro attraverso pascoli minuti ed odorosi, e poi risale serpeggiante il poggio, come partendosi a fatica da quei vaghissimi e tranquilli prospetti. E a buon intenditore significa: - qui non è tramestio di cocchi, di carri e di cavalli, e neppure incessante passaggio di granaglie o d'altre derrate campestri; sibbene pochi contadini sguizzan via col loro ronzino paesano a timone recando al mercato qualche staio di fagiuoli o di castagne, o vi cavalca sul vispo asinello il mugnaio, o le fanciulle vi camminano scalze col paniere dell'ova e dei galletti novelli . Per tal modo la strada segue piegando sui dispersi casolari, e fra loro annodando i crocicchi e i borghicciuoli del paesello, ma non mena direttamente fino a loro, e secondatili a breve distanza lascia tale incarico a viuzze minori più opache, più fresche, più selvagge come pensasse: -Non istà a me, opera dell'arte, sturbare la naturale semplicità di quel ricovero. Solo la chiesuola col solito porticato alla cappuccina dinanzi, s'avanza coll’un fianco fin sulla strada; ma è così piccina, così disadorna, che la si potrebbe torre per uno di que' tempietti che la devozione dei nostri vecchi ha disseminato per ogni canto più riposto e deserto di questo buon Friuli. Voltaire, passandole innanzi soletto all'ora del tramonto, le avrebbe fatto di cappello, e se il vento in quell'istante avesse destato la voce delle due campanelle oscillanti all'aperta sopra l'entrata, gli sarebbe tornato a mente l'AngeIus Domini, che recitava al collegio. Proprio a capo d'una di quelle stradicciuole, tanto sepolta fra due siepi di carpini ed erbosa e zampillante nel fondo da somigliare un fossato, sorge sopra la primissima falda del colle una casa di pittoresco e grazioso aspetto, d'intorno alla quale s'allarga un ripiano messo da pochi anni ad aratura, ma pur qua e là, o per incuria o per licenza de' padroni, invaso da giovinetti rampolli di castagno. Le vecchie piante atterrate per bisogno o per avarizia protestano da sotto le radici contro la tirannia dell'accetta, e quella nuova generazione sembra disposta a rivendicare i diritti dell'antica. La casa, dissi, è pittoresca e graziosa, ma non è merito dei muratori; bensì della madre natura che, ove si lasci fare, ripara pietosamente all'imperizia e all'impotenza degli uomini. Di fatti coprì ella di penduli cespi d'adianto le tegole rotte e sconnesse; vestì di verdissima edera i muri scrostati e screpolati dalla pioggia che vi cola dal tetto malconcio e gli stipiti cadenti delle finestre; nascose sotto belle eriche le macerie del cortile; colmò con festoni bizzarri di lambrusca le brecce del muro di cinta, e della concimaia fece colle acque piovane un laghetto a benefizio delle anitre e delle oche. Ad onta di tutto questo quella topaia non ha figura contadinesca; e certi segni, come la gradinata esterna di pietra, i battitoi marmorei della porta, e il coperto di cotto attestano l'agiatezza de' suoi fondatori. E neppure la cera è di malo augurio; più che ad un tristo immiserito dai vizi, l'assomiglieresti ad un disgraziato colto da contraria fortuna per troppo buon animo. Certo essa move in chi la contempli un senso di compassione, e si è tratto a pensare: -forse la miseria vereconda e paziente s'è accasata lì dentro, e fra le dolorose memorie de' tempi migliori v'uccide una famiglia a colpi di spillo.
II
Una sera di domenica verso la metà del giugno passato, una fanciulla contadina stava discorrendo presso i pilastri dai quali si entra nel cortile di quella casa. Discorreva, già ve lo immaginate, coll'amoroso; ed era un bel paesano sui venticinqu'anni adorno di quegli abiti smaglianti e di quel piglio festereccio di braveria, che tanto disformano la giovenaglia campagnola delle domeniche da quella dei giorni feriali. Anche la fanciulla era bellina, e gentile poi quant'altra mai. La sua pezzuola d'indiana rimboccata sul capo e cadente coll'un pizzo sulle spalle, i ricciolini castano dorati che le ombreggiavano naturalmente le tempie, il busto snello e serrato secondavano mirabilmente la freschezza d'un visetto ovale, nel quale gli occhi grandi e cerulei come sereno d'autunno e la bocca vermiglia e rotondetta come una ciliegia, s'accordavano a un sorriso di melanconia. Però la tristezza non appariva connaturale a quelle sembianze, e ognuno anche vedendola la prima volta avrebbe indovinato da quelle nuvole la tempesta del suo cuoricino.
- Sì, Meni; ti voglio bene di questa tua intenzione, ma persuaditi, - diceva mestamente la giovinetta; - persuaditi che faresti gran torto a barb’Andrea, venendo con me fino a Brescia!... Sai già come l'è fatto, che non ci sente bene sul mio conto; ora sarebbe un dargli ragione il piantarlo così per due settimane o forse più, senza dirgli né tre né quattro. E se gliene parli, sarà ancor peggio, perché nascerà una contesa, e questa mi accuorerà di più, se è possibile, e mi renderà più amara la partenza.
- Ma, Dio ti benedica, la mia Santa! - rispondeva il giovine un po' risentito: -tu credi essere venuta qui al mondo come la pecora per farti tosare; ma nessuno ha detto che sia così. Se barb’Andrea è cocciuto, ha il cuor duro ed è cattivo, devo farmi anch'io sul suo stampo? Mi pare che non lo voglia neppur il Signore. O che diritto l'ha lui di pararmi come un vitello lattone? ... L'è stato forse egli che m'ha fatto?
- No, non fu egli che t'ha fatto, e neppur tuo padre, buon'anima, soggiunse tutta dolcezza la Santa; - ma è stato lui ad aver cura di te ed a tenerti le veci dei genitori, è lui che ha piluccato se stesso per raggrumolare a te qualche poco di roba, e salvarti dalla coscrizione.
- Via; per qual motivo piangi ora, Santina? - riprese il giovine vedendo due lagrimone venirle giù giù per le guance, lasciandosi dietro una striscetta luccicante.
- Eh, tu lo sai bene il perchè!- rispose la fanciulla con un sospiro.
- Sì lo so! E sarei un cane se non t’intendessi; ma non v’è ragione di piangere prima del male. La lettera non dice che Gaetano sia aggravato d’assai, e al fin dei conti Brescia non è in capo al mondo, e devi ringraziar Dio che lo ha visitato in luogo, dove tu puoi accorrere a consolarlo e a guarirlo; perchè, credilo, quando si è lontani, val più una faccia di famiglia che ti guardi, che non tutto un carico di spezieria!
- Oh sì! sento che deve esser vero quello che tu dici, Meni! - soggiunse la giovinetta. - E credi mo che a Brescia si vada in un sol giorno come dice compar Tita? ... Il conte mi diceva giorni fa che l'è lontana quasi duecento miglia.
- Ma dicono che ci sia il vapore, - rispose Meni.
- Che è come sarebbe a dire?
- Che è come sarebbe a dire ... un coso che corre assai assai, e trasporta la gente da un capo all'altro del mondo in un batter d'occhio.
- E di' mo, che ci voglian dei denari assai?
- Ecco, - rispose Meni raschiandosi un poco; - io per me crederei che facendo così presto con questo diavolo di vapore, se ne spendano ancor meno, perché non se ne buttano a spizzico per le tasche degli osti. E guarda, barb’Andrea delle due vacche ha intascato a San Daniele trecento lire, e con queste, se volesse, noi potremmo far il viaggio in compagnia.
-No, no! - sclamò la fanciulla; - non voglio che tu gliene parli per nessun conto!
- Ma sai che mi vien la vergogna alla coscienza di lasciarti andar via così sola, ché, mio Dio, sei tanto novella! ... Scommetto che t'imbrogli alla prima parola che ti dicono! ... E poi come te la caverai a farti intendere con questo nostro gergo che nessuno lo capisce al di là di Pordenone?
-Eh, m'ingegnerò, si! - soggiunse la Santa: - quando era viva la padrona parlottava un po' il veneziano; e poi già non si dee badare a pro né a contro, e il conte me l'ha detto ch'io posso andare, e che è mio dovere di correre dov'è mio fratello, e che non avendo altro che lui, e lui non avendo altro che me, sarebbe una gran crudeltà il non darsi fretta.
- Ah ma ne dice di belle sai, il conte Orazio! Mi pare che per l’età incominci ... già mi capisci!
- Oh cosa dici mai? - Dico, dico che senza denari non si può mettersi in viaggio, e che il tuo padrone non ne troverà certo nella sua cassa che ha perso la serratura, il coperchio e il fondo da più di trent'anni! La fanciulla chinò il capo, e mordendosi le labbra per la gran voglia di piangere, gualciva con una mano la falda del grembiale.
- Via, dimmi un poco, - seguitava il giovine, - lasciando andare tutto il resto, dove sono questi quattrini? - Gli è, vedi ... che ...
- Gli è che, capisco anch'io, se non ci fosse premura, colla gerla in ispalla, e colle scarpe in mano si va lontano assai senza spendere! ... È questo che vorresti dire? Ma, credi mo, ch'io vorrò vederti a quel modo? ... Oh per questa volta barb’Andrea può gettare il suo cappello anche sul fuoco, che io ti verrò dietro fino in capo al mondo, come è vero che san Domenico è il mio santo, e che egli ci aiuterebbe!
- No, no, Meni, - balbettò la Santa; - non voglio vederti così in collera! De’ quattrini ce ne ho quasi al mio bisogno… La Martina del cappellano…
- Via, cosa c’entra ora quella vecchia strega?... Eh! tu mi nascondi qualche cosa, Santina; ma ti incappi troppo presto!... Hai un difettaccio di dir sempre la verità, e ti veggo la bugia correre su pel naso come se non fossi una femmina!
- No, non dico bugia, - riprese la fanciulla alzando il capo.
- La Martina, vedi, ha comperato della tela che avevo…
-Ah! scommetto io!... la tela del tuo corredo!... - sclamò il giovane.
-No, non è quella, - mormorò la Santa. -Torna mo a dirmi di no! se hai cera!...
-Ebbene sì, - rispose francamente la giovinetta: -l'è la tela che mi aveano tessuto per farne il corredo: che già, - proseguì ella con un po' di tremolio; - vedi che ci avremo tempo, e le mie compagne che sono buone me ne faranno dell'altra!
- Insomma tu hai giurato di farmi pigliar una rabbia da morirne! - gridò il giovane.
- No, Meni, io ti voglio bene assai assai, e se tu me ne volessi altrettanto, non daresti ora in ismanie che mi fanno proprio male! ... Non ho fatto bene forse a vendere quella tela per amore di quel povero Gaetano, che adesso forse è laggiù ... solo ... in un lettuccio ... E lo sai già che cura ci hanno dei soldati quando sono in malattia!
- Oh, và la! sei proprio una Santa e non ce l'intenderemo mai!
- Via, Meni! sai quanto affanno ho qui dentro, e tu cerchi ora accrescermelo coi tuoi atti cattivi!... - È vero, è vero! - gridò il giovane mordendosi il dito: - sono un poco di buono ma non lo sarò per nulla almeno, e corpo del sangue mio, se barb’Andrea non acconsente...
- No, e poi no, Meni, - entrò a dire risolutamente la Santa. - Prima barb’Andrea è il tuo capo di casa e tu devi ubbidire e non comandare a lui. E poi,- continuò più sotto voce gettando un'occhiata verso la casa; - c'è qui il mio padrone che avrà bisogno d'una persona di cuore finché io starò lontano, e non potrei fidarmi d'altro che di te!... Meni si tolse furiosamente il cappello di testa e lo sbatté contro il pilastro.
- E dire che col denaro si può far tutto!... - sclamò egli. - E barb’Andrea ne ha del denaro lo so io! Vecchi ostinati e sempre vecchi! Perché son venuti ai mondo cinquant'anni prima di noi si prendono il diletto di martoriarci l'anima.
- No, non è così che devi parlare! ... Se tuo zio è un buon massaio, se non ama lo spendio, è pel bene che vuole a te e a tua sorella, e devi anzi essergliene grato! - Oh! sì; va là che tutto il bene sta nei soldi!. .. Per me se mi avesse permesso di sposarti due anni sono, gli avrei regalato buoi, campi, casa e danari, ché non so cosa farmene; e sarei andato per colono o per bracciante, ché già son sano e il lavoro non mi pesa, e saremmo più contenti tutti e due!...
- Via, abbi pazienza!... ci sposeremo quando Dio vorrà!... vedi, abbiamo già ottenuto molto, che tua nonna mi vuol bene e non mi fa più la guerra come una volta dicendo che sono una cittadina e una cameriera!
-Sì sì, ma intanto?... Ecco che tua andrai pel mondo sola sola, come una povera rondine, coll’ali cimate!... E poverina poi, Dio sa come!
- Sono anzi una signora, - soggiunse la Santa sorridendo mestamente.
- Figurati che dalla tela ricavai centodieci lire!... Del resto poi non è la prima volta che vado pel mondo e sai che quando ci aveva il papà ho fatto de’ bei viaggi in Germania con Gaetano che faceva il muratore.
- Sì ma con Gaetano non eri sola!
- Oh veh! No ci sono le Resiane che stanno fuori di casa mesi e mesi eppur non incoglie loro alcun male!
-Basta! - fece Meni; - non mi ci so adattare.
-Perché non pensi a Dio e alla Madonna, - rispose la Santa. - Pensa che così vogliono essi, certamente a fin di bene, e ti ci adatterai. - Sarà come tu dici; ma pure se barb’Andrea…
- Via non parliamone più, ti prego Meni. Tu resta per amor mio ed abbi cura del conte; io domani mattina vado a Udine con compar Tita, e spero fra due settimane di tornarmene con Gaetano bello e guarito.
- Ma pure… - Senti, senti l’ora di notte!... Uh come ci è passato il tempo!... Bisogna che entri a far la polenta… Vieni in casa un pochino? - Che sia solo il conte?
- E’ solo certamente, - rispose la Santa, - poiché a dirtelo in confidenza, da un mese in qua che abbiamo finito il caffè, e il comperarne dell’altro non è tanto facile, mi ha ordinato di dire a tutti che è fuori di casa. E sì tutti sanno che da un anno non esce più perché… perché non ha vestiti un po’ decenti!
- Povero signore! - fece il contadino. - La è proprio così, che la ricchezza non ha occhi e corre da chi meno la merita. E così dicendo s’avvicinavano passo passo alla porta della cucina donde una lucernetta d’oglio di noce spandeva una luce rossastra e fumosa.
III
Quella cucina, la quale, benché riccamente decorata di fuliggine e povera d'ogni altra cosa, pure di consueto toglievasi dal comune per una certa lindura che sa abbellire fin la miseria, non era quella sera delle meglio ordinate. Tutti gli utensili di ferro e di rame, staccati dai loro chiodi giacevano alla rinfusa sul pavimento, la credenza d'abete spalancata mostrava come impaurite di quel rivolgimento e ritrattesi a consiglio ne' suoi fondi le poche stoviglie, e l'unico secchiello avea disertato lo sciacquatoio per acconciarsi in compagnia di due treppiedi sulla tavola. Presso al camino quasi cadente, eppur tanto pulito da mettere in affanno, sedeva sopra una panchetta un vecchio che mostrava settant'anni, tutto inferraiuolato come si fosse allora il gennaio. Buon per lui che il tabarro mostravasi di tal natura, da lasciar passare nonché l’aria, la luce, tanto n'era il panno spelato e malconcio; il cappello dal canto suo pareva riscattato appena da una salva d'archibugiate, ed i calzoni erano come si dice una carta geografica di sdruci e di rattoppamenti, sicchè tutta quella sua acconciatura invernale, aprendo d'ogni lato sportelli al fresco della sera, piegavasi per quanto poteva alle esigenze della state. Cionullameno quel mucchio di cenci aggiungeva maraviglia e compassione senza togliere dignità ad una testa nobile e severa; una vera testa da san Paolo, che si moveva fra essi. Ma il conte Orazio (ed era proprio lui, il padrone della Santa) non sembrava né consapevole né impicciato di quell'idea di grandezza che naturalmente traspariva da ogni suo atto; e allora appunto con tutta semplicità attendeva a schierare in bell'ordine quell'esercito di padelle, di laveggi, di cazzeruole, di paiuoli; e presili a mano uno per uno, li guardava accuratamente, e ne decantava i pregi ad un peltraio, che stavagli ritto dinanzi, e rispondeva con uno scrollo di capo ad ogni punto ammirativo del panegirico.
- Vedi, mastro Vincenzo: questo è un paiuolo che pesa, sarei per dire, più voto che pieno! E quel padellino? Osserva se lo stagno non pare dato adesso adesso! E le tre schiummaruole? Guarda che le hanno un dito di polvere; e poi già mi hai visto a staccarle dal solaio! ... Ma bada a questa secchia; ti so dir io, che costei non la deve avere gran conoscenza coll'acqua del pozzo! - Sì, sì, rispose burlevolmente il peltraio; - e gli è per darle maggior vezzo che le aggiunsero queste gemme agli orecchini! (E in ciò dire segnava col dito una risaldatura di ferro che ratteneva il manico). E poi guardi la bambinella, quante pozzette l'ha nelle guance! ... Scommetto io, che d'ogni stagione essa ha quel viziaccio fradicio che il mio naso ha solo nel verno!
- Eh và là matto! Non vedi qui dentro i segni freschi freschi del battitore?
- Veggo delle ammaccature belle e buone io, signor conte! Se questa secchia tenesse bene, crede mo' che l'avrebbe lì il pavimento cosi inzaccherato?
-Non credo che sia come tu dici, - soggiunse gravemente il conte; - e poi mettiamo pure che sia, guarda lì quanta roba fiammante ti regalo!
- Bel regalo in verità! quarantasei lire da trentaquattro soldi di questa rameria, che sputa e respira per ogni verso!
- Ah birbaccione! ci hai lì un paiuolo che ne costa di per sé cinquanta!
- Cinquanta manate nel gomito! ... ed io glielo pago a conto fatto ventidue lire.
- E la padella che non ha saggiato mai unto di frittata?. .. E la leccarda? Oh guarda un po' la leccarda! l'ha qui dentro un attendamento di ragnatele da disgradarne il campo di Sebastopoli; e ti giuro, sai, che son cinquant'anni che l'ho in casa, e dopo la morte della mia povera moglie non ha più messo la pancia sulle brage.
- Insomma un botto solo! - soggiunse mastro Vincenzo. - Compresa la secchia, perché la è lei, cinquanta lire!...
- Cinquanta lire? Ma se me ne davi quarantasei prima; ed ora ti aggiungo una secchia che non ha l’uguale, e ne cresci quattro soltanto?
- Grazie! - fece Vincenzo, - insomma vada per cinquantadue!
-Via, dammene sessanta, Vincenzino bello, l'è un conto più tondo, e ti assicuro io ch'è un bell'affare!
-Davvero, signor conte, che non posso! Parola data, parola giurata: ho detto cinquantadue lire, e non mi ritratto.
-Via! Ci vorrà pazienza, - soggiunse il vecchio; - e vada per le cinquantadue. Mastro Vincenzo mise la secchia nel paiuolo, nella secchia la padella, in questa il ramino e la leccarda, e dentrovi i treppiedi e le cazzeruole; e come tutto ebbe acconciato per modo che gli riuscisse agevole il caricarsene, trasse dal taschino una borsa di pelle onde snocciolare il prezzo convenuto. Il vecchio frattanto da un astuccio tutto sudicio avea tolti li occhiali e inforcatone il naso; ma di lenti ve n'avea una sola, e per riscontrare que' soldi gli convenne far d'occhiolino, come se appuntasse il moschetto ad un gallinaccio.
-No, non voglio oro! - sclamò egli, vedendo mastro Vincenzo tasteggiare una certa doppia di Roma tosata meglio d'un cappuccino.
- I patti son chiari, e ho detto, tutto in argento. Il peltraio grattandosi la nuca ripose la romana, e finì di contare la somma in tante lire sonanti; ma le gocciavano fuori a una a una, e pareva che coll'avvizzirsi del borsello si ristringesse anco il cuore di mastro Vincenzo.
- Così va bene, - fece il conte riponendo nella mano sinistra l'ultima moneta, dopo averla ben bene voltata, rivoltata e fiutata.
-Bene per lei, e male per me, rispose il peltraio caricandosi delle sue compere. E pensava: «oh dove diavolo il conte Orazio ha pescato tanta lesineria? Una volta, più era al verde e più la trinciava alla grande!» In quel punto gli s'affacciarono sulla soglia la Santa e il suo innamorato, ond'egli cercava di scivolare colla sua mercanzia fra dessa e lo stipite della porta.
- Cosa c’è di nuovo, mastro Vincenzo? - fece la ragazza trasecolata trattenendolo pel braccio.
- Niente, niente! - rispose colui non giungendo a liberarsi da quella stretta per avere ambedue le braccia impedite.
- Niente; ha ragione! - entrò a dire il conte. - Lascialo passare, figliuola! Sono imbrogliapiedi, dei quali ho pensato sbrattare la casa.
- Ah imbroglia-piedi li chiama! - rispose la fanciulla. -Veh, veh! Il paiuolo, la secchia, la padella!... Oh Madonna santa! E dove vuole che dimeniamo la polenta d’or innanzi, dove abbiamo a serbar l’acqua, dove friggeremo le cipollette, dove….Il vecchio a questa scappatella della ragazza si era alzato; e certo non gli andava a sangue vederla avviata a spiattellare ogni segreto della sua tavola, perché un certo lampo che non pareva di settuagenario gli balenò dalle palpebre, e dandole ricisamente sulla voce:
-Qui, il padrone son io! – sclamò; - e quando io v'assicuro che pei nostri bisogni ci rimane il necessario, a voi deve bastare! Buondì, mastro Vincenzo! - aggiunse con tono più dolce; -e se avrò bisogno altre volte di te, farotti avvertito.
La fanciulla si era fatta tutta umile e vergognosa in un canto e pareva lì lì per piangere; il suo promesso fissava il conte con due occhi incantati, ché mai non l'avea veduto severo e autorevole a quel modo; il mastro intanto, salutata fra i denti la compagnia, se l'era svignata col suo bottino, sbirciando tutto all'intorno le ignude pareti come a significare: «ho gran paura che in questo luogo non si possa aver più bisogno di me!»
-Aspettami un attimo, - riprese il conte come fu partito il peltraio, - torno dabbasso tantotosto. Infatti salì egli al piano superiore, e ne scese indi a poco.
-Guarda, Santina, disse alla fanciulla con voce rabbonita bensì ma che pur diceva: «non patisco obbiezioni»".
- Queste le son cinquantadue lire che mi avanzano delle gallette, le quali unite ai civanzi che mi dici di avere, ti basteranno a fare il viaggio, purché tu ti sappia moderare, e non perda il tuo tempo. Sapeva la ragazza, che dei soldi delle gallette non c'era più nemmanco l'odore per casa; pure conoscendo l'indole del padrone, fece le viste di credere, e presi quei denari, li intascò, ringraziandolo di tanta sua bontà. - Và pure, và pure, figliuola, a passartela via per questa ultima sera, - riprese il conte: - già io non ho bisogno di nulla! Guarda! se mi sentissi in gamba vorrei farti compagnia fino a Brescia. Ma pazienza, e lasciamocela passare!-
E ciò dicendo sospirò, ché non erano già le gambe, bensì qualche cosa non meno essenziale di cui mancava il buon vecchio per mettersi ad un viaggio. La Santa usci col suo bello e appena fuori diede in un pianto dirotto metà d'accoramento, metà di tenerezza. Il vecchio anch'egli poiché la fu lontana si terse di soppiatto una lagrima; e più tardi quando si trovò solo con lei, si mostrò tanto paterno ed amoroso da farle dimenticare l'apparente durezza d'un'ora prima, s'anche già la fanciulla non ne avesse intravveduto il caritatevole intendimento.
IV
La mattina seguente un tratto avanti giorno la Santa e Meni stavano appoggiati allo stesso pilastro dove li abbiamo incontrati la prima volta. Di lì a poco la giovinetta dovea imbarcarsi per Udine nella carrettella d'un ortolano, per poi nello stesso giorno, dietro i ragguagli avuti dallo speziale di Tricesimo seguitare fino a Brescia, dove suo fratello, dopo otto anni di milizia, attendendo il congedo era caduto infermo. Se i due amanti fossero turbati in quel colloquio di commiato ognuno lo può immaginare; ma la gente di campagna è così fatta, che rade volte fa del dolore una commedia; e un melanconico silenzio, qualche occhiata, qualche sospiro sono talora i soli contrassegni d'una disperazione, della quale non trovereste la simile nei cuoricini cachettici della città. Così la Santa non faceva la desolata per una separazione impostale più che dal dovere dal sentimento; e neppur il giovane dava in ismanie per vederla partire così sola, con poca contezza di costumi e di strade. Per verità tentò egli di farsele compagno fino ad Udine; ma la fanciulla gli diede ad intendere che sarebbe aggiungere male a male, e che giacché a quella di dividersi bisognava venire, tanto giovava venirci un'ora prima che un'ora dopo. Se egli le raccomandasse la prudenza e la fretta, non è nemmanco a dire. Ella all’incontro non ristava dal raccomandargli il vecchio conte e, - ho paura, gli diceva sottovoce -ho paura a dirtelo in confidenza, che sia proprio allo stremo; dunque ho pensato, di lasciare a te queste cinquanta lire.
- No, no, - la interruppe il giovine. - Tienle, che non ne hai d’avanzo, e lascia provvedere a me che non gli mancherà nulla!
- Ma per carità!, riprendeva la giovinetta. - Bada che non s’accorga di nulla; e rimetti la polenta nel sacco di mano in mano che l’adoperi; e quando ti domandasse dove hai pigliato la gallina che bolle nella pignatta, rispondigli nel suo pollaio. Per fortuna che l’è così svagato, che non ci vede dentro a queste piccole furberie; ma guai se se ne accorge! Ne serba il broncio per un mese.
- Datti pace, non se ne accorgerà.
- Che Dio te ne rimeriti! - soggiunse la fanciulla soffocando un singulto. Indi siccome sonavano i rintocchi dell’avemaria si ricordò che compar Tita non si perdeva in chiacchiere, quando aveva a menar gli asparagi sulla piazza di Udine, e corse verso casa per prender congedo dal padrone. Il conte la benedisse come una sua figliola, la ammonì d’aver cura del suo passaporto, e le sciorinò gravemente certe sue sentenze intorno al modo di viaggiare con minori noie e maggiore economia. Ma quando ella col suo fardelletto sotto l’ascella fu sparita dietro le siepi della strada, tanto schianto gli venne al cuore da doversi appoggiare alla tavola per non cadere. Le lagrime lo aiutarono a versar fuori parte dell’angoscia, e ne sparse tante e tante che non pareva un vecchio ma un bambino dal quale si fosse partita la mamma. Infatti il pover’uomo abbandonato vent’anni prima da una sua sorella per un capriccio donnesco, rimasto alcun tempo dopo senza la moglie, e lentamente rovinato dalla propria dabbenaggine e dalla crudeltà calcolatrice degli usurai s’era ormai avvezzo a collocar nella Santa ogni suo affetto. La poverina meritava del resto non solo gratitudine, ma ammirazione. Ella solo dopo la partenza del fratello, benché fanciulletta d’appena quattordici anni, avea bastato a servir il conte, a curare il proprio padre, infermo d’apoplessia, e quasi, sarei per dire, a mantenerli ambidue; giacchè le entrate eransi ormai ridotte al prodotto dell’orto ch’ella stessa lavorava, e a quelli del pollaio, ch’ella del pari venìa smerciando sui mercati. A tutto questo ritenevasi obbligata la piccina per certi servigi prestati nei tempi addietro al padre suo dal conte; ma da ciò per fermo non era menomato il suo merito, che si vogliono cuori assai gentilmente temprati per intendere e fare il debito loro con sì squisita e costante pietà. Il vecchio impotente era morto da cinqu’anni, né per questo ella si era tenuta sciolta da cotali doveri; e coll’età e colle forze eranle cresciuti animo e potere per darvisi tutta con migliore efficacia. Cionnonpertanto un tal continuo sacrifizio non le era stato senza giovamento; e prima di tutto l’anima sua erasi riconfermata nella naturale bontà colla diuturna consuetudine del vecchio signore; le sue maniere si erano raggentilite, svegliata la mente, assodato il giudizio; e benché i campagnuoli all’incontro crocchiassero che la sapeva di cittadina, pure dentro a se stessi la ponevano ben alto, e non poteano far a meno di mostrarlesi cortesi, e né due ultimi anni, il giovine contadino che avea saputo farle parlare il cuore, non era poco invidiato dai compagni.
- Sì, là è un vero angelino quella fanciulla! - mormorava il conte asciugandosi gli occhi e montando le scale. Come fu nella sua camera si mise ad un balconcello, e di là porgendo gli occhi nella campagna distinse la carrettella di compar Tita con entrovi la Santa che volava via per la strada di Tricesimo; e un cento passi indietro stavasi il povero Meni, che dell’una mano salutava, e dell’altra tergevasi ei pure le ciglia.
-Cosa vuol dire eh! - seguitava a borbottare il conte. - Anche il bene corre dietro a chi meno lo merita!... Io mi ho cavato, si può dire, il sangue, per far contenta e ricca mia sorella, e quella se n’è andata, e in vent’anni, in vent’anni, mio Dio! non si è degnata rispondere ad una lettera!... E tutto per uno scapestrato, per un uomo che l’avea stregata, e che la sposò in seguito pei suoi quattrini! Oh se fosse vissuto il suo primo marito non la sarebbe mica andata così!... Pazienza; ma quella povera Livietta, quella povera orfanella!... Oh me la ricordo ancora come fosse ieri: l’aveva otto anni soli, ma il suo cuore era già perfetto, come è ora quello della Santa. Dicono che sia maritata anche lei!... Poverina, chi sa quali brutte cose le hanno dato ad intendere sul mio conto per cancellarmi dalla sua memoria. Questo pensiero parve dare al vecchio maggior cruccio d’ogni altro; ma egli era nato in quel secolo bietolone, quando la fede era reputata, com’è, la miglior medicina ai mali della vita, e perciò la si soleva instillare con ogni cura nelle anime. E quanto quella devozione antiquata vincesse in effetto ogni filosofia, la dimostrò la faccia calma e rassegnata colla quale mezz’ora dopo prese commiato da Dio. Intanto il cavalluccio dell’ortolano trottava sulla postale inalberando vispamente le orecchie, e mordendo le redini o il timone ogniqualvolta l’irrequieta frusta del padrone gli sfiorasse la groppa. Furono ad Udine proprio nel momento che si fornivano i cavalli per la messaggiera di Pordenone; e per ventura un vecchio amico di compar Tita partiva appunto allora a quella volta; onde la Santa gli fu caldamente raccomandata da questo, e siccome gli era un capo ameno e un buonissimo diavolo, così per quelle cinque ore di viaggio la giovinetta sentì dimezzato il peso della melanconia e della solitudine.
V
Arrivati a Pordenone ove faceva capo in allora la strada ferrata, il nuovo protettore della Santa non volle lasciarla se prima non l’ebbe aiutata a comperare il biglietto e a salir sul convoglio che partiva per Mestre. La poverina gli fu grata assai di tali buoni ufficii, poiché in quell’andirivieni di gente e di bauli, in quel gridio dei conduttori, in quegli strani rumori delle macchine perdeva a mezzo il cervello. E tutto fu per ismarrirlo quando si misero in moto, e fu sciolto ogni freno al vapore. Quegli alberi, quelle case che parevano cadere all’indietro per la veemenza della corsa le davano il capogiro e cogli occhi ristretti mirava trasecolata in quel vario balenio che appariva fuori del menestrello; insomma era così sorpresa, che a nulla poteva pensare, come si trovasse fuori affatto della vita. Ma la maraviglia quanto più grande e subitanea, tanto meno dura nelle anime semplici de’ contadini. Avvezzi ad ubbidire più al sentimento che al raziocinio, prima alla fede che alla scienza, diffidando essi di salir passo passo dove non saltino di piè pari; e mentre le menti educate nella difficoltà si incaponisono, essi all’incontro guardano, ammirano, e non comprendendo, in breve pensano ad altro. Così la Santa dopo un quarto d’ora stanca e rivenuta dalla maraviglia di quella corsa che pure le sembrava affatto miracolosa, s’adagiò nel suo cantuccio ai soliti pensieri, come se fosse seduta in qualche prato di Arra; e Gaetano, Meni, il conte Orazio, barb’Andrea, la vecchia Martina e il buon cappellano del suo paesello le tennero buona compagnia pel resto del viaggio. Quel giorno era pochissima frequenza di viaggiatori, onde non fu sturbata dal suo raccoglimento pel cicaleccio o la curiosità dei vicini, e se due o tre giovinastri dalle panchette di prospetto la bersagliarono d’occhiate, ella per fermo non se n’accorse. Così giunsero a Verona, ove scesero tutti, nessuno montò; sicché la Santa rimasta soletta colse destro per snodare il fardello e sbocconcellare un pane bigio che vi aveva riposto. Indi siccome affogava della sete smontò essa pure, ma mentre s’accingeva a domandare del dove l’avrebbe trovato un bicchier d’acqua, ecco un discorso che facevano dietro a lei fermarle subitamente il pensiero.
- Oh che vuoi che vada a Brescia oggi? - diceva uno. -Figurati che stamane in due corse vi condussi tre passeggieri, fra’ quali due suore di carità!
- E il cholera cresce ancora? - domandava un altro.
- Caspita se cresce!... Centoventi casi ieri; oggi a mezzogiorno passarono già i cento!
- Oh poveri noi! E ce lo porteranno anche qui, vedete!
- Poveri noi, di’ piuttosto, che ci tocca andare in quella peste, e se domani ci rivedremo sarà per grazia di Sant’Antonio! La Santa sentiva i griccioli nel sangue; la sete le era passata via e tremava sulle ginocchia come se avesse udito la voce dell’orco: ma la campana in quella sonò, i condottieri strillavano: - Brescia, Coccaglio, Milano! - e le convenne rimontare alla meglio, e darsi fretta benché le gambe le reggessero a fatica. «Povero Gaetano! in mezzo al cholera!», pensava ella; chè il proprio pericolo non le era pur passato pel capo. « In mezzo al colera!», ripensava con un brivido. Per verità non conosceva per nulla una tal malattia, chè al suo paese non la c’era mai stata, ma ne avea udito parlare con tali amplificazioni da crederla forse a tre doppi spaventosa e micidiale di quanto non sia. «Povero Gaetano!», riprendeva fantasticando. «E se lo avesse anche lui quel brutto male?... e se arrivassi tardi? Oh no, Signore!… Oh no, no, Vergin benedetta!» pregava la sventurata cogli occhi e più col cuore nel cielo. E già le pareva che il vapore fosse una tartaruga; e certo lo era appetto alle ali del pensiero, sulle quali avrebbe voluto volare a Brescia, e scendere, angelo di consolazione e di salute, daccanto al letto di suo fratello.
VI
A Brescia non arrivò che in sulle sei. La caldura era agostana, il polverio denso rossastro, l’aria greve e stagnante. Il colera si sentiva in essa, come per solito invece vi si sente una virtù ristoratrice. Alle porte quell’apparato di guardie, di suffumigi, che nel furente imperversar del malore accresce negli animi lo spavento senza ammortire nei corpi il germe letale; per le strade una solitudine spaventosa; il silenzio nelle piazze; le botteghe o serrate o appena socchiuse; allo svolto delle cantonate la faccia interriata di qualche femminetta che va per le spese necessarie della casa; qualche gruppo bestiale d’infermiere; qualche medico che sacrifica se stesso non più alla salute dei fratelli, ma alla propria coscienza; qualche prete invocato da dieci moribondi, che s’affretta di casa in casa per benedirne almeno i cadaveri; ogni tratto la barella del lazzaretto più spaventosa omai dello stesso cataletto, e le carrette delle masserizie infette guidate da musi sinistri che per nulla la cedono ai monatti d’una volta; e in mezzo a questo il tetro scampanio che grazie alla gentile civiltà conserva omai le prerogative dei ricchi fin nei contagi, tutto questo, lo veggiamo, è poco a paragone dell’orrendo corteo menatosi addietro dalla peste nei secoli scorsi, ma l’era abbastanza per movere a raccapriccio l’anima d’una giovinetta vissuta sempre nell’aria salubre e nell’allegra calma della campagna. Fortuna per lei, che la novità e la bellezza del sito le rompessero di tratto in tratto il pensiero di queste melanconie! Per quella pulita e simpatica Brescia camminò lunga pezza alla ventura, cercando cui chiedere dell’ospital militare; finchè fattasi cuore entrò da un fornaio, e mosse timidamente la sua inchiesta nel veneziano più puro che seppe trovare. Il botteghiere si fece indietro nel suo banco e stava per risponderle, quando vedendo passare una lettiga portata da soldati: - Guardate, le disse - bella giovine, vedete quel corteggio?... Or bene tenetegli dietro, e andrete dove domandaste. Ma non tanta fretta, aggiunse vedendola disporsi ad uscire: -seguitelo così alla lontana, chè con certi negozi non si vuol troppa dimestichezza; e nello spedale non vi consiglio d’entrare; e se cercate di qualcheduno domandatene conto piuttosto al Comando militare, che è qui alla seconda contrada dov’è la sentinella.
La Santa uditi i consigli del fornaio, e ringraziatolo, si mise a correre per raggiunger la lettiga che allora appunto spariva dietro un canto. All’ospitale era una tal confusione, che dopo un quarto d’ora a fatica potè farsi dar mente da un infermiere.
-Che io so del vostro Gaetano! - le rispose costui alzando le spalle; ma fosse la bellezza, fosse lo sgomento della giovinetta a rabbonirlo, riprese più umanamente: -Via, ditemi il cognome e la compagnia, e guarderò di saperne nuova.
-Il cognome è Diamante, ma della compagnia non so, - rispose la giovinetta.
Il soldato scrollò per la seconda volta le spalle, e disponevasi senz’altro a rientrare, ma un sentimento di pietà ancora lo ritenne: -Fermatevi qui - diss’egli; - e se potrò, verrò a dirvi qualche cosa. La giovinetta colla pazienza tutta propria dei contadini ristette due buone ore, dopo le quali il soldato discese, e le passava accanto senza ricordarsi di lei; ma fu pronta essa a chiamarlo, e seppe che da alcuni giorni Gaetano era assai aggravato nella sala n. 2. In queste parole l’infermiere se n’era ito pei fatti suoi, raccomandandole d’andarsene tosto, perché lì era proibito il fermarsi a lungo e d’altronde l’avrebbe potuto pigliare il colera. «Che me ne vada?» pensava la fanciulla. «E cosa vuol dire che me ne vada? Pare che sia vietato l’introdursi là dentro, altrimenti non lo sarebbe il fermarsi qui sulla porta! Ma già non vorranno mica pretendere ch’io abbandoni Gaetano! Oh no! Dovesse andarne della mia vita!».
In queste tristi considerazioni si fece zitta zitta dietro la porta, e appena vide sgombro il luogo, volò su per lo scalone; indi imboccato un corritoio corse per esso guardando molti usci che vi si aprivano a destra e a sinistra. Quello segnato del n. 2 era appunto chiuso ad un giro di chiave, ella lo aperse con mano tremante ma oltrepassò risoluta la soglia. Erano nella sala cinque soli letti e tutta la occupava un silenzio più di sepolcro che di spedale. La poverina, sostenuta dalla forza grandissima del cuore, fecesi al primo capezzale e si curvò sopra la faccia violacea, immobile, sfatta d’un cadavere: le mancavano le ginocchia, pure passò al secondo, e lì pure le si offerse un viso sformato dalla morte sul quale erano scritti spaventosamente gli spasimi dell’agonia. Rifuggì tutta smarrita; il cuore le batteva precipitoso, pareva che le scoppiassero i polsi delle tempia, gli occhi, le labbra avea spalancate dall’angoscia e dal terrore. Cionnonostante si trascinò al terzo letto; lo sventurato respirava ancora, benché l’intirizzimento della persona, il nericcio delle vene e un cupo rantolo che parea uscirgli dal fondo delle viscere lo dimostrassero alle prese colla più terribile ora del male. La Santa sentì quel respiro cupo spaventevole prima di scernere le fattezze del moribondo; e un certo che le andava dicendo nel cuore: «guardalo è tuo fratello!» Guardò, ma non le parve esser vero come il cuore parlava. Era una figura scarnata, livida, chiazzata di macchie cenerognole, colle labbra vizze e rattratte a un riso satirino, coi denti inchiodati convulsivamente, fra i quali quel rantolo d’agonia strideva più lugubre e doloroso. Pure negli occhi… sì negli occhi durava alcun che dell’umano: erano vitrei e sbarrati, ma l’anima vinceva in essi la potenza pervertitrice del morbo, e ancor l’infondeva d’un’angelica bontà. La poverina tuffava un suo sguardo pieno di speranza, di paura, d’amore in quegli occhi impietrati, quando la mano le si impigliò nel cordone d’una medaglia che pendeva fuori del letto e cingeva il collo dell’infelice. La guardò con un’ansia impossibile a descriversi; poi sclamando: -Gaetano, Gaetano! - gli si buttò perdutamente colle braccia al collo. Il malato parve riconoscerla, e certo lo impediva dal dimostrarlo l’intorpidimento del morbo. Pure dopo miracolosi sforzi abbrancò egli una mano della fanciulla per posarsela sul cuore; ma poi parve pentirsi e respingerla, e quel suo rantolo sforzandosi d’assumere suono di parola strideva quasi minaccioso fra i denti. - O Gaetano, finalmente ti ho trovato!... Oh Dio ti guarirà, ne sono sicura! - seguitava a dire la Santa, a più riprese baciandolo, e inondadogli la fronte di lagrime. -Và via! - riuscì a dire l’infermo con un conato supremo. -Andar via, andar via or che ti ho trovato?... Ora che abbisogni più che mai d’un’anima che ti conforti d’amore?... Andar via? Oh no, mai mai, lo giuro alla Madonna!- sclamava abbracciandolo più strettamente la giovinetta. E benché tutta ancora sconvolta per quel tremendo spettacolo, pur con donnesca pietà adoperavasi per acconciargli il guanciale; e gli parlava armoniosamente nel dialetto del suo paese, e rincacciando nel cuore le lagrime che le gonfiavano le palpebre, si sforzava di sorridergli. Accortasi poi delle sue labbra così riarse e contratte, prese un bicchiere che era lì presso, ed ella prima saggiatolo, e chiaritasi che conteneva dell’acqua, lo accostò alla bocca del poveretto, fissandosi in pari tempo in lui con tale atto di carità e di preghiera da rattenere l’anima di lui anco se giunta al varco mortale. Così stette un pezzo come fuori del mondo, e già le pareva che Gaetano si venisse ricomponendo in viso; e negli occhi tornavagli goccia a goccia la vita, la quale lentamente diffondeasi all’intorno; parecchie volte e sempre invano avea egli fatto prova di parlare, finchè socchiuse dolcemente i denti, e un filo di voce ne uscì, non più cupo e affaticato, ma lieve e soavissimo come di fanciullo che stia per addormentarsi. -Santa, fuggi, fuggi per carità! - diss’egli a quel modo. -Ah finalmente! - sclamò questa; -finalmente! Lo sapeva io!... la Madonna mi ha esaudito… e tu guarirai… sì, Gaetano…. E gli si apprese alle labbra un’altra volta, come sperasse a forza di baci ridonargli la salute o levargli la malattia assorbendola essa stessa. Poi si alzò come per contemplare il miglioramento ottenuto con quelle carezze; ma nel rizzarsi sentì un’acuta puntura e come uno stiramento allo stomaco; un brivido le corse il midollo delle ossa; mise le palme alle tempie ed erano fredde ed asciutte come ghiaccio nel cuore del verno. -Dio mio! - mormorò guardando angosciosamente suo fratello. Questi aveva osservato quegli atti dolorosi della fanciulla; e con crescente spavento vedeva il suo bel visino profilarsi e incavarsi a vista d’occhio, come cera che coli. -Santa, Santa per amor mio, vattene! - sforzavasi a dire. -Chiama qualcuno!... tu stai male!... Soccorso!....