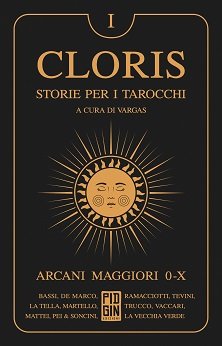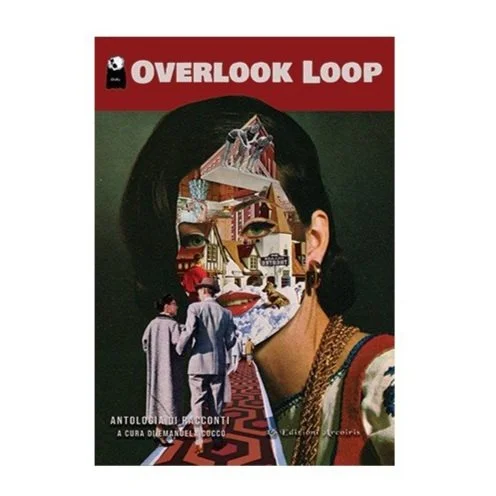Overlook loop, a cura di Emanuela Cocco per Edizioni Arcoiris, è un libro di racconti di case occupate e infestate, edifici teatro di apparizioni fantasmatiche e di ossessioni nere e sinistre debitrici al film Shining di Stanley Kubrick.
Edifici insidiati dalle ombre, che evocano una fatale arrendevolezza al delirio e alla violenza. L’Overlook Hotel, il teatro dell’azione di Shining, un romanzo horror di Stephen King, un incubo cinematografico di Stanley Kubrick. Case che disorientano, terrorizzano, che tengono in assedio, che intrappolano, tormentano, cancellano. Edifici come camere di martirio, incubi interpretativi che conducono alla perdita della ragione, all’avvento del disordine indicibile e dell’orrore.
Gli autori presenti nella raccolta: Dario De Marco, Veronica Galletta, Francesco Follieri, Romeo Vernazza, Pierpaolo Di Mino con Veronica Leffe, Micol Beltramini e Angelo Mennillo, Cristiano Saccoccia, Simone Lisi, Luca Mignola, Andrea Frau, Andrea Zandomeneghi, Arturo Belluardo, Claudio Morandini, Fabrizio Lucherini, Marta Cai
Ospite straniero: Francisco Magallanes (Traduzione di Antonella Di Nobile)
Prefazione di Paola Del Zoppo, postfazione di Bartolomeo Cafarella.
Cattedrale vi propone il racconto di Dario De Marco, per gentile concessione dell’editore.
Studi etnografici a Kill House
di
Dario De Marco
Come lei ben sa, non c’è cura senza sogno, non c’è analisi senza narrazione, non c’è interpretazione senza interpretazione. Perciò questo è il racconto del sogno che ho fatto, dell’incubo che sto facendo, del labirinto onirico nel quale, a volte, ho l’impressione di vagare ancora.
Non è una storia di paura, avevo detto al mio amico Stefano, però è successa davvero. Sì certo, aveva fatto lui, dicono tutti così, peccato che poi sia esattamente il contrario.
Avevo sorriso ma avevo aggiunto: anzi, sta succedendo.
A quel punto lo avevo incuriosito, ma Stefano non lo avrebbe mai ammesso, perciò aprii la porta delle confidenze senza aspettare un invito. La presi alla lontana, iniziando con gli scarafaggi: le blatte che nella città dove viviamo sono endemiche (a differenza del posto in cui sono nato, che pure ha fama di essere sporco e degradato). Blatte che sembravano sbucare dal nulla, ma quella è la loro caratteristica, convenimmo: se vedi uno scarafaggio in un angolo, vuol dire che acquattati per la casa ce ne sono venti, come mi aveva detto il tizio che era venuto a fare la disinfestazione, peraltro invano. Quindi se sbucano a decine, significa che nelle tane, dietro i battiscopa o nelle cerniere dei mobili, ne proliferano a centinaia. Già, ma la cosa strana è che questo numero ipotetico sembrava variare in maniera repentina, nonché priva di logica: potevamo lasciare del cibo incustodito per terra, e trovarlo intatto, per poi imbatterci in quegli esseri schifosi, che sono soliti scrocchiare sotto le pantofole, nelle stanze meno appetibili della casa.
La polvere, la sporcizia, anche quelle tutto sommato erano normali, almeno a casa nostra: non eravamo mai stati fissati con la pulizia e con l’ordine, né io né mia moglie, e poi da quando c’erano i bambini il caos non aveva fatto altro che prosperare. Certo che però a volte faceva specie vedere delle macchie di unto sul pavimento subito dopo aver passato lo straccio, o cumuli di polvere aggrovigliata a peli sbucare da sotto al cuscino di prima mattina. C’erano poi i rumori dentro alle pareti, come di detriti che scivolavano lungo una conduttura, il che pure poteva essere: il proprietario precedente ci aveva raccontato che prima, in quel vecchio palazzo del centro, in ogni appartamento c’erano vari camini, che poi erano stati murati – persistevano le relative canne fumarie, come grotte cieche nei muri. E c’erano le cose che sparivano, ma questo succede a tutti, figuriamoci a noi; a noi però ricomparivano, dopo giorni o anni, nei posti più incongrui: un vasetto di marmellata nel cesto dei panni sporchi, i soldi dentro ai libri, le posate in fondo alle scatole dei pupazzi. Di queste inusuali allocazioni attribuivamo naturalmente la responsabilità ai bambini, o a volte ci accusavamo l’un l’altra; il che non faceva che aumentare la tensione e i continui screzi che avevano caratterizzato il nostro rapporto da sempre, ma in particolare da quando, freschi sposi, neo genitori, eravamo entrati in quella casa.
Tutte queste cose avevano una spiegazione: razionale, psicologica, soggettiva. Il fatto è che, mi resi conto mentre raccontavo a Stefano, per una forma di vergogna stavo omettendo i particolari più misteriosi, illogici: le macchie sui muri che scomparivano e riapparivano, senza legami apparenti con la stagione o con altri fatti concreti quali perdite, lavori eccetera. Le crepe, che in modo ancora più inspiegabile percorrevano i soffitti come rughe in un volto antico, e poi quando finalmente ci decidevamo a chiamare l’amministratore, o un imbianchino, di colpo sparivano, lasciando uno strascico di aspre polemiche e di dubbi sul nostro senso della vista. La muffa, che io scherzando avevo iniziato a chiamare l’inquilino, da quando avevo letto che i funghi, regno cui le muffe appartengono, sono esseri viventi ramificati, le cui propaggini invisibili possono spargersi per metri o chilometri, pur appartenendo allo stesso “individuo”. Era perciò probabile che le muffe che infestavano gli angoli più riposti dell’appartamento, fin dentro il frigo, fossero un solo, grande essere vivente. O gli interruttori della luce, le prese, che sbucavano in posti del muro dove avremmo giurato non fossero mai stati, mentre altre volte la mano andava a colpo sicuro nel buio, per tentare di fare clic su una parete perfettamente liscia.
Forse fu proprio per questo, per non perdere la sua attenzione, per timore che tutte queste autocensure finissero per fargli ritenere la cosa di poco conto – lo era, in effetti, o almeno così pensavo allora – per una specie di rivalsa verso l’aria di sufficienza con cui già iniziava a guardarmi, o così parve a me, fu allora che feci al mio amico la rivelazione che mi ha portato fin qui, in questa strada senza uscita. Buttai l’osservazione lì, quasi per caso: la coincidenza, che avevo notato, tra gli strani fatti della casa e gli avvenimenti della nostra vita. L’ennesimo litigio con mia moglie, la prima uscita serale della figlia quasi adolescente, i capricci del bambino piccolo, le tensioni, la noia, la rabbia, i malintesi, i rancori – insomma tutto quello che rende speciale la vita di una famiglia, d’altra parte non è per questo che ne formiamo sempre di nuove?
E poi aggiunsi, quasi sottovoce, di nuovo vergognandomi, che pareva quasi come se la casa reagisse agli umori dei suoi abitanti. Quello che mi stupì nella sua reazione, fu la mancanza di stupore: sorrise come se non stesse aspettando altro. Proprio come pensavo, disse, qui ci vuole un analista.
Un analista, ripetei come un’eco. Sì, un analista immobiliare, anzi un’analista, disse per farmi sentire l’apostrofo, ne conosco una bravissima. No un attimo, mi opposi, non ci siamo capiti io a casa mia mi trovo benissimo, non ho la minima intenzione di vendere. (E poi chi sa se riuscirei mai a vendere con quello che succede, come in quei racconti di case dove sono avvenute delle brutte storie, che portano la fama di essere infestate, maledette, o semplicemente sfigate, e che perciò nessuno vuole comprare.) Ho detto analista immobiliare non immobiliarista, mi rimbrottò Stefano, e neppure architetto, mi sembra evidente che il problema non è fisico.
Ma quindi analista… Nel senso di terapeuta, psicologa, strizzacervelli dai, benché qui tecnicamente non ci sia un cervello da strizzare. È pure una mia mezza parente, o almeno portiamo lo stesso cognome, spesso ci scherziamo su questa cosa, magari ci esce un po’ di sconto. Non sapevo bene cosa dire, quindi non dissi niente.
Stefano invece aveva continuato, ironizzando sul fatto che una persona colta come me opponesse resistenze, così tanti anni dopo la scoperta dell’inconscio da parte di Sygmund Floyd, che aveva introdotto il concetto nel seminale Psicopatologia della prima casa, e sistematizzato il metodo nel successivo The dark side of the room. Si sa, le patologie mentali si portano ancora dietro uno stigma che quelle fisiche non hanno più, commentò il mio amico, ma pensavo fosse un atteggiamento da persone più anziane, nella nostra generazione chi ha questi pregiudizi, ormai. Se invece, come immagino, quello che ti lascia perplesso, che rifiuti ideologicamente è l’approccio medicalizzato, sappi che molti analisti contemporanei, tra cui quella che ti propongo, non sono di scuola classica ma seguono le teorie archetipiche di C.N.S. Young, prima allievo e poi avversario del padre della psicanalisi immobiliare. Certo certo, avevo abbozzato, pensando che l’importante è il risultato, e a quel punto un tentativo male non poteva fare. Presi perciò appuntamento, ma in via precauzionale decisi di non dire niente a mia moglie. Il mattino dopo entrai nel ripostiglio, l’unica stanza della casa senza finestre, e vidi incollato alla parete un geco enorme, viscido e trasparente.
Ricordo ancora il primo incontro con lei, è quello che ricordo meglio, non che gli altri non siano stati importanti, ma nella memoria si appiattiscono e si amalgamano in un unico flusso, in una sola infinita seduta.
La prima cosa che fece, rapidamente, fu elaborare una diagnosi; e io che credevo quello fosse il punto di arrivo della terapia, non la partenza. Ricordi, disse, psicosomatico non vuol dire inventato, non vuol dire inesistente. I malesseri psicosomatici portato effetti fisici non meno reali. Ogni malattia è un sintomo, ogni sintomo è un messaggio.
Mi aveva poi iniziato a fare un lungo preambolo, una specie di riassunto della sua materia, come se avesse a che fare con un alieno che fosse appena arrivato per caso su quel pianeta; il che peraltro corrispondeva esattamente al mio stato d’animo, quindi misi da parte l’irritazione per non essere ascoltato come speravo, e stetti a sentire. Partendo dall’epoca preistorica in cui alle costruzioni veniva ingenuamente negata qualsiasi identità, in cui venivano usate come strumento, come esca (la Casa di marzapane, la Cantina di Barbablù). Passando per l’epoca successiva, che aveva trovato il culmine nel Gotico, epoca in cui alle case veniva riconosciuta una certa agency, ma sempre in virtù di forze esterne che le animavano, le infestavano: forze di origine umana come i fantasmi, o mostruosa come i demoni, ma comunque entità altre.
Ci furono dei precursori, nelle ere precedenti a quella moderna, mi spiegò: per esempio Chesterton, da vecchio esorcista cattolico, parlava di un palazzo che è più e meno di un palazzo, di una torre la cui sola architettura è malvagia.
Da lì all’elaborazione dell’inconscio immobiliare, il passo fu breve, fu enorme.
In epoca contemporanea, aveva detto, l’approccio più medico-scientifico, di stampo neuroingegneristico, era tornato in auge; come si erano molto diffuse le storielle divulgative alla Oliver Sax (La donna che scambiò suo marito per un castello, la più nota). Aveva poi nominato i pilastri del costruttivismocomportamentismo, la corrente di architettura anti psicanalitica che mira unicamente a ottenere risultati concreti e misurabili, e i cui autori avevano ideato delle specie di manuali pratici, quasi delle guide: Come costruire una casa di foglie (J.Z. Truant), Come demolire una magione in una sola notte (E.A.P. Usher), Come occupare una casa, metà alla volta (J.C. Morelli). E infine le ricerche sul campo di Bessie Jackson, i sopralluoghi e gli studi etnografici a Kill House, alla villa PyncheonMaule, all’Overloop Motel.
Come lei ben sa, non c’è cura senza sogno, non c’è analisi senza narrazione, non c’è interpretazione senza interpretazione. Perciò è giunto il momento di raccontare di quella notte, dell’incubo dal quale non mi sono mai svegliato, o del sogno che non è mai iniziato, ammesso che ci sia una differenza. Mia moglie era andata qualche giorno fuori con i bambini, con la scusa di un ponte, del primo caldo, dell’invito di amici; sospettavo in realtà per allontanarsi un po’ dalla persona paranoica e cupa che stavo diventando, o peggio, dall’atmosfera paranoica e cupa che ci stava avvolgendo.
Potevo dormire, finalmente: ma non ci riuscivo. Le sarà capitato, o ne avrà letto, sentito parlare: l’insonnia prolungata, unita alla deprivazione sensoriale che di solito si sperimenta nelle ore notturne, quando la casa è immersa nel buio e nel silenzio, può portare a visioni, allucinazioni, distorsioni della percezione e veri e propri stati alternativi di coscienza, non dissimili dallo stato onirico. Così come in sogno abbiamo delle rivelazioni – è l’inconscio che lavora per emergere, naturalmente – e all’improvviso un aspetto della nostra vita ci appare chiaro, quasi ovvio (lei ci tradisce, il nostro capo sta per licenziarci, abbiamo una malattia da cui non guariremo mai), così pure dopo ore senza dormire, sorgono in noi, ma come proiettate dall’esterno, idee magnifiche, consapevolezze nuove. Il sonno più profondo e la sua completa assenza producono gli stessi effetti: curioso paradosso: sono quasi impossibili da distinguere. Se sono sicuro di una cosa, riguardo a quella notte, è che non so, non saprò per sempre, se non mi sono mai addormentato o se non mi sono ancora svegliato. Ma un’altra sensazione mi prese, quando di scatto mi misi a sedere nel letto, una sensazione che invece non avevo provato prima, e che non so come articolare se non con una banalità: la certezza di aver sognato il sogno di qualcun altro; anzi di essere stato nel sogno di qualcun altro; di qualcos’altro.
Come sempre, quando ci svegliamo, tendiamo a localizzare le cause che ci hanno riportato alla realtà negli avvenimenti del sogno, piuttosto che in quelli del mondo reale. Il tappeto volante sul quale stavamo viaggiando si è improvvisamente ribaltato, non è stato il letto a subire una scossa; un mostro assassino avanza a passi pesanti per il corridoio, non è il vicino che ha deciso di piantare chiodi alle tre di notte; stiamo annegando in una grotta subacquea, non abbiamo avuto l’ennesimo episodio di apnea notturna. Così quella notte attribuii il movimento improvviso a… non ricordo cosa, ma qualcosa che stava succedendo da quell’altra parte.
Quando il letto si mosse di nuovo, facendo anche un po’ di rumore, proprio come se qualcuno stesse cercando di trascinarlo verso la parete opposta, in un primo momento non mi spaventai: quando sono solo posso finalmente dormire con un po’ di luce, vidi subito che nella stanza non c’era nessuno. Mi alzai di colpo, barcollando leggermente, cosa che attribuii allo spostamento brusco, e alla mia pressione bassa. Ma quando il pavimento cominciò a inclinarsi, tanto che per rimanere in piedi dovetti aggrapparmi a un cassetto semiaperto del comò, cominciai a sospettare che qualcosa non andava. Dopo qualche secondo, la casa si fermò. Solo il lampadario che oscillava leggermente era lì a testimoniare che non mi ero sognato tutto – a meno che non mi stessi sognando anche quello. Vediamo stavolta che si è inventata questa, dissi tra me e me, più arrabbiato che impaurito, e mi diressi verso la porta a grandi falcate, aspettandomi di trovare, non so, i ratti che brucavano in cucina, la libreria del salotto marcia di acqua e salsedine, una pianta carnivora fiorita sull’attaccapanni di ottone, il solito cinema. Ma la porta non si aprì. La maniglia si girava ma la porta non ne voleva sapere di muoversi, neanche quando iniziai a scuotere e tirare e spingere e provarle tutte, facendo un casino terribile che fu seguito da una reazione altrettanto furibonda: le pareti ripresero a scricchiolare, il letto a sussultare, i cassetti del comò ad aprirsi e chiudersi, il lampadario a fare il pendolo.
Ora basta, dissi ad alta voce, senza neanche rendermene conto, ora basta cazzo hai ROTTO IL CAZZO, stavo urlando, ma quel che è peggio stavo urlando contro la casa, stavo parlando con l’appartamento, forse per la prima volta nella mia vita o almeno da quando lei me l’aveva consigliato, ma la reazione non fu così positiva, forse per il tono che stavo usando forse perché parlare a una cosa è obiettivamente da pazzi, e come il pazzo continuavo a urlare e a scuotere la porta fino a che strappai la maniglia dal legno. A quel punto un boato, un rombo come uno sbadiglio prodotto dal più grande essere vivente che abbia mai abitato il pianeta terra, un muggito che veniva dal profondo dal basso dal lato dall’alto da tutti e da nessun luogo, mi zittì, e zittì ogni altro suono, dentro e fuori la casa.
Allora, con la testa che viaggiava a mille e il cuore che mi batteva fin nei polpastrelli, misi insieme le cose: le crepe, gli scossoni notturni al letto, la vertigine come un mal di mare, e da ultimo la porta. Ma certo: tutti sintomi di una cosa sola, indubitabile, solida e certa, come la morte: il terremoto.
C’erano state più scosse, evidentemente, nei giorni precedenti, scosse di assestamento, no quelle sono quelle che vengono dopo, scosse preparatorie? Minacce? Avvertimenti? Maledizione la sua terminologia animista mi aveva contagiato, ma qui ero di fronte a una cosa concreta, altro che fumisterie psicologistiche, una cosa materiale e pericolosa che stava distruggendo la casa e le nostre vite, me lo ricordavo (dai tanti terremoti vissuti e letti, prima che il palazzo crolli, la sua struttura inizia a cedere, a volte si sgretola un po’ alla volta e se ne viene a pezzi, altre volte in maniera globale, intima, invisibile: è come se tutti i muri, e solo i muri si rimpicciolissero, un po’ come quelle vecchine cui l’osteoporosi accorcia le ossa, e che a un certo punto della vita iniziano a decrescere, come ti sei fatto alto diceva mia madre, mamma ormai ho smesso di crescere da un bel po’, ok che sono sempre il tuo bambino ma ho quarant’anni, i muri collassano ma tutto il resto no, per esempio le parti di legno, i mobili le porte, così la casa sembra più piccola o l’arredamento più grande, ma è solo un attimo prima che esploda tutto, prima che tutto si polverizzi, e però quando te ne redi contro è troppo tardi, perché appunto la cornice della porta è diventata più piccola della porta stessa, e se quella è chiusa non si apre più resta incastrata) c’è un’altra strada, pensai con una lucidità di cui non mi credevo capace, la portafinestra che dà sul balconcino, uscendo mi venne anche in mente di saltare giù siamo solo al primo piano ma poi pensai che c’era un modo migliore per farmi male senza morire, l’altra portafinestra quella del tinello, l’altro orifizio sul retro, quante volte i bambini avevano giocato a rincorrersi in cerchio, scavalcai i cumuli di immondizia regolarmente differenziata che nessuno buttava mai e tirai un pugno nella finestra, con una forza di cui non mi credevo eccetera, non ho mai capito perché nei film si usa avvolgere un oggetto contundente in una coperta, se il colpo è ben assestato il vetro si rompe e cade dall’altra parte in mille pezzi aguzzi e acuminati, ma che ormai non possono farti più male, devi solo stare attento a ritirare la mano con lentezza, aprii il nottolino dall’interno, mi precipitai all’uscio di casa e con la mano insanguinata tremante più di quanto tremava la casa tolsi il blocco, quella porta per fortuna non era incastrata e si aprì, cigolando solo un poco, ma la cosa peggiore di tutte fu quello che vidi dopo. Gli altri appartamenti a cominciare da quello a fianco, che dà sullo stesso ballatoio, erano completamente immo
Perfetto, la ringrazio. Può pagare come sempre a Yörg, il mio segretario che l’aspetta fuori, disse la dottoressa Re.
Ma come, io
Me lo finisce di raccontare al prossimo incontro, la sua ora è finita.