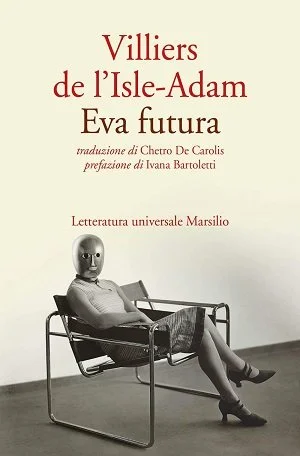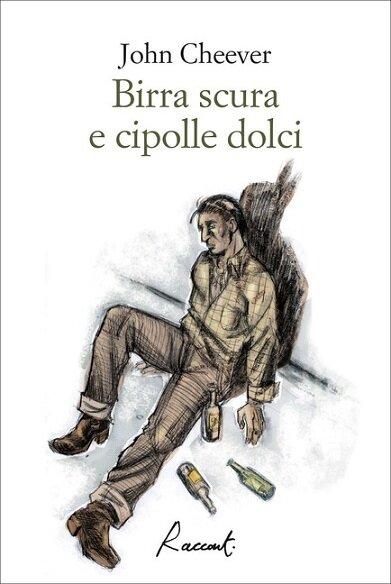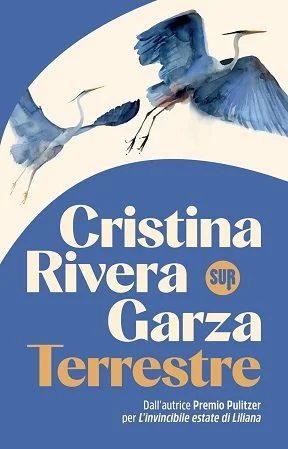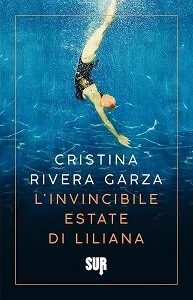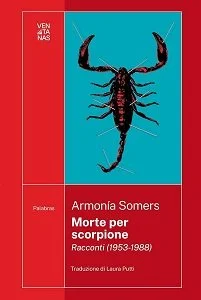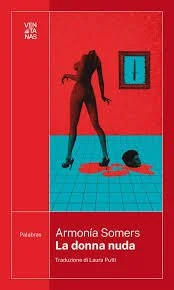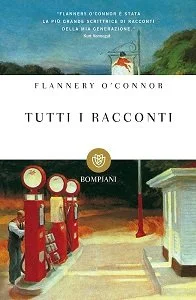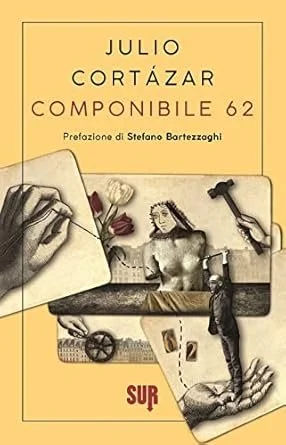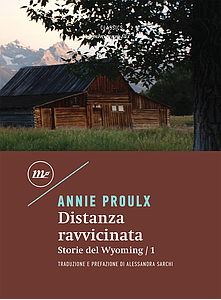di Giuseppe Zucco
Dei Racconti crudeli di Villiers si erano da tempo perse le tracce. L'ultima traduzione risaliva a più di trent'anni fa ed era difficile reperirla. Io stesso mi sono avventurato nelle librerie di seconda mano o nei mercatini dell'usato senza riuscire a trovarne copia. Solo una volta ho avuto fortuna, mettendo le mani su uno smilzo volumetto color carta da zucchero della Biblioteca di Babele, la celebre collana di letteratura fantastica diretta da Borges e pubblicata da Franco Maria Ricci, che compendiava alcune storie di Villiers, la metà riconducibili proprio ai Racconti crudeli.
Scrivo tutto ciò perché il mio corpo, delle librerie di seconda mano e dei mercatini dell'usato, ne farebbe volentieri a meno. Al contatto con la polvere, gli occhi mi si arrossiscono, le dita mi prudono, un caldo formicolio mi sale sulla nuca e dietro le orecchie. In questi casi, mi si pone sempre lo stesso dilemma. Cosa stai cercando su questa terra, la Salute o la Salvezza? Io non ho mai dubitato che i libri potessero salvarmi da me stesso e dal mondo, così, quando cerco un libro necessario, che cascasse il cielo devo leggere ad ogni costo, ricaccio sotto la soglia dell'attenzione sintomi e presagi di malattia, pregando intanto il dio dei racconti di proteggermi dalle forme più feroci dell'allergia. Alle brutte, antistaminico.
Certo, direte voi, se è così, perché non comprare quel libro su uno store online? Non sarebbe stato tutto più pulito, asettico, fuori portata da sciami di acari maligni, due click, una transazione digitale e via? Sicuramente, avrei risposto. Solo che avrei perso quella scarica elettrica che ti percorre dalla testa ai piedi quando il libro dei tuoi sogni si avvera tra un mucchio di volumi rovesciati su un banchetto. Una sensazione pari al colpo di fulmine in amore. E chi sono io per rinunciare alla Salvezza e al Fulmine, ma in una volta sola, aureolandomi all'istante di luce viva?
Capirete però la felicità quando ho saputo che Racconti crudeli sarebbe tornato in libreria grazie a Carbonio Editore con la cura – preziosa nella traduzione, ricca nell'introduzione - di Bruno Nacci. Perché sì, va bene la Salvezza, va bene il Fulmine, ma questa volta non avrei starnutito a ripetizione, né le lacrime, colandomi copiose dagli occhi rossi, mi avrebbero assegnato quell'aria afflitta da eroina romantica. Mi rendo conto solo ora che tutte le volte in cui un libraio mi ha visto acquistare un libro usato allo stesso modo mi ha visto piangere. Ed è così, in questo modo ridicolo e involontario, che si costruisce la nostra reputazione vagando per il mondo.
Comunque sia, una volta preso il libro, mi sono fiondato a leggerlo. Ho letto un paio di racconti ogni mattina, sul trenino che mi porta a lavoro, mentre rovi, prati e campi da tennis scorrono fuori dai finestrini macchiati dall'usura e dai graffiti. L'andatura calma e scricchiolante del trenino si è subito accordata al ritmo del libro. Ogni volta è stato come salire a bordo di una carrozza a cavalli e attraversare Parigi, proprio come capitò a Villiers, che di Parigi ebbe un'esperienza quadrimensionale, avendo contezza dei gradini di marmo che portavano alle sale più lussuose e dei vialetti fangosi che scivolavano verso le più infime bettole.
Villiers fu un aristocratico decaduto che rasentò la miseria nel cuore dell'Ottocento. Sulla sua vita e su quella dei suoi cari circolano storie così penose da rasentare l'allegria, poiché più che dal pessimismo della ragione sembrano guidate dall'ottimismo della volontà, il quale è una strana forma di immaginazione o di monomania.
Suo padre, per esempio, il marchese Joseph-Toussaint, dilapidò buona parte delle risorse familiari cercando il tesoro perduto dei Cavalieri di Malta. Fiumi di denari sgorgarono dalle sue tasche per terreni da cui non cavò neanche una moneta d'oro, tanto da doverli poi rivendere a prezzi stracciati. Villiers, invece, come lo chiamavano i suoi amici, il cui nome completo fu Auguste de Villiers de l'Isle-Adam (lo sentite anche voi il suono di questo nome così lungo e ricercato che sembra strascicare dietro le spalle di chi lo porta come un pregiato mantello ormai logoro e sfilacciato ai bordi?), per ripianare i debiti puntò una ricca ereditiera inglese. Lei promise di sposarlo, lui forse se ne innamorò. In seguito, lei lo respinse. Per vendicarsi, Villiers scrisse Eva futura, uno dei primi romanzi di fantascienza, prestando i tratti dell'amata a una donna tanto abbagliante nell'aspetto quanto non proprio intelligente.
In verità, ci sarebbero un'infinità di storie divertenti racchiuse dentro la piccola vita che la sorte gli assegnò. Quando il trono di Grecia risultò vacante, per oscure ragioni genealogiche, lo pretese a sé. Per mettere insieme il pranzo con la cena, lavorò in una morgue e fu istruttore di boxe. Tra i suoi folli progetti fortunatamente mai portati a termine, ci fu quello di recitare poesie davanti a un pubblico pagante dentro una gabbia di tigri. Secondo quanto affermò Léon Bloy, scrisse Eva futura sdraiato sulle assi del pavimento perché gli pignorarono tutti i mobili della stanzetta in cui viveva.
Da ragazzo fu rinchiuso in un'abbazia quando la sua famiglia si oppose alla relazione che aveva stretto con una donna troppo chiacchierata. Un volta dichiarò che avrebbe voluto un pugnale per uccidere il tempo. In punto di morte, dopo aver corso tutto la vita dietro a donne altezzose di splendido rango, tra cui la figlia di Gautier, sposò la domestica, una donna quasi analfabeta, così da riconoscere nel testamento il figlio avuto da lei. Consumato da un cancro allo stomaco, fu sepolto al Père-Lachaise sotto una lastra di granito su cui uno scalpellino ricamò il suo nome e lo stemma araldico. Uno stormo di sostenitori si affollò intorno all'idea di costruire un monumento funebre alla sua memoria. I lavori furono affidati allo scultore Frédéric Brou. Brou disegnò il progetto in marmo di una donna nuda che apriva la bara di Villiers come una lattina, così da tirarlo fuori da quella trappola e assicurargli gloria imperitura. Il progetto fu presentato al Salone di Parigi del 1907. Come tutte le buone intenzioni, anche questa cadde e non se ne fece nulla.
Se sentite l'ala del ridicolo sfiorarvi la testa, non biasimate più di tanto Villiers. In fondo, chi di noi può dirsi immune dal morbo del ridicolo? E non è il senso del ridicolo ad affratellarci tutti? Non è il ridicolo a renderci tutti uguali?
Villiers, è vero, per molti aspetti, potrebbe apparire un campione del ridicolo. La sua biografia parla per lui. Ma ci fu qualcosa che lo riscattò. Mallarmè, che vegliò sui suoi ultimi respiri, in un'ode funebre definì Racconti crudeli «il più miracoloso dei libri d'ore», e il suo autore un'apparizione sconvolgente. Verlaine lo considerava un «poète absolu» e inserì il suo nome nell'antologia I poeti maledetti. Baudelaire lo riteneva secondo solo a Poe. Renard diceva che le sue frasi facevano «l'effetto di un colpo di fucile sparato in testa». Maeterlinck sosteneva che c'era «un prima e un dopo Villiers. Da un lato l'ombra, dall'altro la luce». Huysmans ne celebrò la figura, trasferendo i suoi tratti al protagonista del romanzo À rebours, che in seguito divenne la bibbia del decadentismo. Breton non perse tempo a infilare il suo nome tra l'eletta schiera di Swift, Kafka, de Sade e via cantando nell'Antologia dell'humor nero.
In breve, fu la scrittura a riscattarlo. E a maggior ragione, furono i Racconti crudeli a farlo passare alla storia, i quali, andando per le spicce, contengono una lingua che lascia pensare a un Flaubert in acido, e un'ironia a tratti macabra che risplende nell'oscurità come i denti dello Stregatto, e un'immaginazione che convoca, prefigurandone l'avvento, Borges, Schwob, Lovecraft, Freud e i surrealisti.
I Racconti crudeli furono scritti nel corso di quasi vent'anni, tra il 1867 e il 1883, apparendo di tanto in tanto su periodici vari, anche di pessima fama. Quando Villiers li raccolse in volume e li propose a Calmann-Lévy, suo futuro editore, questi in prima battuta li rifiutò, poiché, scrisse, «i brani di questo manoscritto più che novelle sono articoli di genere, o saggi di psicologia e di fantasie letterarie».
Ecco, questa affermazione - che presa di per sé rivela la stanca miopia degli editori e un involontario acume critico - non ha nulla di vero, eppure ha qualcosa di vero, e già questo dimostra la felice contraddizione che li anima. Poiché i Racconti crudeli sono racconti in purezza. Bastano certi vertiginosi attacchi per lanciare una malia sugli ignari lettori e tenerli avvinti fino all'ultima riga. Una volta dentro, non c'è modo di sottrarsi al potere di affabulazione di Villiers, anche e soprattutto quando la tentazione di darsela a gambe levate è fortissima, visti gli abissi della realtà e i crepacci del cuore umano che si spalancano sotto i nostri occhi. Ma allo stesso modo questi racconti sono degli spaccati di vita, degli studi dal vero di costumi e di maniere, degli stranissimi e allucinati reportage del mondo nuovo che si disegna sotto l'implacabile avanzata di una nuova classe sociale, la borghesia.
Bisogna sempre ricordare che Villiers fu un aristocratico decaduto, un tradizionalista convinto, un conservatore militante, e la profonda nostalgia per un mondo di sfarzi e agi ormai perduto, legata all'odio per i nuovi padroni del mondo, più che ottundergli i sensi, glieli acuì, permettendogli di cogliere non solo gli ideali che si agiteranno da allora in poi nel corpo delle masse come demoni meschini (il culto del denaro, l'utile elevato a religione, lo spregio di ogni sentimento che non comporti rendita o posizionamento sociale, la paura dei meno abbienti, la morale sempre doppia, la glorificazione della mediocrità, la legge intesa come elegante paravento dietro cui scatenare una ferocia primordiale), ma anche i primi germi di quella società dello spettacolo totale in cui tutti noi siamo immersi fino al collo. Provate a leggere racconti come I briganti, Il desiderio di essere un uomo, Il convitato delle ultime feste, Virginia e Paolo, Due indovini, e più di un brivido vi correrà per la schiena.
Ma Villiers non è Stendhal. Se Stendhal pensava la letteratura come uno specchio che riflette fedelmente la realtà, Villiers, sull'onda della lezione di Poe, sa che lo specchio non è strumento neutro, perché questo può essere concavo, convesso, rotto, incrinato, appannato, deformante. E allo stesso modo sa che la realtà non può esaurirsi nel gelido riflesso del realismo, poiché la realtà è misteriosa, la realtà è oscura, la realtà è molteplice, la realtà è in parte sfuggente e invisibile, la realtà è la compresenza di tutti i tempi, la realtà è un incubo da cui non ci si può svegliare.
Così, stretto tra le mani di Villiers, lo specchio incrinato della letteratura, oltre a riflettere qualcosa, diventa un portale di accesso all'incubo della realtà. E leggendo Racconti crudeli, tutti noi diventiamo come Alice. Prima ci riflettiamo nello Specchio, poi lo attraversiamo. E una volta di là, dall'altra parte, lì dove la Vita fonda il Sogno e viceversa, mettendo i piedi sopra una terra ghiacciata e sotto un cielo dai colori fluorescenti, non potremo fare altro che correre, correre, correre, mentre ci inseguono vecchi boia, eleganti assassini, conti crudeli, gentili dame interessate a tagliarci la testa. Dai quali, va detto, è inutile scappare. Perché prima o poi ci fermeranno. E non ci uccideranno, no. Ci porgeranno una tenera carezza. E non sarà quello l'Orrore degli Orrori? Accorgersi in un istante che quella figure allucinate, oltre a somigliarci pazzamente, contengono nella scatola più riposta del petto un carillon che suona il dolce motivetto dei nostri più cupi desideri? Ah, Villiers! Ah, il pozzo scuro del cuore umano! Ah, questa macabra risata che non finisce di risuonare nelle nostre orecchie!