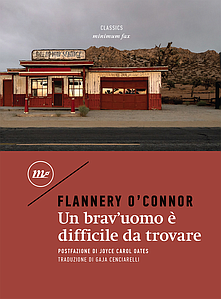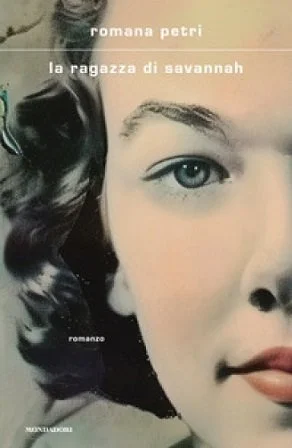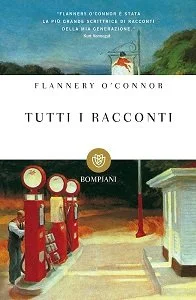di Debora Lambruschini
Il 25 marzo scorso Flannery O’Connor avrebbe compiuto cento anni. Il suo primo libro, Wise Blood, (La saggezza del sangue) venne pubblicato per la prima volta nel 1952: un romanzo, certo, ma nato a partire da quattro racconti apparsi in precedenza su rivista, su cui lo sguardo dell’autrice si è fatto più ampio. E oltre settant’anni dopo le parole di Flannery ancora incendiano la pagina. Il suo passaggio sulla terra è stato piuttosto breve: morì a trentanove anni a seguito di complicazioni dovute alla malattia incurabile di cui soffriva, il lupus; i racconti – trentuno, quelli di cui finora siamo a conoscenza – , i romanzi, le lettere, le sopravvivranno a lungo, continuando a incatenare i lettori del tutto spiazzati da quell’ironia feroce che attraversa le pagine.
Di cosa è fatto il mistero della sua scrittura? Ripercorro le sue opere, i racconti, i romanzi, i preziosi saggi, le biografie, nel tentativo di indagarne il mistero, consapevole che ne scalfirò solo la superficie. A guidarmi, in questo viaggio «nel territorio del diavolo», ci sono le parole di Flannery ma anche di chi le ha sapute interpretare – Gaja Cenciarelli, la sua perfetta voce italiana – e di chi ne ha perlustrato l’esistenza terrena e i testi – Romana Petri, nel bellissimo romanzo da poco pubblicato, La ragazza di Savannah. E dunque parto dalle parole, dal modo peculiare di Flannery di intendere il racconto:
La narrativa opera tramite i sensi, e uno dei motivi per cui, secondo me, scrivere racconti risulta così arduo è che si tende a dimenticare quanto tempo e pazienza ci vogliono per convincere tramite i sensi. Se non gli viene dato modo di vivere la storia, di toccarla con mano, il lettore non crederà a niente di quello che il narratore si limita a riferirgli. La caratteristica principale, e più evidente, della narrativa è quella di affrontare la realtà tramite ciò che si può vedere, sentire, odorare, gustare e toccare. È questa una cosa che non si può imparare solo con la testa; va appresa come un’abitudine, come un modo abituale di guardare le cose. (“Scrivere racconti”, Un ragionevole uso dell’irragionevole, p. 72)
I sensi sono all’erta, viviamo ogni storia in cui ci addentriamo con un’intensità tale che non si esaurisce certo nello spazio breve della narrazione. Di recente ho selezionato per uno dei miei gruppi di lettura la raccolta Un brav’uomo è difficile da trovare: per molti era il primo contatto diretto con la scrittura di Flannery O’Connor e l’opinione comune è stata la necessità di centellinare le storie, per l’impatto notevole che ognuna provocava. Viviamo, dunque, le storie di Flannery, non per quell’orrido principio di immedesimazione che sta contaminando questi nostri tempi, ma per come ogni cosa che l’autrice mette sulla pagina coinvolge tutti i sensi, mentre persegue la verità di quello che racconta.
Io per arte intendo semplicemente scrivere qualcosa che sia dotato in sé di valore e di efficacia. Base dell’arte è la verità, nella sostanza come nella forma. Chi nella propria opera persegue l’arte, persegue la verità, in senso immaginativo, né più né meno. (“Natura e scopo della narrativa”, Un ragionevole uso dell’irragionevole, p. 51)
Le storie di Flannery ci turbano per la brutalità che le attraversa, certo, ma anche perché rincorre una verità tanto di sostanza quanto di forma che mette il lettore di fronte all’ambivalenza del mondo: la grazia che si intreccia al grottesco, la fede, la violenza, l’ironia feroce, il realismo, il divino, una commistione di comicità e orrore. Lo fa con una voce che aderisce e crea il reale, i dialoghi vivi, i dettagli che danno forma ai personaggi e agli ambienti, muovendosi su registri stilistici diversi, rifuggendo le etichette, prima fra tutte quella problematica di “scrittrice del Sud”. Quella di Flannery è una scrittura che non teme di sporcarsi, fatta di carne e sangue, indifferente a compiacere il lettore, la critica, i benpensanti, solo a raccontare la verità che le si presenta davanti.
La narrativa riguarda tutto ciò che è umano e noi siamo fatti di polvere, dunque se disdegnate di impolverarvi, non dovreste tentare di scrivere narrativa. Non è cosa abbastanza nobile per voi. (“Natura e scopo della narrativa”, Un ragionevole uso dell’irragionevole, p. 54)
Di certo Flannery non ha mai avuto timore di impolverarsi con le faccende umane. Mi sono chiesta spesso se il suo rifiuto di ripulire le storie a una forma che l’opinione pubblica del tempo avrebbe trovato meno scandalosa avesse a che fare con la necessità di non perdere tempo dietro a questioni inutili, per una scrittrice che di tempo, ha saputo presto, ne avrebbe avuto poco. Difficile addentrarsi nelle storie di O’Connor senza pensare alla persona dietro l’autrice, alla malattia, alle perdite, alle rinunce, al tempo che si restringeva con una velocità allarmante.
Qualche mese fa Mondadori ha portato in libreria un testo particolarmente interessante, cui accennavo in apertura, a cui apponiamo per comodità l’etichetta di romanzo: La ragazza di Savannah, di Romana Petri, è un testo prezioso, accuratissimo, in cui l’invenzione letteraria e la forma romanzesca si fondano su solide ricerche bibliografiche, sui testi di Flannery che qui prendono vita, sulle numerose lettere che ci ha lasciato, sugli studi critici che negli anni si sono susseguiti. È anche dalla lettura di questo volume che ho avuto conferma della sensazione che sempre mi ha accompagnata tra le pagine di Flannery: una scrittura minuziosa, cesellata e allo stesso tempo urgente, a cui si è tenuta tenacemente aggrappata da quando ha iniziato ancora bambina fino all’ultimo istante.
Non scriveva ancora molto, ma le era ben chiaro che cosa volesse scrivere: il suo mondo del Sud, la sua violenza, le anomalie, la mostruosità, le cose che succedono quando si perde l’unica strada da percorrere. Non si poneva il problema se i lettori avrebbero capito le sue vere intenzioni. (La ragazza di Savannah, p. 60)
E scrive, principalmente, dalla fattoria in cui vive con la madre, Regina, dove ha trascorso la maggior parte della sua vita. Da Savannah si è allontanata poco e per periodi sempre più brevi, tutto il suo mondo pare ridursi a quella casa, alle cure materne, ai polli e ai pavoni che la ossessionano fin da piccola. A differenza di Emily Dickinson, per Flannery quel confinamento non è volontario, ma dettato dalla malattia sempre più invalidante a cui solo dopo qualche anno viene dato un nome: il lupus. La stessa malattia di cui soffriva suo padre, morto quando Flannery era ancora molto giovane e che pareva assurdo si ripresentasse nella stessa famiglia, con tanta ferocia. I medici inizialmente escludono che si possa trattare di lupus, ma quando la diagnosi arriva non c’è tempo per abbandonarsi al dolore: la scrittura è già iniziata e se il tempo terreno che le è concesso sarà così limitato non è possibile concedersi distrazione, compatimento, autocommiserazione. C’è spazio solo per la scrittura, che mira sempre alla perfezione, a qualsiasi costo e in qualsiasi condizione. Per qualche breve incursione nel mondo, che presto si accorge di questa scrittrice fuori dal comune e impossibile da contenere e incasellare, dal carattere difficile, scontrosa e brillante nello spazio di una stessa sera. E quando lei non avrà la forza fisica per quelle incursioni sarà il mondo a venire alla fattoria, attraverso i fittissimi scambi epistolari, le visite di amici e colleghi.
L’urgenza della scrittura, dunque, il minuzioso lavoro di cesellatura, di revisione, cui sottoponeva ogni racconto. I personaggi non conformi, gli sbandati, i problemi e i difetti fisici che popolano le sue storie e, non da ultimo, il tema della fede che le attraversa in modo peculiare. Il male, nel Novecento secolare e materialistico, necessario per arrivare alla grazia, come sottolineava Marisa Caramella nella brillante prefazione al volume Bompiani di Tutti i racconti di O’Connor, il divino a sconvolgere l’equilibrio di un mondo antropocentrico ma anche il mezzo per vedere il mistero nel quale siamo immersi.
Nei miei racconti il lettore troverà che il diavolo getta le basi necessarie affinché la grazia sia efficace. […] A garanzia del nostro senso del mistero, occorre un senso del male che veda il diavolo come uno spirito reale, spirito che va costretto a dichiararsi, e non semplicemente come un male indefinito, bensì come una personalità specifica per ogni occasione. (“Nel territorio del diavolo”, dalle lettere scritte a Winifred McCarthy, Un ragionevole uso dell’irragionevole, p. 92)
La fede che pervade ogni pagina, in modi non convenzionali perché, come sosteneva la stessa O’Connor, se scrive come scrive è perché è cattolica, non benché sia cattolica e il diavolo cammina tra quei balordi, senza redenzione né grazia. Ma la grazia è proprio lì invece, viene fuori dal male. Il Sud, ritratto nel solo modo che conosce, quella verità che da sempre va cercando; grottesco, ma solo negli occhi di chi quei luoghi non li abita, non li conosce, per lei non è altro che reale.
Gli scrittori non fanno che parlare di quel che fa “funzionare” un racconto. In virtù dell’esperienza che mi viene dal tentativo di far “funzionare” racconti, ho scoperto che quello che occorre è un’azione assolutamente inattesa, eppure assolutamente credibile, e ho riscontrato che, nel mio caso, essa indica sempre l’offerta della grazia. […] In breve, leggendo ciò che scrivo, ho constatato che l’argomento della mia narrativa è l’azione della grazia in un territorio occupato in gran parte dal diavolo. (“Nel territorio del diavolo”, dalle lettere scritte a Winifred McCarthy, Un ragionevole uso dell’irragionevole, p. 93)
Le storie di Flannery O’Connor sono dunque fatti di brutalità e grottesco, di ironia feroce e realismo, di comicità e orrore, di fede cattolica, urgenza, cura. La sua scrittura è un mistero difficile da svelare del tutto e nemmeno necessario. Possiamo solo restarne totalmente ammaliati, scossi nel profondo dalle virate improvvise delle sue storie, da un talento tanto selvaggio.