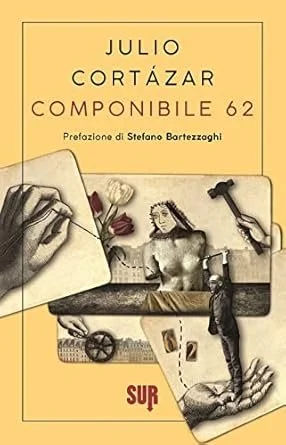di Alice Pisu
“Zötl ha ragione, non c’è bisogno di inventare animali favolosi se si è capaci di rompere il guscio dell’abitudine”.
In una sorta di lettera inviata all’editore Franco Maria Ricci divenuta l’introduzione all’edizione del 1972 del Bestiario di Aloys Zötl, Julio Cortázar riconosce la straordinaria capacità del maestro tintore dell’Austria ottocentesca di potenziare favolosamente l’alleanza dell’immaginario con il visibile e il tangibile. Quegli sfondi fantastici dalla sottile e brutale leggiadria ammaliano Cortázar e lo influenzano nel rinnovare sul piano letterario la fascinazione per una fauna sul confine tra il reale e la sua effigie, tra l’esistenza fisica e quella letteraria. Riaccendono memorie sopite, evocano nello scrittore un trauma infantile ritenuto inaugurale della privata raccolta di ricordi: un risveglio terrificante al canto del gallo all’alba a tre anni, da solo, in una camera con un finestrone.
“Dal nulla, da poppate fra gatti e giocattoli che solo gli altri potrebbero rammentare, emerge un risveglio sul far dell’alba, vedo la finestra grigia come una presenza desolante, un tema di pianto; è chiara solo la sensazione di abbandono, di qualcosa che oggi posso chiamare mortalità e che in quell’istante era sentire per la prima volta l’essere come desolata spoliazione, rettangolo grigiastro del nulla per occhi che si aprivano sul vuoto, che scivolavano all’infinito in una prospettiva senza appigli, un bambino di spalle davanti al cielo nudo. E un gallo cantò, se c’è ricordo è per questo, ma non c’era nozione di gallo, non c’era nomenclatura tranquillizzante, come sapere che era un gallo quell’orrendo frantumarsi del silenzio in mille pezzi, quel lacerarsi dello spazio che precipitava sui miei vetri stridenti, il primo e più terribile Roc”.
Che sin dall’infanzia lo scrittore, saggista, poeta, accademico e drammaturgo argentino naturalizzato francese abbia sperimentato un peculiare incanto per la prospettiva animale dell’uomo e del paesaggio è evidente dal continuo ricorso bestiale che accompagna una parte significativa della sua poetica. Leggere Cortázar significa accordarsi a un’idea di letteratura che annulla il confine tra finzione e realtà nel ritoccare la Storia e rielaborare il repertorio figurativo della mitologia antica, e che rinnova un’attitudine al fantastico, al metafisico e al mistero, utile a lambire questioni esistenziali, politiche e sociali anche attraverso l’esplorazione del sogno e dell’immaginario come dimensioni sovrapponibili.
L’esordio avviene con i sonetti pubblicati nel 1938 con lo pseudonimo di Julio Denis e con saggi di critica letteraria. Antiperonista, abbandona il suo incarico accademico e finisce per dedicarsi alla collaborazione con riviste letterarie (ottenendo la stima di Jorge Luis Borges), e all’attività di traduttore di autori come Edgar Allan Poe che influenzeranno il suo sguardo. La vita in Francia dal 1951 e la scelta di Parigi come luogo d’elezione tra innumerevoli viaggi marca una direzione nuova nella sua letteratura. Lo studio di autori francesi e l’identificazione nel Surrealismo originano la ricerca di un infra-realismo dove, come scrive Stefano Bartezzaghi nell’introduzione a Componibile 62 (trad. Flaviarosa Nicoletti Rossini per Sur), “la vita evidente e la vita segreta, il significato ordinario e il significato idiosincratico, il senso comune e l’assurdo associativo continuano a scambiarsi di posto”. Il riconoscimento della sua grandezza letteraria arriva con l’uscita de Il viaggio premio nel 1960 e tre anni dopo con il suo capolavoro Rayuela, che gli permette di ottenere in seguito particolare attenzione anche per le sue opere miscellanee e per le raccolte di racconti. Da alcune delle pagine più significative della produzione di Cortázar traspare una precisa valenza civile, come nella sua opera più politica, Libro di Manuel (uscito nel 1973 e pubblicato per la prima volta in Italia cinquant’anni dopo da Sur con la traduzione di Ilide Carmignani) dove il linguaggio è insieme divertimento, contestazione e opposizione a ogni totalitarismo. Le nuove consapevolezze definite attraverso esperienze come il viaggio a Cuba negli anni Sessanta e l’impegno politico nel denunciare abusi e diritti negati in America Latina, portano l’autore a sposare posizioni rivoluzionarie nel dedicarsi alla causa di Cuba, alla situazione del Cile di Allende e al Nicaragua sandinista. In tal senso soffermarsi sulla scrittura epistolare permette di avvicinarsi alla complessità e alla ricchezza del pensiero dello scrittore, tributate in un progetto in cinque volumi curato da Aurora Bernárdez e Carles Álvarez Garriga, edito da Alfaguara, che la casa editrice Sur ha pubblicato in Italia in tre volumi grazie alla selezione, alla cura e alla traduzione di Giulia Zavagna. Oltre alle missive politiche racchiuse in Così violentemente dolce (2015), sono rivelatrici le lettere inviate a scrittori e amici raccolte in Carta carbone (2013). La corrispondenza riveste un ruolo centrale nell’esistenza dell’autore, al punto da essere considerata un complemento indispensabile alla sua opera, “una sorta di zona franca – come la definisce Giulia Zavagna – in cui realtà e finzione si mescolano, in cui gli spunti attinti dal mondo circostante si trasformano prima in pensieri sparsi e poi in progetto, in materia narrativa” che prende forma nelle pagine inviate tra gli altri a Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Octavio Paz, Jorge Luis Borges, Osvaldo Soriano, Juan Carlos Onetti, Victoria Ocampo a Eduardo Galeano.
La musica (il jazz in particolare) ha sempre rappresentato un ulteriore mezzo di sperimentazione artistica: pur nella consapevolezza di avere scarso talento come musicista, lo scrittore riconosce in tale dimensione uno spazio creativo necessario a plasmare il suo linguaggio letterario. Significativo in tal senso l’omaggio a Charlie Parker nel racconto più celebre dell’autore, L’inseguitore, edito da Sur con le illustrazioni di José Muñoz e la nuova traduzione di Ilde Carmignani.
Nel muoversi tra il poema, il saggio, il microracconto, il romanzo e il diario, Cortázar talvolta arriva anche a riunire forme diverse in peculiari zibaldoni surrealisti come Ultimo round o Il giro del mondo in ottanta mondi (tradotti entrambi da Eleonora Mogavero per Sur), per portare alla luce molte delle poesie scritte nei decenni precedenti e affrontare, secondo schemi liberi, luoghi amati come il mito, la boxe, l’arte figurativa, l’erotismo, i misteri racchiusi nei crimini, la letteratura francese, il ‘68 in Francia, la Rivoluzione cubana, il fascino delle possibilità di cambi di rotta celati nel ricordo di un libro.
Tutto si apre e si chiude con la poesia in Cortázar, evidenza riconosciuta dalle sperimentazioni giovanili sino all’urgenza, sul finire dell’esistenza, di dedicare gli ultimi sforzi a radunare in Salvo il crepuscolo una selezione di poesie intervallate da prose “perché risulti un po’ più divertente”, come confessa in una lettera a Gregory Rabassa. In Italia l’opera vede la luce per la prima volta a distanza di quarant’anni dalla sua prima uscita con la cura e la traduzione di Marco Cassini per Sur.
Tale circolarità traspare anche nel riconoscimento di una genesi comune per la scrittura del romanzo e della poesia, rintracciata in un repentino estraniamento: sono fondamentali la tensione, il ritmo, la pulsazione interna, l’imprevisto in parametri predefiniti, “quella libertà fatale che non ammette alterazione senza una perdita irreparabile”.
Trovare oggi in un solo volume (Animalia, trad. Ilde Carmignani, Sur) alcuni dei racconti più evocativi di Cortázar grazie all’accurata selezione operata su nove libri dall’erede letteraria e prima moglie Aurora Bernárdez, permette di addentrarsi in un personale bestiario lieve e tempestoso, drammatico e profondamente ironico al contempo, e riconoscere un compendio delle fondamentali istanze letterarie sollevate negli anni da uno degli scrittori più influenti del panorama letterario. Pagine intense che nell’attestare le infinite possibilità della lingua e la ricchezza dei giochi di ingranaggi che racchiude – definiti nell’emblematico confine tra causalità e casualità, “tra la legge e il libero gioco delle cose”– restituiscono la fascinazione per creature animali reali e fantastiche e rivelano aspetti centrali dello studio letterario sull’umano. Tra le pieghe di contraddizioni perenni prendono forma paure ineludibili, questioni esistenziali decisive per dare un senso al vivere, trappole mentali, visioni sulle relazioni affettive, inconoscibilità reciproca, sulla base di uno stupore rinnovato per le trasformazioni che investono ogni cosa, nella presa d’atto dell’impossibilità umana di tracciarne la direzione.
“Senza troppa immodestia ho apportato qui e là qualche ritocco alla visione naturalistica delle cose, aiutato da una specie di sospensione permanente dell’incredulità, condizione non sempre favorevole nella città dell’uomo ma che da bambino mi ha aperto le pagine di un bestiario in cui tutto era possibile [...]”.
Così, di fronte a un axolotl osservato ogni giorno al Jardin des Plantes di Parigi, può accadere di vivere un’identificazione tale da sentirsi quella forma larvale munita di branchie, riconoscere in quelle facce azteche, inespressive e crudeli, una metamorfosi che definisce una sorta di umanità. La condizione di prigionia fisica con la condanna al silenzio abissale è riconosciuta da chi osserva, che sente di essere trasmigrato nel frattempo col pensiero in quell’organismo. Può capitare di imbattersi in un orso nato da una palla di catrame o in uno che abita nelle condutture idrauliche e sbuca con una zampa dal rubinetto; incontrare conigli vomitati da un uomo che custodiscono una forma di coscienza rivelatrice; riconoscere una diffidente alterigia nello sguardo di un casuario; percepire lo sconforto di un cammello rifiutato alla frontiera e rispedito alla sua oasi; misurare grazie a un gatto la fragilità e la mutevolezza di una relazione amorosa; imparare la libertà e l’indipendenza da formiche che decidono di ridursi l’orario di lavoro per abbandonarsi al piacere di esplorare un quadro popolandolo provvisoriamente; allinearsi alla visione di cronopios che riconoscono nelle tartarughe l’ammirazione per la velocità e disegnano rondini sui loro carapaci; interrogarsi sulle sorti di coccodrilli inesistenti, minacciati di sterminio in Alvernia.
Tra le grandi incognite dei racconti di Animalia la possibilità di avvicinarsi il più possibile a sé stessi a partire da una distanza oggettiva. Questioni esplorate narrativamente da Cortázar in senso più ampio nello studio della forma breve, nella convinzione che a definire un grande racconto sia la sua autarchia.
Come sostiene Neruda – “Le mie creature nascono da un lungo rifiuto”– il processo di scrittura richiede il distacco da quelle che lo scrittore argentino definisce presenze invadenti, proiettandole in una condizione che attribuisce una collocazione universale attraverso una polarizzazione, una separazione liberatoria. Nel definirsi un veterano nel non falsificare il mistero e tenerlo vicino alla fonte con “il suo tremore originale, la sua balbuzie archetipica”, in Ultimo round, Cortázar si sofferma in particolare sulle caratteristiche del racconto fantastico, definendolo un’allucinazione, un incubo, neutralizzato mediante “l’oggettivazione e il trasferimento a un ambiente esterno rispetto al terreno nevrotico”. Tra i criteri indicati l’esigenza di uno sviluppo temporale ordinario, perché “solo l’alterazione momentanea all’interno della regolarità rivela il fantastico, ma è necessario che l’eccezionale diventi anch’esso regola senza soppiantare le strutture ordinarie fra le quali si è inserito”. In quella peculiare realtà dell’insolito bisogna guardarsi dal rischio di ricadere nell’assurdo, perché la coerenza interna funziona con il medesimo rigore di quella del quotidiano, e “qualsiasi trasgressione alla sua struttura lo fa precipitare nella banalità e nella stravaganza”.
Ogni nuovo progetto editoriale che rinnova attenzione all’opera di Julio Cortázar è un’occasione preziosa per celebrare la poetica di uno scrittore capace di infrangere convenzioni, strutture codificate, tradizionali concezioni temporali e spaziali. Come mostra anche la pubblicazione di Animalia, leggere Cortázar richiede di addentrarsi anzitutto in un’inesausta ricerca linguistica, perdersi tra giochi di parole ricorrenti che travalicano la mera adesione alla realtà, immagini incongrue in bilico tra l’infanzia e la morte, la sottile malinconia, l’umorismo dell’insignificanza. Impone anche di confrontarsi con enigmi tesi grazie all’attenzione estrema riservata alla parola, alla complessità dei suoi sensi letterali, alla versatilità della lingua, alle sue forme inventate (che aprono scenari innescati da improbabili tipi umani e specie animali) e alle sue continue evoluzioni in relazione ai cambiamenti storici e sociali, agli equivoci da cui si biforcano nuove possibilità, e alla necessità primaria di celebrare la scrittura non come strumento per accordarsi alla verità ma per perpetuare una ricerca linguistica e espressiva volta a una decifrazione impossibile. In questo senso è emblematica la dichiarazione di poetica che riluce tra le pagine di Componibile 62.
“Ma in fondo so che tutto è falso, che sono ormai lontano da ciò che mi è appena capitato e che come tante altre volte si risolve in questo inutile desiderio di capire, non badando forse al richiamo o al segno oscuro della cosa medesima, all’inquietudine in cui mi lascia, all’istantanea dimostrazione di un ordine diverso in cui irrompono ricordi, potenze e segnali tesi a formare una folgorante unità che si scompone proprio nell’istante in cui mi abbatte e mi strappa da me stesso. Adesso tutto questo non mi ha lasciato che curiosità, l’antico topos umano: decifrare”.