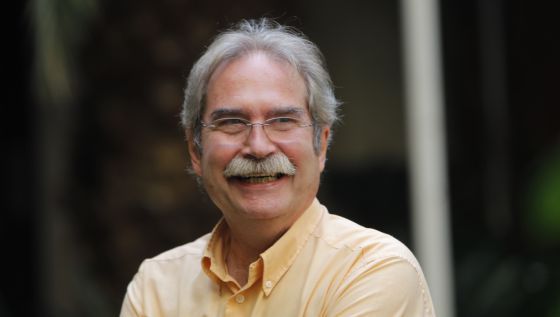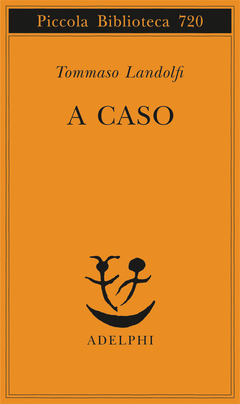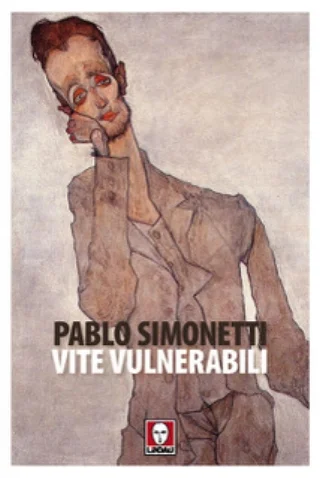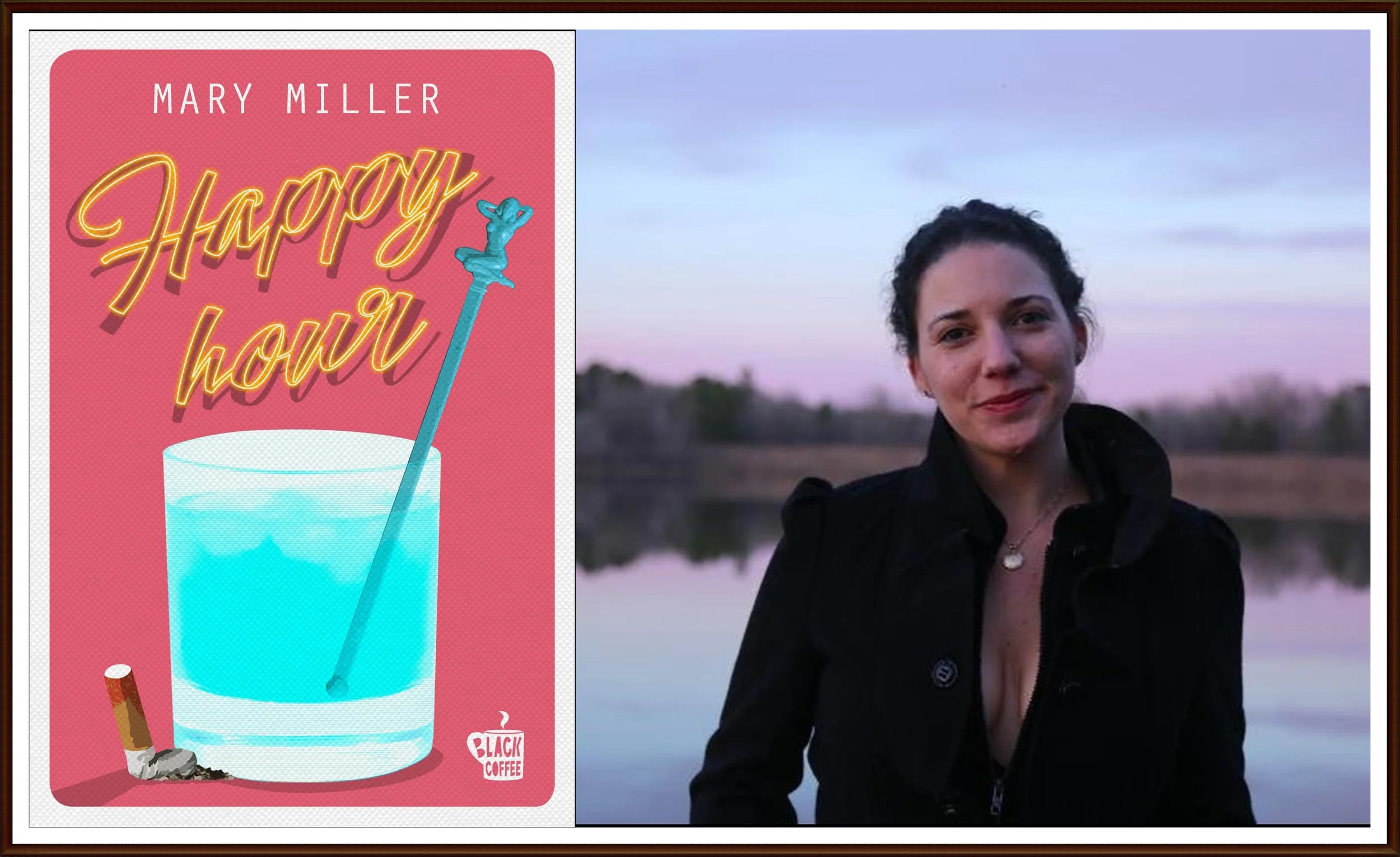Dal 6 Settembre 2019 è in libreria Disincontri, la raccolta di racconti che Cortázar ha pubblicato nel 1982. Pubblicati per la prima volta da Sur in un volume a sé e nella nuova traduzione di Ilide Carmignani, sono chiavi per porte che non si aprono, puntuali come un contrattempo, familiari e spiazzanti come un déjà-vu. Che lo si legga da sempre o per la prima volta, l’incontro con Cortázar è sempre un «disincontro».
Cattedrale vi propone il racconto che dà il titolo alla raccolta, per gentile concessione dell’editore.
DISINCONTRI
Non avevo più alcuna ragione particolare per ricordarmi di tutte quelle cose, e anche se in certi periodi mi piaceva scrivere e c’erano amici che apprezzavano i miei versi e i miei racconti, a volte mi veniva da domandarmi se quei ricordi d’infanzia meritassero di essere scritti, se non nascessero da un’ingenua tendenza a credere che le cose erano state più vere quando le mettevo in parole per fissarle a modo mio, per averle lì come le cravatte nell’armadio o il corpo di Felisa la notte, qualcosa che non si sarebbe potuto rivivere ma che diveniva più presente come se nel semplice ricordo si aprisse una terza dimensione, una quasi sempre amara ma anelata contiguità. Non ho mai capito bene perché, ma tornavo e ritornavo su cose che altri avevano imparato a dimenticare per non trascinarsi nella vita con tutto quel tempo sulle spalle. Ero sicuro che fra i miei amici ce ne fossero pochi che ricordavano i loro compagni d’infanzia come io ricordavo Doro, anche se quando scrivevo di Doro non era quasi mai lui a muovermi a scrivere ma qualcos’altro, qualcosa in cui Doro era soltanto il pretesto per l’immagine di sua sorella maggiore, l’immagine di Sara a quell’epoca, quando io e Doro giocavamo nel cortile o disegnavamo nel salotto della casa di Doro. Eravamo stati così inseparabili ai tempi delle medie, dei dodici o tredici anni, che non ero capace di percepire separatamente me stesso che scrivevo di Doro, di accettarmi fuori dalla pagina a scrivere di Doro. Vederlo significava contemporaneamente vedermi come Aníbal con Doro, e non sarei riuscito a ricordarmi nulla di Doro se al tempo stesso non avessi sentito che anche Aníbal era lì in quel momento, che era stato Aníbal a tirare la pallonata che un pomeriggio d’estate aveva rotto un vetro della casa di Doro, lo spavento e la voglia di nascondersi o di negare, l’arrivo di Sara che li chiamava mascalzoni e li spediva a giocare nel prato all’angolo. E con questo ecco che arrivava anche Bánfield, è chiaro, perché tutto era successo laggiù, né Doro né Aníbal si sarebbero potuti immaginare in un paese che non fosse Bánfield dove le case e i prati erano allora più grandi del mondo intero. Bánfield, con le sue strade sterrate e la stazione del Ferrocarril Sud, coi suoi campi incolti che d’estate, all’ora della siesta, brulicavano di cavallette multicolori, un paese che di notte si acquattava come impaurito intorno ai pochi lampioni sugli angoli delle vie, con qualche fischio delle guardie a cavallo e l’alone vertiginoso degli insetti che svolazzavano intorno a ogni lampione. Le case di Doro e di Aníbal così poco distanti che la strada era per loro come un corridoio in più, qualcosa che li teneva uniti di giorno e di sera, nel prato quando giocavano a calcio all’ora della siesta o sotto la luce del lampione all’angolo quando guardavano i rospi disposti in cerchio per mangiarsi gli insetti ubriachi a forza di girare intorno alla luce gialla. E l’estate, sempre, l’estate delle vacanze, la libertà dei giochi, il tempo tutto per loro, per loro, senza orari né campanelle di entrata in classe, l’odore dell’estate nell’aria calda dei pomeriggi e delle sere, sulle facce sudate dopo aver vinto o perso o litigato o corso, dopo aver riso e a volte pianto ma sempre insieme, sempre liberi, padroni del loro mondo di aquiloni e palloni e angoli di strada e marciapiedi.
Di Sara gli restavano poche immagini, ma ognuna si stagliava come una vetrata nell’ora del sole più alto, con azzurri e rossi e verdi che fendevano lo spazio fino a fargli male, a volte Aníbal vedeva soprattutto i capelli biondi che le scendevano sulle spalle come una carezza che lui avrebbe voluto sentire sul viso, a volte la pelle bianchissima perché Sara non usciva quasi mai al sole, assorbita com’era dalle faccende di casa, la madre malata e Doro che tornava ogni pomeriggio coi vestiti sporchi, le ginocchia sbucciate, le scarpe piene di fango. Non aveva mai saputo l’età di Sara all’epoca, solamente che era già una signorina, la giovane madre di suo fratello che diventava più bambino quando lei gli parlava, quando gli passava la mano sulla testa e poi lo mandava a comprare qualcosa o chiedeva a tutti e due di non gridare così tanto nel cortile. Aníbal la salutava timido, dandole la mano, e Sara gliela stringeva gentilmente, quasi senza guardarlo ma accettandolo come l’altra metà di Doro che quasi quotidianamente veniva a casa a leggere o a giocare. Alle cinque li chiamava per dargli caffellatte e biscotti, sempre sul tavolinetto del cortile o nel salotto tetro; Aníbal aveva visto solo due o tre volte la madre di Doro, dolcemente dalla sua sedia a rotelle diceva il suo ciao bambini, state attenti alle macchine, anche se c’erano così poche macchine a Bánfield e loro sorridevano sicuri di poterle schivare per strada, della loro invulnerabilità di giocatori di calcio e corridori. Doro non parlava mai di sua madre, che stava quasi sempre a letto o ascoltava la radio in salotto, casa sua erano il cortile e Sara, a volte qualche zio in visita che domandava cos’è che avevano studiato a scuola e regalava cinquanta centesimi ciascuno. E per Aníbal era sempre estate, degli inverni quasi non aveva ricordo, la sua casa diventava una prigione grigia e nebbiosa dove contavano solo i libri, la famiglia intenta nelle proprie cose e le cose piazzate al proprio posto, le galline a cui doveva badare, le malattie con lunghe diete e tè e solo a volte Doro, perché a Doro non piaceva restare tanto in una casa dove non lo lasciavano giocare come nella sua.
Fu nel corso di una bronchite di quindici giorni che Aníbal cominciò a sentire la mancanza di Sara, quando Doro veniva a trovarlo gli domandava di lei e Doro rispondeva distratto che stava bene, l’unica cosa che gli interessava era se quella settimana avrebbero potuto giocare di nuovo in strada. Aníbal avrebbe voluto saperne di più su Sara ma non aveva il coraggio di domandare molto, a Doro sarebbe sembrato stupido che si preoccupasse di qualcuno che non giocava come loro, che era così lontano da tutto quello che facevano e pensavano loro. Quando poté tornare a casa di Doro, ancora un po’ debole, Sara gli diede la mano e gli domandò come stava, non doveva giocare a pallone per evitare di stancarsi, meglio che disegnassero o leggessero in salotto; il suo tono era serio, gli parlava come parlava sempre a Doro, affettuosa ma lontana, la sorella maggiore premurosa e quasi severa. Quella sera, prima di addormentarsi, Aníbal sentì che qualcosa gli saliva agli occhi, che il cuscino diventava Sara, sentì il bisogno di abbracciarla forte e di piangere con il viso stretto a Sara, ai capelli di Sara, il desiderio che lei fosse lì e gli desse le medicine e guardasse il termometro seduta ai piedi del letto. Quando la mattina dopo venne sua madre a frizionargli il petto con della roba che sapeva di alcol e mentolo, Aníbal chiuse gli occhi e fu la mano di Sara a sollevargli la camicia da notte, ad accarezzarlo lieve, a guarirlo.
Era di nuovo estate, il cortile della casa di Doro, le vacanze con romanzi e figurine, con la collezione di francobolli e la raccolta di calciatori che s’incollavano su un album. Quel pomeriggio parlavano di pantaloni lunghi, ormai non mancava più molto a metterseli, non si poteva mica andare alle superiori coi pantaloni corti. Sara li chiamò per il caffellatte e Aníbal ebbe l’impressione che avesse ascoltato i loro discorsi e che sulla sua bocca aleggiasse l’ombra di un sorriso, forse si divertiva a sentirli parlare di quelle cose e li prendeva anche un po’ in giro. Doro gli aveva detto che adesso aveva il fidanzato, un signore grande che veniva a trovarla il sabato ma che lui non aveva ancora visto. Aníbal se lo immaginava come uno che portava i cioccolatini a Sara e parlava con lei in salotto, come il fidanzato di sua cugina Lola, in pochi giorni era guarito dalla bronchite e ormai poteva giocare di nuovo nel prato con Doro e gli altri amici. Ma la sera tutto diventava triste e al tempo stesso così bello, da solo nella sua stanza prima di addormentarsi si diceva che Sara non era lì, che non sarebbe mai entrata a fargli visita né da sano né da malato, proprio nell’ora in cui lui la sentiva così vicina, la guardava a occhi chiusi senza che la voce di Doro o le grida degli altri ragazzi si mischiassero con questa presenza di Sara sola lì per lui, accanto a lui, e il pianto ricominciava come un desiderio di abbandono, di essere Doro nelle mani di Sara, di sentire i capelli di Sara che gli sfioravano la fronte e la sua voce che gli diceva buonanotte, che Sara gli rimboccasse le lenzuola prima di andar via. Trovò il coraggio di domandare come per caso a Doro chi si occupasse di lui quando era malato, perché Doro aveva preso un’infezione intestinale e aveva passato cinque giorni a letto. Glielo domandò come fosse normale che Doro gli dicesse che lo aveva curato sua madre, pur sapendo che non poteva essere così e quindi Sara, le medicine e il resto. Doro rispose che gli faceva tutto la sorella, cambiò argomento e si mise a parlare di cinema. Aníbal però voleva saperne di più, se Sara si era occupata di lui da quando era bambino, ed era chiaro che se n’era occupata lei perché sua madre era quasi invalida da otto anni e Sara badava a tutti e due. Ma allora era lei che ti faceva il bagno quando eri piccolo? Certo, perché mi domandi queste cretinate? Così, per saperlo e basta, dev’essere talmente strano avere una sorella grande che ti fa il bagno. Non c’è niente di strano, sai. E quando ti ammalavi da piccolo era lei che si occupava di te e ti faceva tutto? Sì, è chiaro. E tu non ti vergognavi che tua sorella ti vedesse e ti facesse tutto? No, perché avrei dovuto vergognarmi, ero piccolo allora. E adesso? Be’, adesso uguale, perché dovrei vergognarmi se sono malato. Perché, è chiaro. Nell’ora in cui chiudendo gli occhi immaginava Sara che entrava di notte nella sua stanza e si avvicinava al suo letto, c’era come un desiderio che lei gli domandasse come stava, gli mettesse la mano sulla fronte e poi tirasse giù le lenzuola per guardargli la ferita al polpaccio, gli cambiasse la fasciatura chiamandolo stupido per essersi tagliato con un vetro. La sentiva che gli alzava la camicia da notte e lo guardava nudo, tastandogli il ventre per vedere se era infiammato, coprendolo di nuovo perché si addormentasse. Abbracciato al cuscino si sentiva di colpo così solo, e quando apriva gli occhi nella stanza ormai vuota di Sara era come una marea d’angoscia e di gioia perché nessuno, nessuno poteva sapere del suo amore, nemmeno Sara, nessuno poteva capire quella pena e quel desiderio di morire per Sara, di salvarla da una tigre o da un incendio e di morire per lei, e che lei lo ringraziasse o lo baciasse piangendo. E quando allungava le mani in basso e cominciava ad accarezzarsi come Doro, come tutti i ragazzi, Sara non entrava in scena, c’era la figlia del droghiere o sua cugina Yolanda, certe cose non potevano succedere con Sara che la sera veniva a prendersi cura di lui come si prendeva cura di Doro, con lei non c’era altro che quella gioia di immaginarla mentre si chinava su di lui e lo accarezzava e l’amore era quello, anche se Aníbal ormai sapeva che cosa poteva essere l’amore e se lo immaginava con Yolanda, tutto quello che una volta o l’altra lui avrebbe fatto a Yolanda o alla ragazza del droghiere.
Il giorno del fossato fu quasi alla fine dell’estate, dopo aver giocato nel prato si separarono dalla banda e su un sentiero che conoscevano soltanto loro due e che chiamavano il sentiero di Sandokan si persero nella boscaglia spinosa dove una volta avevano trovato un cane impiccato a un albero ed erano scappati dalla paura. Graffiandosi le mani si fecero strada fino al punto più fitto, affondando la faccia nei rami dei salici piangenti finché furono sul bordo del fossato dalle acque torbide dove avevano sempre sperato di pescare saraghi ma non avevano mai preso nulla. Gli piaceva sedersi sul bordo a fumare le sigarette che Doro faceva con i cartocci del granoturco, parlando dei romanzi di Salgari e progettando viaggi e cose. Quel giorno però non ebbero fortuna, ad Aníbal si incastrò una scarpa in una radice e cadde in avanti, si aggrappò a Doro e scivolarono tutti e due giù nel fossato entrandoci fino alla vita, non c’era pericolo ma fu come se ci fosse, annasparono disperati finché afferrarono i rami penduli di un salice, strisciando e imprecando si arrampicarono di nuovo in cima, col fango che gli si era infilato da tutte le parti, che gli colava dentro le camicie e i pantaloni e puzzava di marcio, di topi morti. Tornarono indietro quasi senza parlare e si intrufolarono in casa di Doro dal fondo del giardino, sperando che non ci fosse nessuno in cortile per sciacquarsi di nascosto. Sara stava stendendo il bucato vicino al pollaio e li vide arrivare, Doro come impaurito, e Aníbal dietro, morto di vergogna, che voleva morire davvero, essere mille miglia lontano da Sara nel momento in cui lei li guardava stringendo le labbra, in un silenzio che li inchiodava, ridicoli e confusi, sotto il sole del cortile. «Ci mancava solo questa», si limitò a dire Sara, rivolgendosi a Doro ma anche ad Aníbal che balbettava le prime parole di una confessione, era colpa sua, gli si era incastrata una scarpa e allora, Doro non aveva nessuna colpa, è che era tutto così sdruccioloso. «Andate subito a lavarvi», disse Sara come se non lo avesse sentito. «Toglietevi le scarpe prima di entrare, e poi sciacquate i vestiti nella pila del pollaio».
In bagno si guardarono e Doro fu il primo a ridere ma era una risata poco convinta, si spogliarono e aprirono la doccia, sotto l’acqua poterono cominciare a ridere davvero, a litigare per la saponetta, a guardarsi da capo a piedi e a farsi il solletico. Un fiume di fango scorreva via verso lo scarico diluendosi poco a poco, la saponetta cominciava a fare schiuma, si divertivano così tanto che in un primo momento non si accorsero che la porta si era aperta e Sara stava a guardarli, che si avvicinava a Doro per togliergli di mano la saponetta e strofinargliela sulla schiena ancora infangata. Aníbal non sapeva cosa fare, in piedi immobile nella vasca da bagno si mise le mani sull’inguine, poi si voltò di colpo perché Sara non lo vedesse e fu ancora peggio, di tre quarti con l’acqua che gli scorreva sul viso, cambiando lato e di nuovo di spalle, finché Sara non gli diede la saponetta con un lavati meglio le orecchie, hai il fango da tutte le parti. Quella sera non riuscì a vedere Sara come le altre sere, anche se chiudeva forte le palpebre l’unica cosa che vedeva era Doro con lui nella vasca, Sara che si avvicinava per ispezionarli da capo a piedi e poi usciva dal bagno con i vestiti sporchi sulle braccia, diretta generosamente alla pila a lavare le loro cose gridando che si sfregassero bene con i teli finché non erano perfettamente asciutti, servendo il caffellatte senza dire nulla, né arrabbiata né gentile, sistemando l’asse da stiro sotto il glicine e asciugando pian piano i pantaloni e le camicie. Come mai non era riuscito a dirle nulla alla fine, quando li aveva mandati a vestirsi, nemmeno un semplice grazie, Sara, lei è proprio buona, grazie davvero, Sara. Nemmeno quello era riuscito a dirle e Doro uguale, erano andati a vestirsi in silenzio e poi la collezione di francobolli e le figurine degli aeroplani, senza che Sara ricomparisse più, sempre impegnata a badare alla madre la sera, a preparare la cena e a volte a canticchiare un tango fra il rumore dei piatti e delle pentole, assente come adesso sotto le sue palpebre che non erano più in grado di farla apparire, di farle sapere quanto l’amava, quanta voglia aveva di morire davvero dopo averla vista che li guardava mentre erano sotto la doccia.
Dovevano essere state le ultime vacanze prima di iniziare il Colegio Nacional, senza Doro perché Doro avrebbe fatto la Escuela Normal, ma tutti e due si erano ripromessi di continuare a vedersi ogni giorno anche se sarebbero andati in scuole diverse, che importava se tanto il pomeriggio avrebbero continuato a giocare come sempre, senza sapere che invece no, che un giorno di febbraio o di marzo avrebbero giocato per l’ultima volta nel cortile della casa di Doro perché la famiglia di Aníbal si trasferiva a Buenos Aires e si sarebbero visti solo nei fine settimana, pieni di una rabbia amara per un cambiamento che non volevano accettare, per una separazione che i grandi imponevano come tante altre cose, senza preoccuparsi di loro, senza consultarli. Di colpo tutto andava avanti veloce, cambiava come loro coi primi pantaloni lunghi, quando Doro gli disse che Sara si sarebbe sposata agli inizi di marzo, lo disse come una cosa senza importanza e Aníbal non fece alcun commento, passarono giorni prima che trovasse il coraggio di chiedere a Doro se Sara avrebbe vissuto con lui anche dopo sposata, ma sei scemo, figurati se restano qui, quello ha un sacco di grana e se la porta a Buenos Aires, ha un’altra casa a Tandil e io rimarrò con la mamma e con la zia Faustina che si occuperà di lei. Quell’ultimo sabato delle vacanze vide arrivare il fidanzato sulla sua auto, lo vide vestito di blu e ciccione, con gli occhiali, che scendeva dall’auto con un vassoietto di pasticcini e un mazzo di gigli. Intanto lo stavano chiamando da dentro casa perché cominciasse a imballare le sue cose, il trasloco era lunedì e non aveva ancora fatto nulla. Sarebbe voluto andare a casa di Doro senza nemmeno sapere perché, per starsene semplicemente là, ma sua madre lo obbligò a impacchettare i libri, il mappamondo, le collezioni di insetti. Gli avevano detto che avrebbe avuto una stanza grande tutta per sé con vista sulla strada, gli avevano detto che sarebbe potuto andare a scuola a piedi. Tutto era nuovo, tutto sarebbe iniziato in un altro modo, tutto girava lentamente, e ora Sara doveva essere seduta in salotto insieme al ciccione col vestito blu, a prendere il tè coi pasticcini che lui aveva portato, così lontana dal cortile, così lontana da Doro e da lui, senza mai più chiamarli per il caffellatte sotto il glicine.
Il primo fine settimana a Buenos Aires (era vero, aveva una stanza grande tutta per sé, il quartiere era pieno di negozi, c’era un cinema a due isolati), prese il treno e tornò a Bánfield per vedere Doro. Conobbe la zia Faustina, che non gli diede nulla quando ebbero finito di giocare nel cortile, uscirono a fare un giro e Aníbal ci mise un po’ a domandargli di Sara. Be’, si erano sposati in municipio e ormai erano nella casa di Tandil per la luna di miele, Sara sarebbe tornata ogni quindici giorni a trovare sua madre. E non ti manca? Sì, ma che vuoi farci. È vero, ormai è sposata. Doro si distraeva, cominciava a cambiare argomento e Aníbal non sapeva più come farlo parlare ancora di Sara, forse chiedendogli di raccontare il matrimonio e Doro che rideva, che ne so io, sarà stato come tutti gli altri, dopo il municipio se ne sono andati in albergo e poi c’è stata la prima notte di nozze, sono andati a letto e a quel punto lui. Aníbal ascoltava e intanto guardava i cancelli e i balconi, non voleva che Doro lo vedesse in viso e Doro se ne accorgeva, scommetto che non sai cosa succede la prima notte di nozze. Non rompere le palle, certo che lo so. Lo sai ma la prima volta è diverso, me l’ha raccontato Ramírez, a lui gliel’ha detto il fratello che è avvocato e si è sposato l’anno scorso, gli ha spiegato tutto. C’era una panchina vuota nella piazza, Doro aveva comprato le sigarette e continuava a raccontare e a fumare, Aníbal annuiva, mandava giù il fumo che cominciava a dargli la nausea, non aveva bisogno di chiudere gli occhi per vedere sullo sfondo del fogliame il corpo di Sara che non aveva mai immaginato come un corpo, vedere la prima notte di nozze attraverso le parole del fratello di Ramírez, attraverso la voce di Doro che continuava a raccontare. Quel giorno non ebbe il coraggio di chiedergli l’indirizzo di Sara a Buenos Aires, rimandò alla visita successiva perché in quel momento aveva paura di Doro, ma la visita successiva non arrivò mai, cominciò la scuola con i nuovi amici, Buenos Aires a poco a poco inghiottì Aníbal carico di libri di matematica e con tanti cinema in centro e lo stadio del River e le prime passeggiate serali insieme a Beto, che era un vero porteño. Anche a Doro probabilmente stava succedendo la stessa cosa a La Plata, ogni tanto Aníbal pensava di mandargli due righe perché Doro non aveva il telefono, poi arrivava Beto o bisognava fare una ricerca per compito, passarono i mesi, il primo anno, vacanze a Saladillo, di Sara non restava ormai che qualche immagine isolata, una ventata di Sara quando qualcosa in María o in Felisa gli ricordava per un attimo Sara. Un giorno del secondo anno la vide nitidamente uscendo da un sogno e gli fece male di un male amaro e bruciante, in fin dei conti non era stato così innamorato di lei, poi allora era un bambino e Sara non lo aveva mai considerato come adesso Felisa o la bionda della farmacia, non era mai andata a un ballo con lui come sua cugina Beba e Felisa per festeggiare la promozione al quarto anno, non si era mai lasciata accarezzare i capelli come María, andare a ballare a San Isidro e scomparire a mezzanotte fra gli alberi della riva, baciare Felisa sulla bocca fra proteste e risate, appoggiarla a un tronco e accarezzarle il seno, scendere fino a perdere la mano in quel calore sfuggente e dopo un altro ballo e tanto cinema trovare rifugio in fondo al giardino di Felisa e scivolare con lei a terra, sentire in bocca il suo sapore salato e lasciarsi cercare da una mano che lo guidava, ovviamente non le avrebbe detto che era la prima volta, che aveva avuto paura, ormai era al primo anno di ingegneria e non poteva dire così a Felisa e poi non ce ne fu più bisogno perché s’imparava tutto molto in fretta con Felisa e qualche volta con sua cugina Beba.
Non seppe più nulla di Doro e non gli importò, si era dimenticato anche di Beto che insegnava storia in qualche paese di provincia, i giochi non avevano riservato sorprese a nessuno, Aníbal accettava senza accettare, qualcosa che doveva essere la vita accettava al posto suo, una laurea, un’epatite grave, un viaggio in Brasile, un progetto importante in uno studio con due o tre soci. Stava salutando uno di loro sul portone prima di andare a bersi una birra dopo il lavoro quando vide arrivare Sara sul marciapiede opposto. Di colpo si ricordò che la notte prima aveva sognato Sara e che erano sempre nel cortile della casa di Doro anche se non succedeva nulla, anche se Sara stava solo lì a stendere i panni o a chiamarli per il caffellatte, e il sogno finiva così senza quasi essere iniziato. Forse perché non succedeva nulla, le immagini erano di una precisione tagliente sotto il sole dell’estate di Bánfield che nel sogno non era la stessa di Buenos Aires; forse anche per questo o in mancanza di qualcosa di meglio gli era tornata in mente Sara dopo tanti anni di oblio (ma non era stato oblio, si ripeté cupo nel corso della giornata), e adesso vederla arrivare per strada, lì vestita di bianco, identica ad allora coi capelli che le sfioravano le spalle a ogni passo in un gioco di luci dorate, agganciandosi alle immagini del sogno con una continuità che non lo stupiva, che aveva qualcosa di necessario e prevedibile, e poi attraversare la strada e sbarrarle il passo, dirle chi era e lei che lo guardava sorpresa, non lo riconosceva e di colpo sì, di colpo sorrideva e gli tendeva la mano, gliela stringeva davvero e continuava a sorridergli. «Incredibile», disse Sara. «Come facevo a riconoscerti dopo tanti anni». «Lei no, certo», disse lui. «Ma io, vede, l’ho riconosciuta subito». «È logico», disse logicamente Sara. «Non avevi ancora i pantaloni lunghi. Anche io sarò cambiata tanto, è che tu sei più fisionomista». Aníbal esitò un secondo prima di capire che era da idiota darle ancora del lei. «No, non sei cambiata, nemmeno la pettinatura. Sei la stessa». «Fisionomista ma un po’ miope», disse Sara con la sua vecchia voce in cui si mischiavano bontà e presa in giro. Il sole in faccia, non si poteva parlare in mezzo al traffico e alla gente. Sara disse che non aveva fretta e che le sarebbe piaciuto bere qualcosa in un caffè. Fumarono la prima sigaretta, quella delle domande generali e dei giri di parole, Doro faceva il maestro a Adrogué, la mamma era morta come un uccellino mentre leggeva il giornale, lui lavorava in uno studio associato con altri giovani ingegneri, le cose gli andavano bene anche se la crisi, certo. Alla seconda sigaretta Aníbal lasciò cadere la domanda che gli bruciava le labbra. «E tuo marito?» Sara esalò il fumo dal naso, lo guardò lentamente negli occhi. «Beve», disse. Non c’era né amarezza né pena, era una semplice informazione e poi di nuovo Sara a Bánfield prima di tutto questo, prima della lontananza e dell’oblio e del sogno della notte precedente, proprio come nel cortile della casa di Doro, con lei che accettava il secondo whisky, come sempre quasi senza parlare, lasciandolo proseguire, toccava a lui raccontare perché aveva tanto di più da raccontare, aveva avuto anni così pieni, lei era come se non avesse vissuto molto e non valeva la pena dire perché. Forse perché l’aveva appena detto con una sola parola. Impossibile sapere in che momento tutto smise di essere difficile, gioco di domande e risposte, Aníbal aveva allungato la mano sulla tovaglia e la mano di Sara non si era sottratta al suo peso, lei l’aveva lasciata lì mentre lui chinava la testa perché non poteva guardarla in faccia, mentre le parlava a fiotti del cortile, di Doro, le raccontava le sere nella sua stanza, il termometro, il pianto contro il cuscino. Glielo diceva con una voce piatta e monotona, mescolando insieme momenti ed episodi ma era tutto la stessa cosa, ero così innamorato di te, ero così innamorato e non te lo potevo dire, tu venivi la sera a prenderti cura di me, eri la mamma giovane che io non avevo, mi misuravi la febbre e mi accarezzavi perché mi addormentassi, ci davi il caffellatte nel cortile, ti ricordi, ci sgridavi quando facevamo delle sciocchezze, io avrei voluto che parlassi soltanto a me di tante cose ma tu mi guardavi così dall’alto, mi sorridevi così da lontano, c’era un vetro immenso fra noi e tu non potevi far nulla per romperlo, ecco perché la sera ti chiamavo e tu arrivavi per prenderti cura di me, per stare con me, per amarmi come io ti amavo, accarezzandomi la testa, facendomi quello che facevi a Doro, tutto quello che avevi sempre fatto a Doro, ma io non ero Doro e solo una volta, Sara, solo una volta e fu orribile e non lo dimenticherò mai perché avrei voluto morire e non potevo e non sapevo, è chiaro che non volevo morire ma era l’amore, voler morire perché tu mi avevi guardato tutto nudo come un bambino, eri entrata nel bagno e avevi guardato me che ti amavo, e mi avevi guardato come avevi sempre guardato Doro, tu che eri già fidanzata, tu che stavi per sposarti e io lì mentre mi davi la saponetta e mi ordinavi di lavarmi anche le orecchie, guardavi nudo il bambino che ero e non ti importava nulla di me, nemmeno mi vedevi perché vedevi soltanto un bambino e poi te ne andavi come se non mi avessi mai visto, come se io non fossi stato lì senza sapere dove mettermi mentre mi guardavi. «Mi ricordo benissimo», disse Sara. «Me lo ricordo bene quanto te, Aníbal».
«Sì, ma non è lo stesso». «Chissà se non è lo stesso. Tu non potevi rendertene conto allora, ma io avevo sentito che mi amavi in quel modo e che soffrivi, ecco perché dovevo trattarti uguale a Doro. Eri un bambino ma a volte mi dispiaceva così tanto che fossi un bambino, mi sembrava ingiusto, qualcosa del genere. Se tu avessi avuto cinque anni di più... Te lo dico perché ora posso e perché è giusto, quel pomeriggio entrai apposta nel bagno, non c’era nessun bisogno che venissi a vedere se vi stavate lavando, entrai perché era un modo per mettere fine alla faccenda, per guarirti dal tuo sogno, perché tu ti rendessi conto che non avresti mai potuto vedermi così mentre io avevo il diritto di guardarti da tutte le parti come si guarda un bambino. Per questo, Aníbal, perché guarissi una volta per tutte e smettessi di guardarmi come mi guardavi pensando che io non lo sapessi. E ora sì, un altro whisky, ora che siamo grandi tutti e due». Dall’imbrunire a notte fonda, lungo strade di parole che andavano e venivano, di mani che si incontravano un istante sulla tovaglia prima di una risata e altre sigarette, restava una corsa in taxi, un certo posto che conosceva lei oppure lui, una camera, tutto come fuso in una sola immagine istantanea che si riduceva a un candore di lenzuola e alla quasi immediata, furiosa convulsione dei corpi in un interminabile incontro, nelle pause interrotte e rifatte e violate e sempre meno credibili, e in ogni nuova implosione che li falciava e li sommergeva e li bruciava fino al sopore, fino all’ultima brace delle sigarette dell’alba. Quando spensi la lampada della scrivania e guardai il fondo del bicchiere vuoto, tutto era ancora una pura negazione delle nove di sera, della fatica alla fine di un’altra giornata di lavoro. Perché continuare a scrivere se le parole scivolavano ormai da un’ora su quella negazione, stese sulla carta per quel che erano, meri disegni privi di qualsiasi fondamento? Fino a un attimo prima correvano cavalcando la realtà, riempiendosi di sole e di estate, parole cortile di Bánfield, parole Doro e giochi e fossato, alveare rumoroso di una memoria fedele. Solo che giunto a un tempo che non era più Sara né Bánfield il rendiconto si era fatto quotidiano, presente utilitario senza ricordi né sogni, la vita nuda e cruda né più e né meno. Avevo voluto proseguire e far proseguire docili anche le parole fino ad arrivare al nostro oggi di ogni giorno, a una qualunque delle lente giornate nello studio di ingegneria, ma poi mi ero ricordato del sogno della notte precedente, di quel sogno di nuovo con Sara, del ritorno di Sara da così lontano e così indietro, e non avevo potuto restare in un presente in cui ancora una volta sarei uscito dallo studio la sera e sarei andato a bere una birra al bar all’angolo, le parole erano tornate a riempirsi di vita e benché mentissero, benché non ci fosse nulla di vero, avevo continuato a scriverle perché nominavano Sara, Sara che arrivava per strada, così bello proseguire anche se assurdo, scrivere che avevo attraversato la strada con parole che mi avrebbero portato a incontrare Sara e a farmi riconoscere, l’unico modo per poterla finalmente rivedere e dirle la verità, arrivare alla sua mano e baciarla, ascoltare la sua voce e vederle i capelli che le sfioravano le spalle, andarmene con lei verso una notte che le parole avrebbero riempito di lenzuola e di carezze, ma come proseguire adesso, come iniziare da questa sera una vita con Sara quando lì accanto si sentiva la voce di Felisa che entrava coi bambini e veniva a dirmi che la cena era pronta, che dovevamo metterci subito a tavola perché era tardi e i bambini volevano vedere Paperino in televisione alle dieci e venti.