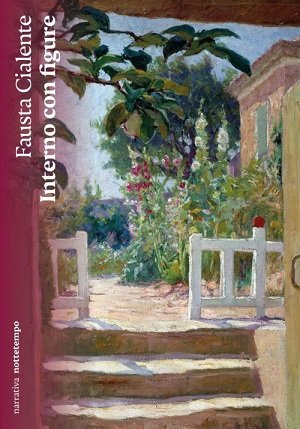di Emanuela Lancianese
Come Maria Giacobbe, Fausta Cialente, nate entrambe in Sardegna ma vissuta quest’ultima soprattutto in Egitto, entrambe, a loro modo, involontariamente esiliate dalla repubblica delle lettere e volontariamente dall’Italia, è una scrittrice che ha avuto una voce, uno stile, uno sguardo sul mondo forte e profetico.
Temi poco affrontati dalla letteratura, se non nei testi drammaturgici della corrente verista, come la relegazione delle donne e dei bambini in spazi scomodi, l’uso e abuso del corpo e del desiderio, il dominio patriarcale del maschile sul femminile e dell’Occidente autocrate sui popoli colonizzati, evocano dimensioni letterarie sfocate sullo sfondo della “grande letteratura” novecentesca che Fausta Cialente ha messo in prospettiva rispetto al caleidoscopio delle visioni italiane del secolo scorso, agitate dalla guerra, dalla psicanalisi, dalla “caduta delle maschere” e poco o nulla dal grande rimosso dei desideri femminili e dell’infanzia. Lo ha fatto con grande anticipo sui tempi, anche se il canone letterario, come è stato per Ada Negri e appunto per Maria Giacobbe, stenta ancora a riconoscerne il merito, assecondando un grave peccato di omissione verso talenti molto moderni.
In realtà a forzare il canone delle case editrici del Novecento, Fausta Cialente era riuscita nel 1976 quando vinse il premio Strega per “Le quattro ragazze Wiselberger”, ma dalla metà degli anni’70 in capo a pochi anni, dei suoi libri e racconti si è fatto tabula rasa, nonostante una scrittura impeccabile e sottile, capace come poche di raccontare tutte le sfumature del tormento della dimensione domestica. Merito quindi della casa editrice Nottetempo averla riscoperta e nuovamente pubblicata.
Sul perché poi l’oblio culturale colpisca più spesso le donne che gli uomini è una domanda alla quale in Fausta Cialente si può trovare l’eco potente di una risposta: le donne sono spesso confinate in uno spazio dove
“il tempo scorre sereno, senza grandi urti, né gravi preoccupazioni, in un sereno egoismo familiare”
(da ‘Marianna’)
Anche se fuori è passata la guerra, basta loro, per riattarsi alla vita domestica, aver ritrovato la casa intatta al ritorno, ma anche, più acutamente, nell’orrore della distruzione, non conoscere veramente differenza nei tempi e nei luoghi della loro condizione di recluse, intrappolate tra il desiderio di libertà e l’impossibilità di sapere come fare per esserlo fino in fondo, libere appunto, una volta intrapresa la lotta materiale per diventarlo.
Forse a Fausta Cialente non è stata ancora perdonata l’aura favolistica che hanno certe sue ambientazioni ricreate per dire di “realtà inesorabili”, proprie del mondo dei bambini, con le loro “sorprendenti chiaroveggenze, malizie studiate e dosate, crudeltà forse inconsapevoli”.
Nei suoi tredici racconti in Interno con Figure a cura di Emmanuela Carbè, che Nottetempo ha ristampato insieme ai romanzi “Un inverno freddissimo”, “Il vento sulla sabbia” e “Ballata levantina”, ci sono bambini che scacciano colei che possiede la forza della ribellione di cui ne intravedono la forza e il pericolo, perché “ha una segreta puzza di bruciato negli abiti” (come Marianna) e ci sono bambini che nella bruttezza di una vecchia ne riconoscono per primi e in solitudine il potere stregonesco e metamorfico (La ballerina).
Bambini, bambini benedetti ed eroici nei racconti di “Interno con Figure”. Con dignità, mentre nel soggiorno borghese si teme e si urla per la vergogna della figlia incinta, il bambino malato compie da solo l’ultimo viaggio a cavallo di una statua equestre (Statue). Non mancano i bambini che sanno spiare le insoddisfazioni degli adulti, apportando al momento giusto il migliore sollievo alla catastrofe, come il figlio di Pamela, che appena l’amante della mamma, pittore appartenente alla classe colonizzatrice e benestante, ospite invadente della casa e soprattutto della cucina, luogo sacro al muliebre della famiglia ‘indigena’ affittuaria, se ne torna leggero nel suo mondo, consola con un gesto inaspettato la madre, che nel deserto di un corpo ancora desiderante, sa che “l’estate è finita” per sempre.
I bambini non si ingannano nemmeno sulla astuta amabilità della bella vedova che aspettano sulla via del cimitero, beandosi della sua grazia ammaliatrice e materna mentre smascherano il vuoto di certi riti luttuosi inscenati dagli adulti, riti che usano per nutrire l’immaginazione dei loro giochi. Del resto tutto là fuori è incline a una “lieta profanazione”: se la piccola Ninì, accompagnando in un bar l’amica di collegio poco più vecchia di lei, intuisce subito l’essenza di quel bel giovane comparso sulla soglia “dall’aria insolente, che s’era fermato a guardare dentro con un’occhiata di sfida e di sprezzo e, quando i suoi occhi s’erano posati su Angela, di sfacciata, trionfante ammirazione”. Ninì non si inganna neanche per un attimo sul destino di Angela.
“La vide farsi pallidissima e strinse le mani intorno al bicchiere dentro cui s’era inutilmente disciolta la granita al lampone. Il giovane era bello su per giù come i principi che sbarcavano nell’isola per sposarla; ma se quelli inventati da lei avevano quasi sempre espressioni d’amore o di rimpianto, in costui non c’era proprio nulla di romantico. Peggio ancora: non ispirava nessuna fiducia, nessun rispetto. Pensò: Questo è uno che ha bastonato e, subito dopo: Forse bastonerà anche lei”.
Spetta però a certe bambine umiliare certi uomini. “La sfrontatezza della bambina selvaggia sapeva tenere testa al padre Toni e umiliarlo” e spetta alla scrittrice trovare un aforisma di cui poi abbiamo abusato nei decenni per indicare una profonda verità: “Toni aveva introdotto una frase che ripeteva ad ogni occasione: Voi dite che non vi occupate di politica e non vi accorgete che la politica si occupa di voi! Rideva, dicendolo, benevolmente, perché era sempre benevolo”. “Quando la vita rincara,” diceva, “quando la gente non trova né casa né lavoro, non trova posto negli ospedali, e per i bambini non ci sono scuole sufficienti, cosa credete che sia? È politica, e quando protestate contro queste cose ingiuste, voi ‘fate’ politica, anche se non vi sembra. Basta pensarci”. E anche quest’altra immagine lessicale ci lascia Fausta Cialente incisa nelle viscere: “A questi levantini, pensava Pamela piegando un poco la bocca, no ghe piase rider, no. E le pareva una gran malinconia, una cosa ben miserabile che anche per poter ridere si avesse bisogno di quattrini”.