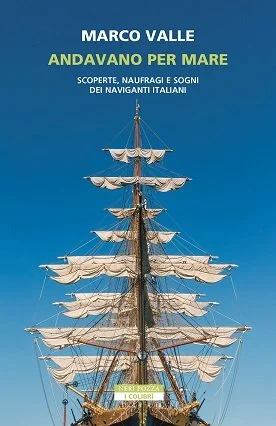Neri Pozza porta in libreria Andavano per mare, di Marco Valle. Un libro ibrido, dal fascino avvolgente. Avventure straordinarie e rischiosissime, ritmate dal frastuono dei marosi e dall’alito dei venti, in balìa della solitudine, del sole, del gelo, dalla sete e dalla fame. Storie di uomini di mare ma anche di astronomi geniali, temerari letterati, giramondo inquieti. Storie lontane, ma anche storie di oggi, che quest’Italia distratta e molto terricola ha spesso dimenticato. Ed ecco il motivo, la ragione di questo libro: ritrovare, riannodare quel lungo filo blu che si dipana dalle galee medievali e dalle caravelle colombiane e arriva sino al Rex che inalbera il Nastro azzurro, a Luigi Rizzo e Tino Straulino, alla saga di Azzurra, a Enzo Maiorca e Giovanni Soldini.
Cattedrale vi propone un estratto da uno dei testi, per gentile concessione dell’Editore
Navigare necesse
di Marco Valle
La grande stagione dei navigatori italici – con l’eccezione del Malaspina – si esaurì con l’inoltrarsi del Seicento, per l’intera penisola un secolo d’arretramento e declino. Come analizzato da Carlo Maria Cipolla, nell’arco di tre generazioni l’Italia da Paese ricco e sviluppato divenne una terra povera e arretrata, dominata «da una casta di possenti proprietari agrari che avevano ricacciato in secondo piano gli operatori mercantili, manifatturieri e finanziari». Sotto il peso della concorrenza straniera le esportazioni crollarono; la vita economica delle città centrosettentrionali, cuore della produzione manifatturiera, si ripiegò su pochi nuclei d’imprenditorialità, mentre il Meridione scivolava in una condizione di «gravissimo sottosviluppo: un paese di baroni poco o niente illuminati e di contadini analfabeti dove lo spazio del ceto medio era occupato quasi esclusivamente da avvocati e notai».1
La crisi delle produzioni padane e toscane assieme allo sfaldamento delle relazioni finanziarie e commerciali, accelerò il progressivo appannamento della vocazione marittima delle talassocrazie nostrane, ancora pingui ma ormai sfibrate, esauste; in modi e tempi differenti, Genova e Venezia smisero d’essere due dei massimi centri degli scambi mondiali e si rattrappirono in una opulenta neutralità sempre più disarmata. Una scelta miope.
In quel primo scorcio dell’Età Moderna il controllo del Mediterraneo passò di mano: era arrivato il tempo di Olanda e Inghilterra. Translatio imperii. Approfittando della fatica spagnola e dei tanti problemi italici, grandi vascelli nordici iniziarono a oltrepassare Gibilterra infilandosi nel Mediterraneo per affollare le banchine dei porti del Levante o, se capitava, per pirateggiare a loro piacimento. Nel frattempo, i martoriati litorali, sottoposti alla continua pressione dei corsari barbareschi, si spopolarono e impaludarono, gli scali decaddero e la navigazione – a eccezione delle residue linee venete, liguri e ragusee – si ridusse a un piccolo cabotaggio gestito da scarne comunità rivierasche.
A solcare le onde rimasero in pochi, e ancor meno furono coloro che non rinunciarono a combattere, tra questi l’ultimo navarca della Serenissima: il capitano da mar Francesco Morosini. Nel 1644, dopo una lunga fase di pace, i tamburi di guerra tornarono a rullare e la classe dirigente veneziana – come sottolinea Alvise Zorzi ancora «elastica, coraggiosa e capace di rischiare» – affrontò le ultime sfide contro il trisecolare rivale ottomano: le guerre di Candia (Creta) e di Morea (Peloponneso). I marciani, guidati dall’ottimo Morosini, ottennero vittorie navali importanti – il 19 ottobre 1667 a Stantia s’imposero in una delle rare battaglie notturne della storia – e sperimentarono con successo la guerra anfibia, impiegando i coraggiosi schiavoni oltremarini2 come fanti da mar in sincronia con l’artiglieria terrestre e la micidiale tecnica delle mine. Tanto valore e ingegno, ma nel 1669 le casse dello Stato erano vuote (“esser in Candia” divenne sinonimo di bancarotta) e le perdite divennero insopportabili. Il 6 settembre Morosini si rassegnò alla capitolazione e dovette accettare la cessione dell’isola, fatta eccezione per le enclaves fortificate di Suda, Grasbusa e Spinalonga e le isole di Tino e Cerigo nell’Egeo. Sulle quindici galee rientranti in patria gli ultimi difensori caricarono i tesori delle chiese e gli archivi relativi ai 465 anni d’amministrazione veneta a Creta.
Ma non era finita. Nel 1684 la Repubblica di Venezia riprese le armi con alleati potenti – austriaci e polacchi già vittoriosi a Vienna – e idee innovative. Nuovamente sotto il comando di Morosini, in quattro anni riconquistò quanto aveva perso in Morea e nello Ionio; nel 1687 fu la volta di Patrasso, Corinto e Atene, dove una cannonata veneta centrò il tetto del Partenone, facendo esplodere le polveri che i turchi avevano ammassato nel tempio. Mettendo a frutto l’esperienza acquisita nella guerra di Candia, l’ammiraglio coordinò strettamente la flotta con le forze di terra, facendo appoggiare gli sbarchi dall’armata sottile (le galee) e affidando all’armata grossa (i velieri) il compito di tagliare le linee di comunicazione turche. Ottimi successi che valsero al condottiero un monumento in bronzo, il titolo di Peloponnesiaco e poi, il 3 aprile 1688, quello di doge. Una breve parentesi. L’ormai anziano Morosini morì nel 1694 a Nauplia. Lo ricordano il prestigioso liceo navale di Venezia, istituito nel 1961 e a lui intitolato, e un pattugliatore d’altura varato nel 2020, terza nave della Marina militare a portare il suo nome.
La guerra proseguì tra l’Egeo e i Dardanelli in una serie di scontri navali dall’esito incerto. Nel 1699 il trattato di Carlowitz riconobbe al dogato il possesso del Peloponneso, l’isola di Egina nel golfo dell’Attica, le isole Ionie e alcuni capisaldi in Albania. Cipro e Creta, l’obiettivo finale della campagna, rimasero sotto le babbucce degli ottomani. Una conclusione agrodolce e poco redditizia: per difendere i poverissimi domini ellenici a Nauplia, Acorinto e Corone furono erette fortezze talmente formidabili che, riprendendo Zorzi, «pare impossibile che siano state costruite da una potenza di proporzioni e di risorse limitate, fanno pensare, piuttosto, a un impero di grandi proporzioni».
Una barriera imponente purtroppo mal difesa e incapace, nel giugno 1715, d’arginare e respingere l’ennesima offensiva turca. Conquistata la Morea, nel luglio dell’anno dopo l’esercito sultaniale investì con tutta la sua forza Corfù, la chiave dell’Adriatico. Energicamente guidata dal conte sassone Johann von Schulenburg, la piccola guarnigione resistette valorosamente; un’altalena di furiosi attacchi e contrattacchi, sortite e ritirate che si protrasse sino alla fine d’agosto quando gli invasori, pressati dalla flotta veneta, furono costretti a reimbarcarsi. Salvata l’isola, l’armata grossa impegnò a più riprese gli ottomani nello Ionio e poi nell’Egeo, e insidiò nuovamente i Dardanelli. Gli ultimi combattimenti avvennero nel golfo di Pagania, nel luglio 1718, con ventotto velieri che respinsero un convoglio nemico e a Dulcigno dove le galee sbarcarono 10mila uomini. Il glorioso commiato della vetusta marina remica marciana.
I successi navali non furono però sufficienti per “pesare” al tavolo della pace di Passarowitz. L’imperatore d’Austria Carlo VI, forte delle vittorie di Eugenio di Savoia a Petervaradino, Zenta e Belgrado, impose a nemici e alleati le sue condizioni. Il trattato, firmato 21 luglio 1718, obbligò i veneti a cedere la Morea, Tino, Spinalunga, Suda, nonché Antivari, Zarine, Ottovo e Zurbi. In cambio Venezia ottenne la restituzione di Cerigo, Butrinto, Prevesa e il mantenimento di Corfù e dipendenze. Misero risultato. Giustamente Zorzi fissa in quel momento storico l’esaurimento di una presenza risalente al tempo delle crociate: «Come potenza mediterranea, come potenza coloniale, Venezia ha cessato di esistere. Il possesso delle isole Ionie rappresenta soltanto un bel residuo dell’antico impero». Fu così che il sempre più ristretto patriziato lagunare – una classe ormai fiacca, languida e terribilmente cinica – inguainò le spade e volse definitivamente le spalle al mare.
Con l’evaporarsi di Venezia dalla scena mediterranea, la parallela agonia delle marinerie liguri e toscane e la parziale estromissione del Mare Interno dai grandi traffici mondiali, il Patrio Stivale s’interrò definitivamente. Nonostante alcune spinte in controtendenza – le politiche marittime di re Carlo di Borbone e del figlio Ferdinando a Napoli, gli investimenti dell’Austria teresiana sui porti di Trieste e Fiume, gli approcci navali sabaudi, la sorprendente resilienza della flotta mercantile di Ragusa di Dalmazia – il mare si estraniò dal pensiero stesso degli italiani. Significative a riguardo le riflessioni di Giacomo Leopardi nello Zibaldone: «Le idee relative al mare sono vaste e piacevoli per questo motivo, ma non durevolmente, perché mancano di due qualità, la varietà, e l’esser proprie e vicine alla nostra vita quotidiana, agli oggetti che ci circondano, alle nostre assuefazioni, rimembranze ecc. (dico di chi non è marinaio di professione) e anche alle nostre cognizioni pratiche; giacché la cognizione pratica, almeno ingrosso, l’uso e l’esperienza, una tal quale familiarità con ciò che il poeta ha per le mani è necessaria all’effetto delle immagini e sentimenti poetici; ed è per questo che piace soprattutto alla poesia quello che spetta al cuore umano».3
Una “mancata esperienza” di cui le ristrette élite nostrane iniziarono ad avere sentore e coscienza soltanto negli anni Trenta dell’Ottocento con l’avvento della prima rivoluzione industriale, una svolta epocale che si intrecciava a un’altra rivoluzione, questa volta spaziale. In pochi anni la navigazione a vapore, le ferrovie, il telegrafo (prima ottico e poi elettrico) determinarono una contrazione delle distanze e la creazione delle prime reti globali di comunicazioni. In breve tempo prese forma un sistema di interconnessioni e trasporti di massa, e tutto (o quasi) sembrò raggiungibile.
Su queste coordinate i segmenti modernisti di tutta Europa iniziarono a guardare con nuovi occhi il Mediterraneo, valutando con crescente interesse il dibattito sul taglio dell’Istmo di Suez. Fondamentale fu l’incessante agitarsi del francese Barthélemy Prosper Enfantin, per i suoi sodali semplicemente le Père Enfantin, personaggio pittoresco quanto ingegnoso che aveva trasformato i cenacoli intellettuali fondati da Claude-Henri de Saint-Simon in una comunità elitaria in cui strambi aspetti para-religiosi, aspirazioni comunistiche, critiche sociali si confusero e si mescolarono con intuizioni tecnologiche, progetti futuristici, sapori orientalisti. Fedeli alle formule del fondatore, i sansimoniani immaginavano un mondo régi par les savants, retto dai sapienti, e l’idea del Canale – concepita come sintesi di tecnica e poesia, grande opera di pace e concordia utile all’umanità tutta – divenne per gli entusiasti sognatori francesi il grande laboratorio transnazionale in cui l’“utopia del progresso” diventava infine realtà. Al tempo stesso lo scavo dell’idrovia divenne una prospettiva interessante per il “partito industriale” europeo, oltre che un nodo centrale del serrato duello tra Londra e Parigi per il controllo della via delle Indie.
Nelle aree più dinamiche dell’allora frammentata Penisola, la crescente consapevolezza della rinnovata centralità del grande bacino accese un inedito interesse sulla negletta dimensione marittima dell’Italia, suscitando in modo intermittente il recupero di una percezione del mare da tempo smarrita. Un sentimento che motivò, con risultati alterni, imprenditori illuminati e alcuni governanti a impegnarsi in pioneristiche iniziative armatoriali e limitati investimenti infrastrutturali. Per quanto flebile, la nuova “coscienza politica del Mediterraneo” alimentò anche le speranze e le aspirazioni del nascente movimento risorgimentale, determinando i primi disegni unitari. Negli scritti di Gioberti, Cattaneo, Balbo, Durando, Cantù, Mazzini cominciarono a prendere forma – seppur in maniera ideologica e astratta – l’immagine di un’Italia “navalista”, e persino acerbe ipotesi di una eventuale proiezione oltremare. Fu però un geniale conte torinese il primo a delineare con lucidità una solida ed efficace strategia navale, e a inserirla – prima come ministro della Marina del Regno di Sardegna e, dal 1861, del Regno d’Italia – nel contesto geopolitico ed economico del tempo. Si chiamava Camillo Benso di Cavour, il Pater Patriae.
1 Carlo Maria Cipolla, Storia facile dell’economia italiana, Mondadori, Milano 2017, p. 78.
2 Gli oltremarini erano i temuti soldati della Serenissima, conosciuti anche con il nome di schiavoni, volontari reclutati in Dalmazia, Albania Veneta e isole Ioniche. Formavano undici reggimenti comandati da ufficiali illirici, balcanici ed ellenici; a seconda dei reparti gli ordini erano impartiti, oltre che in veneto, in serbo, croato, albanese e greco. Impiegati inizialmente come fanti da mar, passarono poi al servizio in terraferma, presidiando fortezze e città. I centri d’arruolamento erano Zara e Corfù e una volta addestrati venivano mandati al forte del Lido oppure a Padova, centro militare dello Stato da Tera. Era richiesta una statura minima di un metro e sessantadue (altezza di tutto rispetto se si pensa a quella media di allora), un’età compresa tra i sedici e i quarant’anni, l’appartenenza alla religione cristiana e, soprattutto, un fisico robusto. Celebri l’amore degli schiavoni per il vessillo marciano, il fortissimo spirito di corpo (tra loro si chiamavano brate, «fratello») e la ferocia in battaglia. L’aspetto era pittoresco: capelli lunghi e incolti e gran mustacchi. Erano armati della micidiale spada schiavona, molto pesante e a lama larga, di pistola ad avancarica, pugnale a lama lunga e di un fucile senza baionetta.
3 Giacomo Leopardi, Zibaldone, Newton, Roma 1997, p. 397
© 2025 Neri Pozza Editore, Vicenza