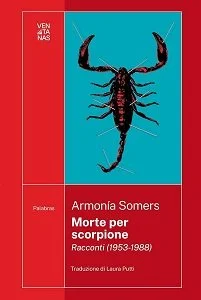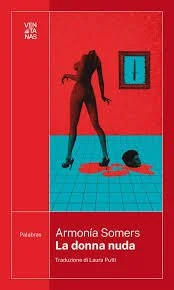di Alice Pisu
Nel complesso panorama letterario latinoamericano occupa un posto rilevante dopo anni di marginalità Armonía Somers. Divenuta un’autrice di culto e tra le maggiori scrittrici femministe ispanoamericane, è ingiustamente rimasta sconosciuta in Italia sino al 2023, quando Ventanas edizioni pubblicò La donna nuda grazie alla lungimiranza di Laura Putti che ha curato anche la traduzione e la selezione dei racconti Morte per scorpione usciti tra il 1953 e il 1988.
Somers ha definito con le sue opere una personale letteratura attraverso una peculiare poetica del disastro, dalla prosa tersa e fosca al contempo, innovativa per temi ritenuti rivoluzionari per il secondo Novecento e per la capacità di generare una destabilizzazione totale nel lettore ancora oggi, a oltre settant’anni dalla prima uscita.
Determinante l’influenza avuta dai luoghi natii (nacque a Pando nel 1914). Paese di luci e ombre, con un alto tasso di criminalità ma al contempo progressista per la netta divisione tra Stato e Chiesa e per la tutela dei diritti (risalgono al 1877 l’obbligo scolastico generale, ben quarant’anni prima della Germania, e al 1913 l’introduzione del divorzio per volontà della donna), l’Uruguay divenne nel tempo la patria di grandi voci letterarie.
Somers assorbì precocemente la necessità di giustizia e l’attenzione per le fragilità sociali, fece proprie le grandi contraddizioni della società uruguaiana in cui si formò, e seppe tradurre le istanze femministe in ogni sua opera generando accesi dibattiti per i temi affrontati e per la complessità della prosa, come dimostrato dal clamore generato per l’uscita de La donna nuda nel 1953.
“Il suo spagnolo è immaginifico – ha dichiarato Laura Putti su Tuttolibri –. Quando sembra pieno di riferimenti, quando sembra che tu lo debba decodificare per rendere la vita un po’ più facile al lettore, è valido in realtà soltanto quello che leggi. E così devi tradurre. Parola dopo parola. Senza domandarti il perché”.
Ogni opera di Somers trasuda dolore e desiderio, impasta di continuo una materia rimaneggiata su traumi e svolte necessarie, anche per le influenze subite negli anni di insegnamento nei quartieri marginali di Montevideo che la portarono a compiere studi significativi sul disagio e la criminalità giovanili.
Nel tempo Somers continuò a misurarsi in ugual misura con forme brevi, novelle e romanzi, anche per affrontare il difficile rapporto con la malattia che segnò gli ultimi venticinque anni della sua vita. Furono le discussioni innescate dai suoi libri a portare la critica a focalizzarsi sulla sua letteratura, all’inizio con profondo scetticismo e solo successivamente riconoscendone un rilievo tale da inserire Somers tra le voci letterarie uruguaiane alternative e eclettiche, accanto a Felisberto Hernández, Horacio Quiroga, Juan Carlos Onetti, Mario Levrero, tra gli altri.
La matrice anticonvenzionale di scrittura e vita di Somers incise nella generale discordanza sulla sua opera. Un esempio su tutti il passo indietro di Mario Benedetti rispetto al giudizio negativo espresso per il suo esordio. Dieci anni dopo quella uscita prese atto della grandezza e della profonda originalità di una narratrice che in particolare con i suoi racconti meritava di essere antologizzata, come suggerì nel contributo critico apparso nel 1964 poi confluito nel Saggio sulla letteratura uruguaiana del XX secolo.
Benedetti rimase affascinato dalle implicazioni metafisiche di questa letteratura anomala, della quale sottolineò la capacità di celebrare orrori senza redenzione in un destino cieco che condanna l’essere umano alla miseria e a una solitudine inesorabile.
Tutto ricade in una dimensione perversa, allucinata, il cui senso non sempre è chiaro, sulla base della definizione dell’esistenza concepita dall’autrice come un gioco dimenticato dalla morte. Solo le opere successive avrebbero chiarito la visione di Benedetti in merito a Somers, per condurlo ad affermare che seppur con i limiti di un esordio, le sue prime storie non si riducono a manierismo ma palesano un’angustia metafisica.
Somers risultò come una scrittrice perennemente estranea al canone, eclettica e anomala, anche rispetto ai suoi contemporanei. Le sue storie scatenarono presto nette divisioni tra quanti ne elogiavano l’originalità formale e quanti ne denunciavano il caos e la mancanza di senso. Quel che sfuggiva era la straordinaria capacità di far coesistere sulla pagina scenari capaci di suscitare emozioni contraddittorie e vivide, di produrre compassione autentica e repulsione per un personaggio, di favorire un’uguale dose di eccitazione disturbante e orrore per visioni orrorifiche e seducenti inserite all’interno di un disegno più ampio che si addentra nelle pieghe recondite della perversione.
L’atto brutale, feroce, violento, che sovente apre le storie, non mostra cause intelligibili e non fornisce un appiglio adeguato nel contestualizzare nel tempo e nello spazio la narrazione: induce un generale effetto destabilizzante acuito dall’indeterminatezza che si posa su personaggi e luoghi.
La dorsale che attraversa l’intera produzione di Somers è il rapporto con il desiderio, declinato nel superamento dei confini del noto attraverso esperienze estatiche, spirituali e carnali al contempo, o nella privazione e repressione del piacere con esiti devastanti a livello individuale e collettivo. Aspetti resi attraverso un affresco su condizionamenti sociali, stereotipi, patriarcato delle relazioni, in un continuo dissidio interiore e tra soggetti narrati che rende i luoghi depositari di memorie oscure.
Ogni figura convive con tensioni agli antipodi e si scopre capace di crudeltà e tenerezza secondo una duplice natura per convenzione ritenuta contraddittoria ma che, come Somers mostra, è la matrice più autentica dell’umano, a partire dalla necessità di nutrirsi di morbosità e desolazione.
Il testo che apre Morte per scorpione, Il crollo (1953), segue uno schema narrativo ricorrente nelle novelle e nei racconti di Somers: la colpa che grava sul protagonista (Tristàn, assassino afrodiscendente); la fuga; il degrado privo di salvezza (una baracca che ospitava una moltitudine di disperati, “un forte miscuglio di umanità, pidocchi e peccato che russava per terra”); un incontro decisivo che funge da catalizzatore e rappresenta un’epifania (la statua della Madonna che veglia sul tugurio e prende vita invitando Tristàn a sciogliere la cera che la ricopre e renderla umana per vendicarsi di chi ha ucciso suo figlio); l’inesorabile tracollo psichico e esteriore (il traballare della baracca con “quel rumore che precede i crolli”).
Ogni storia definisce il suo senso ultimo a partire dalla svolta inattesa che anticipa un disfacimento in grado di alterare i connotati del tangibile e favorire nuove consapevolezze nel dolore e nel piacere. La svolta è spesso legata alla dimensione sessuale che nell’universo narrativo dell’autrice travalica il mero erotismo. Emblematiche ne Il crollo le pagine dedicate al graduale scioglimento della cera della statua della Vergine con il tocco del peccatore che prova un desiderio irrefrenabile di penetrarla e che assiste, incredulo, alla sua prostrazione grata davanti a lui.
L’esplorazione fisica e interiore studia le tensioni antitetiche dell’essere umano come pura corporeità esposta agli eventi, destinata al logoramento e a un’inesorabile trasfigurazione. Ogni individuo pare destinato a fare i conti con contraddizioni che lo caratterizzano e lo conducono allo smarrimento, alla perversione, al decadimento.
La sensualità della prosa di Somers riserva una cifra di sacralità nel corpo, depositario del fervore liberatorio reso attraverso scene surreali elette per attestare i percorsi sotterranei dell’inconscio. Al di là della parvenza blasfema, lo slancio visionario e rivoluzionario nello sguardo letterario di Somers risiede nel definire in termini nuovi le frontiere della salvezza nell’amore. Edifica un riparo che non risparmia dalla morte (semmai la predice) ma illumina il vero attraverso la pietà per chi è segnato dalla colpa: afferisce alla consapevolezza di un’umanità celata persino negli individui ritenuti abietti, considerati uno scarto della comunità, indegni di esistere. È a tali soggetti che Somers si rivolge costantemente, nel renderli protagonisti delle sue storie e elevarli a emblemi di una società incapace di scrutare sé stessa.
L’impronta crudele che caratterizza molti dei soggetti delle sue storie riserva i risvolti imprevedibili propri di una dimensione di solitudine che accomuna l’essere umano: sono legati a una malvagità irrimediabile, a un’espressione di odio indiscriminato che rappresenta una forma di difesa da altro dolore o che palesa le radici dell’intolleranza spesso nei confronti della libertà femminile, delle unioni omosessuali, dell’emancipazione da regole triviali.
Il rapporto con la fine è una delle costanti nella produzione di Somers. Il racconto Requiem per Goyo Ribera studia il peso del compromesso nel sopravvivere alla morte di una persona cara. Lo splendore della rovina dell’altro, il dolore nel mancato riconoscimento pubblico, l’impossibilità di una reale elaborazione del lutto sino al curioso rovesciamento dell’epilogo, si sostanziano nel graduale svelamento della complessità di un soggetto in relazione all’orientamento sessuale, alla sua libertà, al problema di coscienza definito “l’organo accidentale della vigliaccheria” di chi è annientato dal proprio conflitto interiore e non vuole “cani che lo sbranino”.
Come nel racconto eponimo, la morte è lo spettro ineludibile, frammista al crescendo definito dal desiderio osceno, morboso, sottaciuto, che corrode le relazioni e si insinua come il veleno stesso dell’aracnide annidato negli angoli remoti di un’abitazione emblema di un’unità famigliare in bilico.
Risulta ineludibile l’isolamento in cui versa chi resta, privato, come chi muore, di un conforto ultraterreno: una sorte che non contempla redenzione perché non concepisce la presenza divina.
Come ricorda nelle sue pagine: “Dio io non ti ho mai trovato”. L’assenza di Dio riveste una questione centrale nella poetica di Somers, definisce l’agire del singolo e lo smarrimento esistenziale inestinguibile, si lega al senso assunto dal lato oscuro, abietto, misero, del vivere, e illumina quello che Benedetti definì il carattere osceno del mondo.
È la scrittura stessa ad acquisire una cifra divina, incarna l’impulso vitale originario che sancisce l’inizio e la fine. Come dichiarò in un’intervista: “Penso e dico sempre che non inventiamo la finzione nel suo senso assoluto, ma che questo compito delirante dipende in qualche modo dal Demiurgo dei platonici o dei neoplatonici, e che noi non siamo certo i loro obbedienti scribi”.
Lo studio narrativo sull’umano si regge sull’idea di messa a nudo, sullo smascheramento, sulla decostruzione di stereotipi, per far rilucere la cifra vulnerabile più autentica e indurre in chi legge un cambio di prospettiva. Persino quelle che all’apparenza sono storie d’amore celano stratificazioni sotterranee grottesche, macabre, che lambiscono l’assurdo per amplificare gli esiti dell’abbandono totale all’altro e le conseguenze di relazioni insane in cui si rimane invischiati nell’incapacità di una reale emancipazione.
Le ricorrenze nell’intera produzione letteraria di Somers sono definite in dettagli minimi portatori di significati assoluti e caratterizzano in senso più ampio la bizzarra costellazione di personaggi e vicende: orologi fermi mai più ricaricati; binari simbolo di partenze e ritorni impossibili; nudità rivelatrici di perversioni altrui; boschi come porte verso dimensioni ignote, selvatiche, spesso scenari di cambiamenti radicali.
Che si tratti di racconti o romanzi, ogni storia composta da Somers getta chi legge in un atipico smarrimento dall’efficacia inalterata. È un’alienazione generata da una sovrabbondanza di rimandi al mito, al trascendente, all’assurdo, al fantastico, per comporre una personale epica dell’abbandono con figure che sfilano sulla pagina sovrastati da fardelli insopprimibili che tuttavia non inibiscono la capacità di stupore. L’apparente sfuggevolezza del senso ultimo delle sue storie tradisce l’intento di mostrare la cifra caleidoscopica di ogni vicenda in favore di una riflessione sulla natura fragile di un’epoca incapace di misurarsi con la propria memoria.
Leggere racconti come La deviazione o romanzi come La donna nuda porta a percepire un’affinità recondita nel raffigurare un’epopea amorosa screziata da un lato mostruoso e marcio. Ancora una volta la stazione è lo scenario d’elezione di Somers: nel racconto La deviazione una coppia nasce proprio dall’incontro in un luogo di scambi e incontri fortuiti. La casualità innescata da un bambino sulla banchina con un mucchio di palloncini favorisce sguardi decisivi per un contatto fatale tra un uomo e una donna che da quel momento in poi passeranno un lungo periodo a bordo. Nella loro carrozza il tempo e lo spazio sembreranno non avere più importanza al di fuori della compagnia reciproca e delle mele per il sostentamento. L’idillio del vivere l’uno per l’altra mano nella mano con la sola evasione del mangiare fuori dalla cabina sotto un cielo stellato è segnato da un presagio che si fa strada nella sensazione di correre all’inverso del tempo.
Confesso ora quella sensazione di andare in senso contrario a qualcosa che veniva fatto a pezzi tra i nostri denti, ma il cui dolore non era quello
che avrebbe dovuto essere conformemente all’importanza della privazione.
Sono i rimandi biblici a cadenzare il crescendo nefasto di una vicenda che lambisce l’assurdo per il senso claustrofobico di essere in trappola sovrapposto al romanticismo di un’esperienza di coppia totalizzante: il frutto come simbolo d’amore e di peccato, la creazione e la ricorrenza del sette (il viaggio di sette giorni che si trasforma in sette anni è percepito ironicamente come “il tempo giusto per quello che sta succedendo. Che infallibile e misurata precisione. Dio e i suoi incantevoli enigmi”).
Il tempo dilatato e lo spazio ristretto ridefiniscono i contorni del noto imponendo una ricomposizione del disordine con un epilogo che assegna ancora una volta a una figura esterna il ruolo risolutore estremo che annulla i pochi riferimenti considerati certi e cancella ogni prospettiva futura.
Una straordinaria affinità lega racconti come Jezebel a romanzi come La donna nuda per il rimando alla dimensione selvatica e per il ricorso a elementi fantastici nel dare forma all’esplorazione del sentimento amoroso sulla base di una decostruzione di stereotipi fomentati da misoginia e omofobia. In entrambi gli esempi a stagliarsi su una società ottusa e triviale sono figure illuminate dalla libertà.
In Jezebel il protagonista prova verso un giovane sconosciuto un’attrazione irrefrenabile che si sostanzia nel desiderio di possederlo sessualmente e di annientarlo al contempo. Traspare la denuncia del mascheramento di aneliti ritenuti moralmente disdicevoli: quel rifiuto di accettare la reale natura del proprio desiderio si trasforma in odio e violenza.
Ne La donna nuda una comunità intera organizza spedizioni per stanare la giovane avvistata senza vestiti, e porta ognuno a fare i conti con la propria coscienza (dalla coppia di gemelli al boscaiolo e persino al prete) e a prendere atto che il peccato non risiede nel corpo nudo come emblema di tentazione, ma nella repressione violenta da scardinare attraverso la perdita di una coscienza di stampo convenzionale. Quella figura che si aggira senza vestiti nei pressi del borgo dopo essersi mozzata la testa e averla poi riposizionata sul proprio collo, innescherà una vera e propria rivoluzione con la sua sola presenza: impone a chi la guarda di rispecchiarsi in quello sguardo morboso, unica e reale oscenità. È un esempio fulgido di pensiero femminista: la sua libertà è possibile grazie alla sua nudità, ma “la libertà individuale dell’atto in sé” trascina ciascuno a pensare “all’impossibilità della propria”.
Grazie a sottili sconfinamenti del grottesco nel tragico Somers offre, in particolare con le sue storie brevi, istantanee fulminanti e attuali di una società invischiata nelle proprie incongruenze.
La riscoperta oggi di Armonía Somers permette di interrogarsi sul senso del vivere e sulla direzione dell’umanità attraverso il furore di una scrittrice il cui dirompente femminismo ha contribuito a rappresentare un nuovo corso per un’idea sovversiva di letteratura, nell’audacia di temi affrontati per l’epoca (misoginia, omofobia, libertà di coscienza, aborto, relazioni tossiche, dipendenza emotiva, perversioni, repressione sessuale, ecc.), e per la singolarità di una scrittura virtuosa e brutale, poetica e terrosa, con accenti fantastici, surreali, toni da fiaba macabra, rimandi gotici e un sapiente uso del comico per definire una personale visionarietà del reale.
Ho perso la mia libertà e sono uscita.
Ho lasciato le convenzioni alle spalle, i rovi mi hanno graffiata per questo.