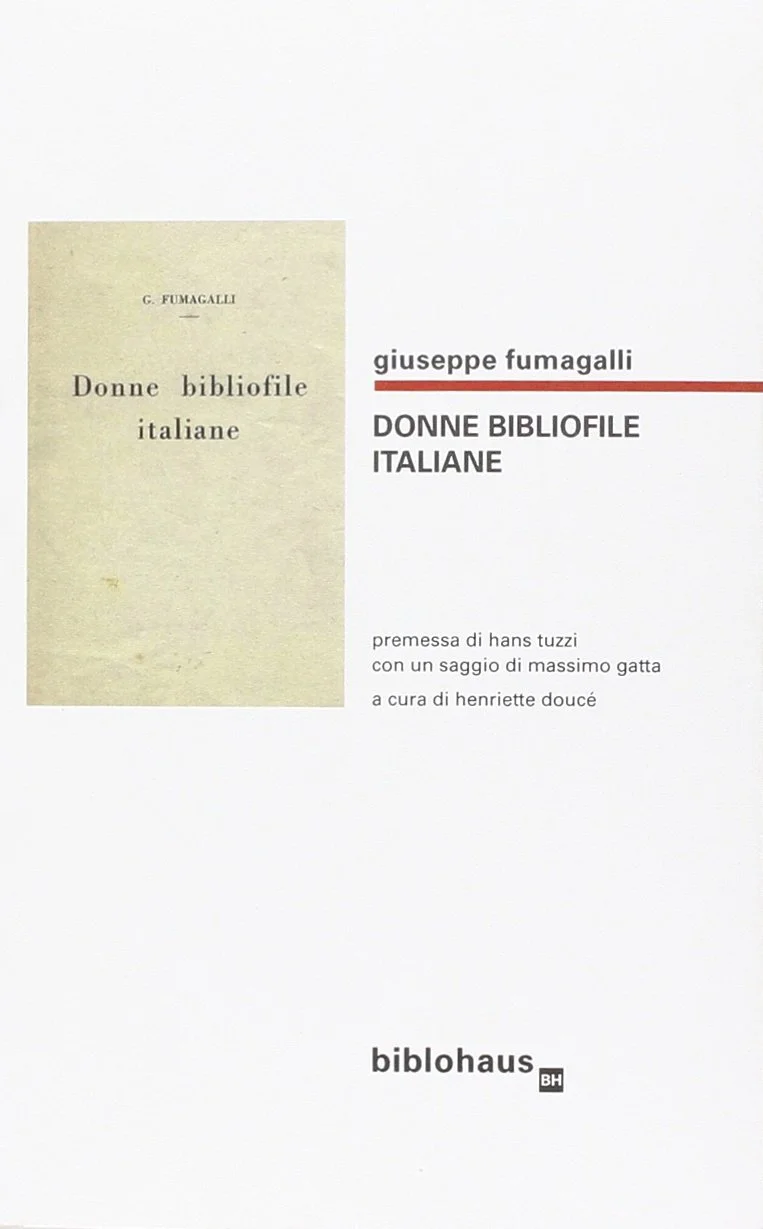di Alice Pisu
Risale al 1926 un pregevole studio pionieristico ancora di particolare rilievo per le intuizioni e le informazioni storiche racchiuse: Donne bibliofile italiane di Giuseppe Fumagalli. Il saggio indaga il collezionismo librario femminile offrendo notizie biografiche perlopiù su nobili, ma anche badesse, cortigiane, a partire dagli inventari delle loro biblioteche. Un’analisi fondamentale anche nel porre l’accento sulle difficoltà avute per secoli dalle donne ad accedere al collezionismo librario, per limiti dovuti ai ruoli socialmente imposti in merito alla cura della famiglia e per la mancanza di autonomia economica. Quell’intento di dare legittimità per la prima volta a una significativa presenza femminile a lungo ignorata nella storia della bibliofilia italiana risuona oggi nel sesto volume dei Quaderni dell’Aldus Club a cura di Francesca Nepori, edito da La nave di Teseo.
Donne che amano libri è un saggio corale concepito come un’esplorazione storiografica, sociale, letteraria che restituisce ritratti dal Settecento a oggi con una sezione dedicata a storie, aneddoti, curiosità, retroscena sui mestieri legati al libro e alla promozione della lettura con una presenza determinante di tipografe, xilografe, storiche, esperte di case d’aste antiquarie.
Con gli autorevoli contributi critici di Fabio Massimo Bertolo, Giovanni Biancardi, Gaetano Blasa, Simonetta Buttò, Antonio Castronuovo, Emilia Cerasi, Roberta Cesana, Alessandro Danovi, Gianfranco Dioguardi, Edoardo Fontana, Ludovica Gioiello, Lorenza Iannacci, Laura Lalli, Maria Luisa Eugenia Lopez-Vidriero Abello, Laura Malfatto, Elisa Marazzi, Marco Menato, Francesca Nepori, Chiara Nicolini, Maurizio Nocera, Tiziana Plebani, Fiammetta Sabba, Aristide Saggino, Silvia Scaravaggi, Elisabetta Sgarbi, Lucrezia Signorello, Paolo Tinti, Simone Volpato, Giuseppina Zappella, Paola Zito, il percorso del volume è cadenzato dalle tappe marcate dalle sue sezioni: Impromptu, Bibliofile, Lettrici e bibliotecarie, Altri mestieri, Memorie, Fuori luogo.
Il quaderno si apre con una “seducente meditazione sulla lettura e si chiude con uno sguardo negativo – come sostiene Nepori. Per secoli non pochi hanno infatti pensato che tra donna e libro non ci fosse possibilità di comprensione. E così il contributo finale, intitolato Fuori luogo, svela la figura di Octave Uzanne, uno dei tanti bibliofili vissuti a cavallo tra Otto e Novecento che hanno pensato non potesse esistere una bibliofilia femminile. “E questo finale sguardo ‘negativo’ non fa altro, infine, che rafforzare la verità: che ci sono state e ci sono tante donne per le quali il libro è motivo di passione, di studio e di lavoro”.
Il volume racchiude innumerevoli curiosità anche in merito ai mestieri diversi legati al libro con una presenza femminile rilevante rimasta a lungo nell’ombra, come nell’ambito delle tipografie antiche con straordinarie protagoniste della storia dell’editoria. Lo studio di Giuseppina Zappella riserva attenzione a tale presenza nella tradizione iconografica, sottolineando che “se il ritratto della donna nella marca tipografica è un elemento paratestuale, che ne arricchisce la valenza simbolica e autoreferenziale, anche le allegorie della Stampa privilegiano la raffigurazione femminile con immagini iconiche cariche di suggestione per le molteplici implicazioni culturali.”
Emblematica la storia di suor Isabella Piccini (nata Elisabetta) ripercorsa da Laura Lalli, che risale alla seconda metà del Seicento a Venezia. La bottega di famiglia era nota per i suoi valenti incisori e rappresentava un luogo di incontro per artisti di altre città e un’opportunità di crescita in un ambiente vivace. Alla morte del padre, Elisabetta avanzò la richiesta al doge di ottenere il privilegio esclusivo di proteggere il lavoro d’incisione. L’inevitabile vita claustrale non impedì alla giovane di dedicarsi all’arte con cui era cresciuta. In convento si ricavò uno spazio personale per incidere a bulino diventando famosa in tutta Italia e all’estero e ricercata da numerosi committenti per la sua bravura nel riprodurre originali e nel rielaborare temi e soggetti noti. La sua grande passione oltre a rappresentare una ragione di vita divenne anche la sua condanna nel limitare la sua esistenza e la sua salute fisica e mentale e nell’impedirle di accettare incarichi ambiti. Si ridusse a esercitare la professione sino a tarda età tra innumerevoli difficoltà e a morire povera e sola. La sua vicenda si rivela ancora oggi emblematica accanto a quella di altre sapienti calcografe e legatrici di libri.
Spiccano nella sezione Altri mestieri anche gli approfondimenti dedicati a xilografe femministe tra le più influenti del primo Novecento, analizzate attraverso lo studio dell’imprescindibilità di arte e vita, della natura eclettica e del ruolo nelle nuove tendenze artistiche dell’epoca.
Tra gli aspetti pregevoli del volume Donne che amano libri la scelta di adottare una molteplicità di sguardi trasversali per ridefinire scenari e visioni stereotipate. Emergono interessanti notizie riguardanti bibliofile come Madame du Barry, contessa favorita di re Luigi XV che diede un preciso marchio stilistico alla nuova biblioteca con una presenza significativa di libri scritti da donne per altre donne. Il suo caso è emblematico per i pregiudizi che accompagnarono per lungo tempo la vicenda di una figura storica a lungo ritenuta un’illetterata.
Molti ritratti di bibliofile principiano dalle peculiarità delle loro biblioteche che evidenziano la capacità di intuire le tendenze colte dell’editoria collezionando volumi dalle legature di pregio e titoli insoliti. La biblioteca di Anna Pieri, ad esempio, attesta il ruolo culturale di una figura dalla personalità cosmopolita attorno a cui si riuniva un animato salotto intellettuale, promotrice letteraria e musicale con un orientamento politico marcato anche dalle scelte di lettura. L’inventario compiuto dopo la sua morte ha permesso di ricostruire preferenze e piccole ossessioni, con opere pregevoli come la prima edizione dell’Encyclopédie di Diderot e d’Alembert, in trentatré volumi in folio.
Numerose bibliofile si distinsero nel panorama culturale dal Quattrocento in poi, ma solo recentemente gli studi in merito hanno riservato attenzione a tali figure femminili, soprattutto collezioniste che furono le committenti di volumi di pregio. È interessante chiedersi anche quale tipo di rapporto avessero con i libri le donne che non erano di estrazione nobile. Le difficoltà giuridiche e sociali con cui dovevano scontrarsi per accedere al regime proprietario dei beni era un aspetto non secondario se si considera, come sottolinea Tiziana Plebani, che neppure le donne sposate potevano utilizzare liberamente le risorse della propria dote, amministrata dai mariti. In molti casi i libri reperiti nei cassoni datali erano un’eredità materna, tra operette devozionali, cronache, romanzi, manuali sanitari, spesso non destinati alla conservazione e neppure inventariati se privi di legature di pregio. Una ‘galassia scomparsa’ che ha reso difficile ricostruire il rapporto delle donne comuni con i libri.
Intriganti le scoperte in merito alle ‘honeste cortigiane’ che a differenza delle comuni meretrici erano raffinate esperte di libri e musica, sapevano condurre conversazioni colte per gentiluomini intellettuali. Usavano la lettura come strumento di seduzione e simbolo culturale, sapevano far di rima e suonare diversi strumenti musicali, aspetti che le rendevano stimate e apprezzate socialmente. Plebani si sofferma su alcune delle loro storie a partire dall’inventario dei loro beni. Spiccano le vicende di Imperia Cognati, nata nel 1486 a Roma, figlia di una cortigiana, madre a quattordici anni e con alta probabilità amante di Raffaello. Nella sua casa vennero rinvenuti una cetra e numerosi libretti volgari e latini riccamente adornati. Tra i beni di un’altra cortigiana, Giulia Leoncini, oltre a oggetti d’arte e gioielli, risaltano volumi antichi tra cui I Trionfi di Petrarca con la pregiata legatura di sciamito che rivelava un gusto preciso e particolarmente raffinato.
L’opera attraversa epoche diverse compiendo anche un significativo affresco sociale, in relazione a mutamenti determinanti in merito a diritti e nuove possibilità di affermazione per le donne. In particolare l’Ottocento segnò un momento di svolta per la bibliofilia femminile, anche grazie alla possibilità di raggiungere maggiori livelli di istruzione rispetto al passato che favorirono anche un coinvolgimento più significativo nelle questioni politiche e sociali. La fine del secolo marcò anche nuove tutele per le donne e maggiore facilità di accesso a professioni rimaste a lungo ad appannaggio maschile, come il settore bibliotecario. Simonetta Buttò ripercorre alcune storie esemplari di bibliotecarie impegnate nella salvaguardia del patrimonio bibliofilo con una chiara scelta culturale e politica, spesso in aperto contrasto con direttive generali.
Furono numerose le azioni di resistenza occulta in favore degli antifascisti e dei perseguitati praticate da molte bibliotecarie da Nord a Sud. Tra gli esempi più alti quello di Guerriera Guerrieri: la sua azione di tutela della biblioteca e dei suoi beni prese forma anche nel convinto impegno antifascista già prima di essere nominata, nel novembre del 1942, soprintendente alle biblioteche della Campania e della Calabria e, nel 1943, direttrice della Biblioteca nazionale di Napoli. In una situazione emergenziale prese decisioni fondamentali dedicandosi alla ricostruzione della Biblioteca, alla creazione di una rete fra le autorità civili e militari, alla gestione delle casse di libri disseminate nei vari rifugi della regione, con un’identificazione totale, come sottolineato da Buttò, con la vita delle istituzioni della cultura. Si devono a Guerrieri anche innovazioni fondamentali come l’elaborazione delle norme catalografiche, la catalogazione dei periodici, le attività pubblicistiche e le azioni di promozione del libro e della lettura. Una figura attuale e moderna, come la definisce Fiammetta Sabba, per le nuove prospettive documentarie e informative a cui aprì la strada ma anche per la tenacia e l’abnegazione con con cui portò avanti il suo servizio scontrandosi con difficoltà dovute al suo essere una donna.
Tra le altre grandi storie di impegno civile quella di Anna Saitta Revignas che nell’agosto 1944 a Firenze disobbedì all’ordine di sfollamento della zona dei lungarni impartito dai tedeschi per difendere il patrimonio librario, o quella di Teresa Motta che in Basilicata rappresentò un coraggioso punto di riferimento per i confinati politici, gli antifascisti, i socialisti, gli ebrei. Motta organizzò una rete di assistenza per gli studiosi internati tra il 1941 e il 1943 che garantiva un supporto concreto per lo studio e la ricerca favorendo anche occasioni di confronto tra oppositori politici nonostante i divieti del regime. Storie che, come sottolineato da Buttò, rivelano la nascita di un modello femminile fondato su un saper fare acquisito sul campo, un’interpretazione nuova della professione bibliotecaria.
Sulla capacità di visione, il volume annovera numerose storie di intellettuali che definirono un netto cambio di passo anche attraverso le realtà a cui diedero forma. È il caso, tra gli altri, di Carla Marzoli, che fondò e diresse per decenni la libreria La Bibliofila (inaugurata nel 1945 a Milano) e Edizioni della Chimera. Concepì un’idea di libreria come spazio intimo di confronto con la fruizione di pregiati volumi d’arte dallo sguardo internazionale, pensò a ogni dettaglio affidandosi all’architetto Renzo Mongiardino che rese gli ambienti confortevoli e stravaganti secondo un percorso di avvicinamento al libro inteso come oggetto d’arte. Definita da Fabio Massimo Bertolo un gigante nel mondo della bibliofilia del dopoguerra, Marzoli si rivelò anche una raffinata studiosa che operò nell’ambito della promozione culturale dichiarando apertamente il suo antifascismo con progetti e visioni basati su un’interconnessione tra ambiti diversi – il teatro, l’arte figurativa, la letteratura – nell’intento di ‘sprovincializzare’ l’arte italiana.
Nel percorso storico, letterario e artistico di Donne che amano libri colpisce il ruolo avuto da personalità complesse nella crescita e nella tutela del patrimonio culturale del Novecento, come Giannalisa Gianzana Feltrinelli. Il suo primogenito Giangiacomo la ricordò come una figura dominante e energica con cui fu in netto contrasto per le idee politiche (lui aderì alla Resistenza e poi al Partito comunista, lei si schierò per la monarchia). Come sottolineato da Roberta Cesana, Giannalisa non fu promotrice e sostenitrice dell’ascesa intellettuale e politica del figlio ma garante dell’eredità famigliare. Di altissimo valore centinaia di volumi rari e preziosi, testimoni di secoli di storia tipografica, culturale e artistica italiana e europea che finirono in collezioni diverse con sette aste tra New York, Londra, Roma, Parigi. La parziale dispersione della biblioteca di Giannalisa Feltrinelli rappresentò, come ricorda Cesana, un passaggio fondamentale nella storia del collezionismo librario europeo, oltre che un esempio alto di biblioteca intesa come spazio narrativo e collezionistico.
Tra curiosità bibliofile e aneddoti su retroscena sconosciuti, approfondimenti sulla complessa filiera del libro, panoramiche sugli stravolgimenti sociali, letterari, artistici, politici e culturali, memorie e ritratti di visionarie capaci di progettare rivoluzioni culturali e favorire una sperimentazione nella promozione della lettura, con Donne che amano libri emerge un affresco vivace sulla bibliofilia femminile che invoca un cambio di passo negli studi di settore, in virtù della necessità di ridefinizione di un assetto miope, a predominanza maschile, per indagare un fenomeno composito e sorprendente.