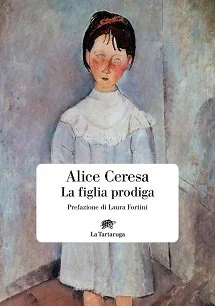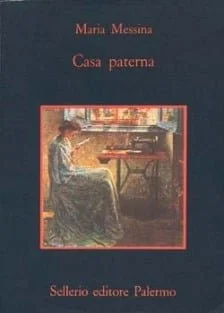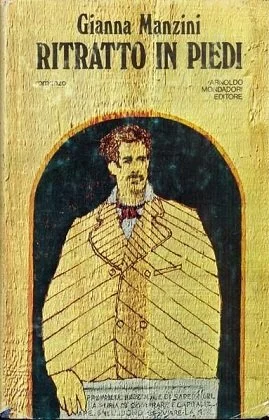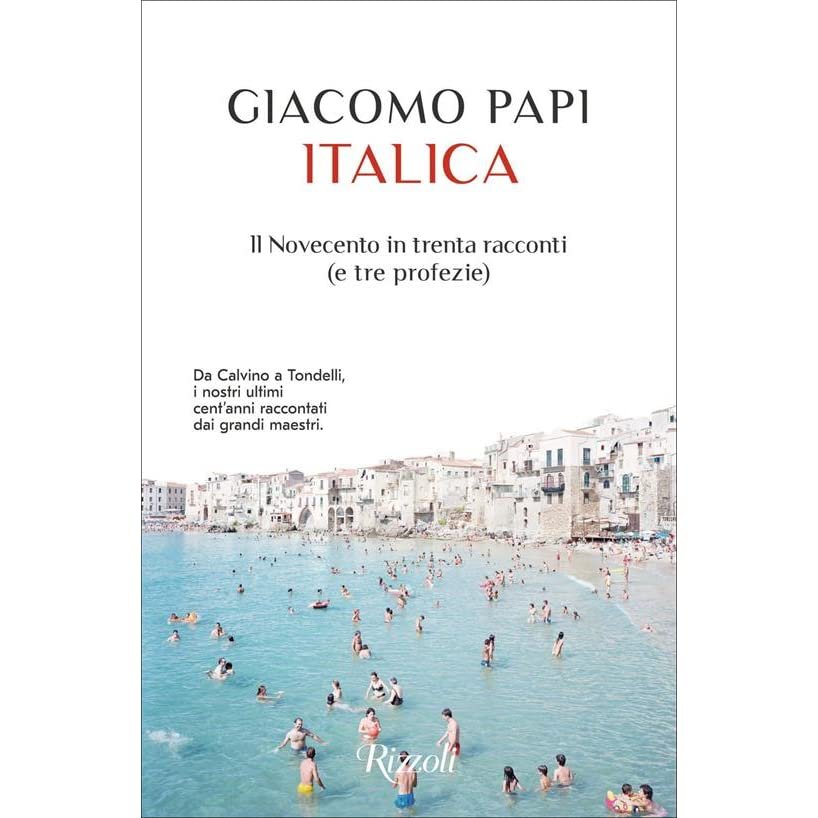UN GIORNO
di Paola Drigo
Durante le vacanze, in settembre, il giorno di Maria, per immutabile consuetudine noi ci recavamo a festeggiare l'onomastico della nonna nella sua casa di campagna a R., sulle rive del Brenta. Durante le vacanze, in settembre, il giorno di Maria, per immutabile consuetudine noi ci recavamo a festeggiare l'onomastico della nonna nella sua casa di campagna a R., sulle rive del Brenta.
Si partiva di buon mattino per evitare il caldo e perchè il viaggio era lunghetto: una ventina e più, di chilo metri in pianura. Si partiva di buon mattino per evitare il caldo e perchè il viaggio era lunghetto: una ventina e più, di chilo metri in pianura. E siccome la ferrovia non arrivava in quel remoto an golo di provincia, e quelli eran tempi antichi nei quali non usava ancóra nè automobile nè aeroplano, si partiva patriarcalmente in carrozza, pigiati come sardine, papà, mamma, e noi quattro bambini.
E siccome la ferrovia non arrivava in quel remoto an golo di provincia, e quelli eran tempi antichi nei quali non usava ancóra nè automobile nè aeroplano, si partiva patriarcalmente in carrozza, pigiati come sardine, papà, mamma, e noi quattro bambini.
A cassetta stava Antonio, il domestico, colle sue orecchie ad ansa, impettito; compreso dell'importanza dell'avvenimento, e con un solino più alto del consueto.
Cincinnata, la cavalla grigia, che per il suo trilustre soggiorno in casa nostra, conosceva ormai le abitudini e le tradizioni di famiglia, quando sentiva caricare nella carrozza scialli e mantelli, e soprattutto quando vedeva salire noi quattro l'uno dietro l'altro, con un mazzo di fiori in mano, capiva subito che non si trattava di una breve corsa per condurci a scuola o a pigliare il fresco, ed invece di mostrarsi allegra dei suoi bei finimenti rimessi a nuovo, abbassava la testa e allungava il collo con aria malinconica e demoralizzata.
Ognuno di noi bambini portava adunque alla nonna il suo mazzo di fiori: – non grande, rotondo, contornato di carta smerlata e traforata; – e lo portava in mano, ricusando accanitamente di deporlo nel cestino apposta preparato.
Ciascuno di noi aveva l'ambizione di presentarle il più bello, e sui pregi e sulle benemerenze di ogni singolo mazzo, le discussioni e i litigi duravano a lungo, accendendosi e riaccendendosi fino all'istante di partire, per cessare immediatamente non appena la carrozza si metteva in moto.
Allora la strada ci prendeva, col fascino dei suoi aspetti e dei suoi incidenti, con le sue vicende previste ed impreviste.
Ora si allungava diritta fra le siepi, ora si snodava varia e irregolare per la bella campagna settembrina ben lavorata, pettinata, coi vigneti carichi d'uva; e qui ci interessava un albero storto che protendeva grottescamente le braccia dal ciglio del fossato, là un porcellino che sbucava da un cortile come impazzito correndo a zig zag e cacciandosi quasi tra le zampe della Cincinnata; più giù, un somaro che, al nostro passare, sventolava le grandi orecchie mandando un raglio.
Dapprincipio, data l'ora mattutina, si incontrava poca gente: appena qualche lattaia che tornava dalla città coi suoi secchi di rame lucidi e cigolanti; ma, andando, la strada si animava; si attraversavano paesotti e paesini, e come era giornata di festa, Antonio ogni momento doveva mettere la Cincinnata al passo per fendere la folla contadina che sostava nelle piazze, dinanzi alle trattorie, o nei pressi delle chiese. Donne, uomini, ragazzi, che pareva non avessero occhi nè orecchi, e si facevano quasi metter sotto, prima di dar posto, malgrado i decisi e ripetuti: – Ohe! Ohe! – coi quali Antonio dall'alto del suo seggio annunciava dignitosamente il nostro arrivo, non certamente fulmineo.
Quando quelli poi si decidevano ad udire, sbandavano bruscamente, e stavano a guardarci a bocca aperta come avessero visto una cosa straordinaria, oppure, adocchiando le grandi orecchie dell'auriga, ci gridavano dietro: – I va a vela!... – e sguaiatamente ridevano.
Quello spettacolo ci divertiva assai, sulle prime; poi, col procedere del viaggio, finiva per non interessarci più e quasi per annoiarci.
La panchina era dura e stretta; il caldo si faceva sentire; i miei fratelli specialmente, che nella loro qualità di maschi erano più indocili ed impazienti, incominciavano a dimenarsi, buttar le gambe di qua e di là.
Innocente o malizioso, volava qualche calcio, seguito da infinite doglianze e recriminazioni. I quattro mazzi di fiori, dianzi tenuti con la precauzione e il rispetto con cui si sarebbe tenuta la reliquia d'un santo, erano alquanto bistrattati, e con lo smerlo discretamente sgualcito.
Allora, per rimettere un po' di disciplina nella comitiva, mio padre, che era con noi molto buono e paziente, ci offriva di raccontarci una storia.
Noi accettavamo con entusiasmo, battendo le mani e gridando, e, a quei rumori incomposti, la Cincinnata drizzava le orecchie e si metteva a trottare più in fretta. Le storie che ci raccontava mio padre, brevi o lunghe che fossero, erano sempre molto belle, ed ora, ricordandone taluna, penso che egli aveva una fantasia nell'inventare, ed un'arte nel raccontare, quali pochissimi posseggono. Anche la sua voce era bella; calda, armoniosa, varia di tono, e piacevolissima ad udirsi. Quando raccontava cose liete, i suoi occhi erano talvolta allegri e limpidi come quelli d'un fanciullo. Ma allora, io m'interessavo soltanto all'intreccio, al fatto, e non badavo ad altro; e con me si divertivano i miei fratelli che, interrotte le beghe, ascoltavano a bocca aperta. Con questi espedienti e trattenimenti, senza troppi disastri, si giungeva in vista del campanile di R., e lemme lemme, si entrava finalmente in paese. Con questi espedienti e trattenimenti, senza troppi disastri, si giungeva in vista del campanile di R., e lemme lemme, si entrava finalmente in paese. Qui si capitava in piena baraonda, chè R. festeggiava il nome di Maria con una fiera grandiosa, la fiera più importante dei dintorni, che richiamava gente in folla da tutta la provincia.
Nuovamente, bisognava rimettere la Cincinnata al passo, proprio adesso che, povera bestia, sentendo la scuderia vicina, avrebbe avuto voglia di andare al trotto; ed era necessaria tutta l'abilità di Antonio per destreggiarci in quella baraonda, – fra le baracche, i veicoli, i banchetti di ciambelle e di zucchero filato, le giostre coi cavallini impennati, le barche volanti che avevano tutta l'aria di volarci sulla testa, i cocomeri ammonticchiati fin quasi in mezzo della strada. Com'era bella quella fiera, ai miei occhi di bambina!... Quel giorno, quasi in mezzo della piazza, l'uomo serpente aveva disteso la sua stuoia, e, fra un esercizio e l'altro, arringava la folla: era un uomo calvo, quasi vecchio, con una maglia verde stinta, e una gran bocca che, non so perchè, pareva nera. Un po' più in là, l'indovina con gli occhi bendati, issata su di un tavolino, teneva i suoi responsi e vendeva i «pianeti». Sotto gli ippocastani, un circo equestre aveva piantato la sua tenda coperta di cartelloni multicolori, e alle finestrelle del carrozzone si affacciavano visi sudici e teste scarduffate di fanciulli dai grandi occhi. Due cavalli magri brucavano l'erba polverosa dietro la chiesa. In mezzo a quel dedalo d'improvvisate architetture, ai mazzi di palloncini colorati, a quel gridìo, a quel frastuono di tamburi, trombe, trombette e fischi, noi passavamo abbagliati e frastornati come attraverso a una scena fiabesca.
La casa della nonna era dalla parte opposta a quella da cui eravamo venuti, un po' fuori del paese, e, per giungervi, dopo aver attraversato l'abitato, bisognava la sciar dietro a noi tutto il movimento e lo schiamazzo della fiera, per riprendere un breve tratto di strada di campagna, ed entrare si può dire in un altro mondo. E in un altro mondo ci pareva d'entrare veramente, quando, con una magistrale voltata, la carrozza, appena internatasi per una stradetta secondaria, oltrepassava un cancello, ed entrava nel giardino; un giardino quadrato, un po' in ombra, cinto da un muro alto, dove ingenui fiori dai nomi antiquati, – le portaluche, gli astri, gli amorini, le porcellane, le salvie, – variegavano le aiuole. In fondo a quel giardino, la casa non antica nè moderna, – vecchiotta – distendeva la sua facciata solida e semplice dalle ampie finestre regolari.
C'era un gran silenzio; e certe erbe grasse dalle foglie carnose, che parevano sempre umide, crescevano intorno al pozzo. Al nostro arrivo, trovavamo generalmente due altre carrozze che ci avevano preceduto, e di cui si erano già staccati i cavalli; quella della zia Giulia e della zia Norina, che villeggiavano nei dintorni, e non mancavano mai di venire in quel giorno a pranzo dalla madre, insieme ai mariti ed ai figli. In giardino non c'era più nessuno, tranne i cocchieri che, approfittando della disattenzione generale, si erano messi in maniche di camicia, e fumavano la pipa seduti sotto un albero.
Noi gettavamo un'occhiata inquieta ai nostri fiori che erano in uno stato pietoso, ma ci consolavamo tosto ricordando che la nonna, in fondo, quei mazzi li prendeva senza quasi guardarli, e li passava subito alla zia Luisa perchè li mettesse nell'acqua; eppoi, se eran brutti e avvizziti in confronto a quelli dei cugini, avevano l'attenuante della strada più lunga, sotto il solleone. E mentre la mamma ci dava qualche buffetto sulle vesti per scuoterci di dosso la polvere, ecco la zia Luisa affacciarsi all'uscio della sala terrena, e venirci incontro rapida per il vialetto fiancheggiato dalle siepi di bosso.
Delle quattro figlie di mia nonna, la zia Luisa era la maggiore: non più giovane, ed ancora zitella. A me anzi sembrava già vecchia, ma, se ripenso al giorno di cui scrivo, non doveva allora aver toccato i quarant'anni. Ella ci veniva incontro socchiudendo gli occhi, perchè era molto miope; aveva delle bellissime trecce di un biondo spento, senza riflessi; ed un viso dai lineamenti piuttosto fini e delicati. Non sarebbe stata brutta, se la figura eccessivamente, straordinariamente alta ed esile, non avesse attirato su di lei l'attenzione, e direi quasi la sorpresa, di chi la guardava. Non ho mai veduto nè allora nè poi, una donna così alta.
E credo che quella sua statura fuor del comune rappresentasse l'infelicità, o meglio una delle infelicità, del la sua vita, e cercava di dissimularla come meglio poteva, camminando un po' curva, colle ginocchia piegate, colle scarpe senza tacco. Malgrado questi accorgimenti, quando usciva per le strade, anche di città, tutti si voltavano a osservarla, e la gente del popolo, specialmente, le diceva dietro barzellette e commenti che l'offendevano e l'intimidivano, ed avevano contribuito a rendere il suo carattere malinconico e scontroso. Povera zia Luisa.... Per me, ella aveva una speciale predilezione, ed ora che son passati tanti anni e vedo le cose con un diverso sentimento, ho rimorso di averla ricambiata così male, e quasi con ingratitudine, sfuggendola quando potevo, e annoiandomi mortalmente con lei.
Eppure, ella era gentile d'animo, coltissima, intelligente; ma le mancava qualche cosa: forse il sorriso, la gaiezza, – chi sa?... – forse il calore che ispira e comunica la simpatia.
Basta; quel giorno ella ci veniva adunque incontro, mi par di vederla, – vestita di lilla, che era il suo colore preferito; un po' piegata su se stessa e protesa in avanti, emergendo tuttavia altissima e sottile dalle siepi brune, come un pioppo che camminasse ondeggiando. Baciava mia madre, stringeva la mano a mio padre, salutava i bambini; poi mi passava affettuosamente un braccio intorno al collo, – io mi sentivo piccola come una formica al suo fianco!... – e ci scortava verso la casa. Ma non ne avevamo ancora raggiunta la soglia, che, chinata su di me la sua lunga persona, mi sussurrava all'orecchio in tono di mistero – ...Ti occorre?... Io mi svincolavo sdegnosamente dal suo braccio; mi sentivo offesa e oltraggiata come se mi avesse accusata di furto e di rapina.
Rispondevo precipitosamente, arrossendo fino agli orecchi: – No, no no! – e correvo avanti, piantandola lì. Ma, colla coda dell'occhio, vedevo benissimo che ella ripeteva la stessa manovra coi fratellini, ed essi, più vili o più docili, la seguivano pecorescamente su per le scale, fino a un certo posticino, di dove ridiscendevano in fretta per essere ammessi alla presenza della nonna.
Della nonna, pur volendole bene, noi avevamo tutti grande soggezione. Forse perchè la vedevamo poco, e quel poco, sempre in circostanze, per così dire, solenni, e senza intimità. Con noi bimbi era molto buona, ma di una bontà un po' fredda e sostenuta, e se non rammento di lei il minimo atto d'impazienza, la minima ingiustizia o parzialità, non riesco neppure a rammentare che mi abbia mai preso sulle ginocchia e baciato e consolato come le nonne sanno fare. Aveva insomma in sè qualchecosa che ispirava il rispetto e anche l'affetto, ma escludeva la tenerezza. Quando noi entrammo quel giorno, ella stava nella sala grande a pianterreno, nella sua solita poltrona presso alla finestra, e forse perchè quella poltrona posava su di un largo gradino rialzato, dava l'idea di una specie di trono intorno a cui i dignitari e i vassalli, in ordine di grado e d'importanza, si schierassero in attesa di far atto d'omaggio.
La nonna infatti, su quella poltrona ad alta spalliera, più bella e più grande delle altre, e che le dominava tutte, pareva davvero una regina che tenesse circolo. Le figlie, i generi, i nipoti, le erano seduti intorno, ma era lei che dirigeva la conversazione, e nessuno avrebbe osato interromperla o contraddirla, e tanto meno muoversi senza il suo permesso.
Ella, che era stata bellissima, aveva anche da vecchia grande cura di sè, ed era sempre ben vestita, e, se di persona s'era un po' incurvata ed ingoffita, aveva conservato un profilo puro, splendenti occhi neri, e delle belle mani che metteva in mostra con una certa civetteria. Quel giorno, io dovevo dire la poesia francese: «La grande ânesse». Come e perchè, per festeggiare l'onomastico della nonna, dovessi raccontarle in francese le vicissitudini, le amarezze e le glorie della Grande ânesse, non lo so; e forse mi sembrava strano anche allora, ma la verità è questa. Dovevo recitare la poesia con bella pronuncia e senza gesticolare: da un mese la maestra me la faceva ripetere ogni giorno con inesorabile pazienza. Mi misi in mezzo alla sala col mio gonnellino rosa ben largo, il mio mazzolino di fiori in mano, e incominciai:
La grande ânesse..
Evitavo di guardare dalla parte dei miei fratelli e cugini perchè non mi succedesse di interrompermi o di ridere se l'uno o l'altro di loro mi avesse fatto di soppiatto una smorfia; guardavo adunque deliberatamente da un'altra parte, quando incontrai gli occhi della zia Luisa che stava un po' fuori del gruppo dei parenti, con le spalle addossate ad una libreria di legno scuro.
Il suo viso era, come di solito, sbiadito e senza luce, ma gli occhi suoi, che mi fissavano, avevano un'espressione di grande malinconia. Pareva che quegli occhi mi dicessero: – Perchè sei anche tu così cattiva con me?... Non sai che nessuno mi vuol bene? Sì; c'erano proprio queste parole nei suoi occhi. Ne fui colpita, ed ancora adesso me ne ricordo con una stretta al cuore, ma si è tanto crudeli ed egoisti quando si è bambini, che allora non vi badai più che tanto, e tirai giù in fretta gli ultimi versi della Grande ânesse, senza più guardare la zia, preoccupata solo di finir presto. Entrava il domestico ad avvertir che era pronto; e tutti passavamo con un respiro di sollievo nella sala da pranzo.
Splendidi erano i pranzi della nonna; serviti su piatti contornati da un filino verde e oro; con bicchieri di diversa grandezza, che per noi però rimanevano costantemente vuoti. C'era il pesce; un pesce così grande che da noi fanciulli era ritenuto senz'altro un pescecane; argenteo fra ciuffi di prezzemolo, con una fettina di limone in bocca; poi, sformati di varie fogge, e capponi arrosto meravigliosi, dorati, rosolati; e torte, e frutta d'ogni sorta. Fra grandi e piccini formavamo una tavolata rispettabile.
Come in una grande tela fiamminga, rivedo i commensali di quel pranzo come fossero in quest'istante dinanzi a me, intorno a quella candida tovaglia, fra le alzate di frutta e le coppe di vin d'oro, col vestito, col sorriso, con l'atteggiamento, che avevano in quel giorno. Era un quadro lieto e luminoso perchè riuniva intorno a mia nonna la famiglia nell'ora sua più bella e più piena, quando è a un tempo realtà e speranza, presente e avvenire, non offuscata ancóra dalla malinconia dei ricordi, dei rimpianti, delle delusioni. Certo, ogni figura di quel quadro portava in sè, colla sua luce, anche la sua ombra, e l'ombra del suo destino; e quell'ombra più tardi avrebbe forse soverchiato di gran lunga la luce, ma, quel giorno, nessuno se n'accorgeva, chè le donne eran giovani e belle, gli uomini nel fiore dell'attività e dell'intelligenza, i fanciulli sani e spensierati.
Ecco la nonna e le sue quattro figlie: la zia Giulia vestita di rosso, bruna come una creola, non bella, ma vivacissima, con un corpo stupendo; occhi che ridono e lampeggiano; mia madre alta, fresca, serena; la zia Norina, incinta, col viso un po' sfiorito eppure bellissimo, il luminato da grandi occhi grigi. Bella come la nonna era la zia Norina, ma con una dolcezza di sorriso ed una spiritualità d'espressione che la nonna non aveva. E benchè da bimbi si sia troppo distratti e irrequieti per fermare l'attenzione sulla bellezza di un viso umano, pure la bellezza della zia Norina era tale, che m'incantavo talora a contemplarla con inconsapevole gioia. tale, che m'incantavo talora a contemplarla con inconsapevole gioia. La zia Luisa, seria e rannuvolata sotto il diadema delle trecce smorte, stava in coda alla tavola, in mezzo alla marmaglia di noi fanciulli.
A destra della nonna siede lo zio Francesco, con la sua gran barba da frate e lo sguardo buono e mansueto. Lo zio Francesco insegnava filosofia all'Università di N., ed era uomo di grande dottrina ed anche di liberi spiriti, ma da giovinetto era stato destinato alla carriera ecclesiastica ed aveva trascorso alcuni anni in Seminario: di quegli anni un'impronta gli era rimasta, un'impronta indefinibile, come una lievissima sfumatura che non so precisare, ma si sentiva tuttavia. Sua moglie, la zia Giulia, lo dominava e lo tiranneggiava ed accanto a lei egli sbiadiva alquanto, parlava poco, e faceva l'effetto d'essere timido. Ecco lo zio Alvise, il marito della zia Norina, che alza il bicchiere e ride.
Piccoli e penetranti sono i suoi occhi, e benchè di nobile prosapia e laureato in legge, ha egli piuttosto l'aspetto di un fattore di campagna, un po' trasandato nel vestire, acceso in faccia, propenso agli scherzi e alle barzellette. Intrattiene la brigata con molto spirito, se si può desumerlo dall'attenzione con cui è ascoltato, e dal buonumore che suscita in tutti, tranne in sua moglie. E fra tutte queste immagini, più o meno belle, più o meno liete, rivedo il volto di mio padre, pallido, incorniciato dai capelli nerissimi; quel volto di nobiltà e di pensiero, la fronte alta e gli occhi indimenticabili; quel volto, che il mio occhio infantile cercava di continuo con sentimento di adorazione e di tenerezza infiniti. Senza rendermi conto del perchè, intuivo la superiorità di mio padre, e ne ero orgogliosa; e non soltanto la superiorità fisica, ma la superiorità della sua intelligenza, del suo animo, e del suo carattere. Nello stesso tempo, dalla sua presenza mi veniva un senso di sicurezza che non mi sapevo spiegare, ma che era vivissimo e profondo.
Forse egli sentiva la mia adorazione, – religiosa, in condizionata, assoluta; – ed i nostri sguardi s'incontrava no di frequente, chè io non staccavo gli occhi da lui, e, se parlava, dimenticavo di mangiare per ascoltarlo, con la forchetta a mezz'aria e la bocca semiaperta, ed egli, accorgendosene, mi sorrideva con grande dolcezza. Dicono che gli assomigliassi molto; ma io non ero allora che una bimbetta brutta, magrolina, pallida, con una lunga treccia e delle lunghe gambe. E forse neppur più tardi ho mai avuto negli occhi e nella fronte quella luce così viva di pensiero, e quel sorriso così aperto che conquistava gli animi senza bisogno di parola. Durante il pranzo, la zia Luisa sovraintendeva alla nostra disciplina, e lo faceva, – com'era del suo temperamento – con scrupolosa attenzione ed eccessiva pedanteria.
Non eravamo ancora seduti, che organizzava una specie d'interrogatorio sugli studi, sui maestri, sulla villeggiatura. Le sue domande erano monotone, professorali, senza la vivacità e la camaraderie che le avrebbero rese tollerabili.
Dapprincipio noi rispondevamo distratti, con esattezza molto relativa; dall'arrosto in poi, non rispondevamo più affatto, preoccupati soltanto del dolce che doveva arrivare, delle frutta che l'avrebbero seguito, del maraschino di cui forse una gocciolina la nonna avrebbe acconsentito a lasciar versare nei nostri bicchieri. Alla fine del pranzo ci scambiavamo dei piccoli calci sotto la tavola, ridevamo nervosamente senza sapere perchè. Pur avendo bevuto solo acqua, ci sentivamo un po' ebbri, eccitati, e proclivi a litigare e a dire sciocchezze. Finalmente la nonna faceva il cenno augusto che ci regalava la libertà.
Allora, ci gettavamo giù dalle sedie; raggiungevamo,– ipocritamente compunti –, l'uscio del salotto, e, appena fuori, ci sbrigliavamo come puledri. La zia Luisa rimaneva in coda alla tavola, in mezzo alle sedie vuote. Noi ci affacciavamo tosto all'uscio della cucina per spiare se Antonio e Nale, incaricati di accompagnarci a fare un giro per la fiera, avevano finito di pranzare. Sul focolare, da cui era stato sfilato lo spiedo, ardeva ancóra un gran fuoco. I rami brillavano come fossero d'oro. Angela, la cuoca, ed Annetta, la ragazzina che l'aiutava, avevano il viso lustro e scalmanato.
I due vecchi erano seduti l'uno di fronte all'altro, in maniche di camicia, curvi sul piatto. Al vederci far capolino dall'uscio, all'udire i nostri eloquenti colpetti di tosse, voltavano verso di noi lentamente la testa e gli occhi grossi, come i cavalli quando veggono apparire sulla soglia della scuderia il cocchiere inesorabile che viene per riattaccarli. Ma non dicevano niente, e ripigliavano a mangiare senza affrettarsi. Quando a Dio piaceva, si alzavano e, sempre masticando, infilavano la giacca. La comitiva rumorosa e burrascosa si metteva in cammino. Antonio e Nale s'impadronivano dei quattro ragazzi più piccoli per tenerseli a mano. Nale, che era più vecchio di Antonio e serviva in casa della nonna da tempo immemorabile, zoppicava alquanto, ed aveva sul naso un'escrescenza carnosa grossa come una nocciola, che pareva un naso neonato.
Qualcuno fra i più insolenti di noi, si divertiva a domandargli: – Come mai, Nale, due nasi? Oppure: – Che odore sentite, Nale? Ed egli, senza sorridere: – Odor de putei matuséi.
I miei fratelli e cugini, che facevano parte di quella comitiva, sono sparsi oggi per il vasto mondo: uno è prefetto, l'altro ammiraglio, un terzo occupa un alto posto alla Minerva, un quarto è morto in guerra alla presa di Gorizia.
Allora, fra tutti insieme, – tre femminucce e otto maschi –, non sapevamo nulla di nulla; fra tutti insieme, allora, contavamo poco più di cent'anni.
Quel giorno, caso straordinario, io chiesi il permesso di non uscire. Mi sentivo stanca, snervata, e disposta alla solitudine. E siccome ero convalescente d'una grave malattia, il capriccio inaspettato fu accolto per buona moneta, e mi si accontentò, a condizione che mi mettessi tranquilla sul divano dello studio, magari a leggere le fiabe. Io promisi. I grandi rimasero nella sala a terreno, a parlare, a fu mare; la zia Giulia sedette al piano; la zia Norina salì a riposare. Presi un vecchio album di fotografie e mi misi a sfogliarlo. Com'erano buffe quelle facce, quegli abbigliamenti, di gente d'un altro tempo, sbiadita e dimenticata come una raccolta di fiori secchi fra le ingiallite pagine dell'album!... Un ritratto della nonna giovinetta, con la crinolina; un prete; un gruppo di famiglia; un signore seduto accanto a un tavolo, con la tuba in testa e i calzoni chiari attillati, che faceva le viste di leggere un libro; un altro prete; un bimbo nudo che sgambettava su di un cuscino...
Il mio interesse non durò lungamente. Quando fui ben certa che nessuno più si ricordava di me, rimisi l'album al suo posto, ed a passi lievi, raggiunsi l'uscita e scivolai nel giardino. Nessuno se n'accorse; non incontrai nessuno; probabilmente credevano che dormissi. Il giardino della nonna aveva sempre avuto per me un gran fascino; forse perchè lo conoscevo poco; forse perchè non assomigliava al nostro; forse perchè aveva in sè qualche cosa di sorpassato, di leggermente malinconico e di enigmatico come i chiostri dei conventi, che dava ali al sogno e alla fantasia. Mi piaceva il pozzo, con quelle erbe grasse e umide che gli crescevano intorno, con quell'acqua immobile dai riflessi verdastri che nessuno ormai attingeva più, dove il mio viso si rifletteva come in uno specchio appannato, e non mi pareva il mio viso.
Mi piacevano le siepi di bosso, fitte, compatte come muricciuoli; con quelle foglioline brune, dure e aride che, strofinate, mandavano un aspro odore. Mi piaceva il berceau di gelsomini, rotondo e riparato quasi come una casetta, sulla sommità della minuscola montagnola. E soprattutto mi piaceva quel giardino perchè era territorio proibito, dove mai, mai, m'era stato concesso di aggirarmi da sola, senza la vigilanza spietata dalla zia Luisa.
La montagnola si addossava al muro di cinta e ne pareggiava quasi l'altezza; di là, affacciandosi come a un balcone, si vedeva il brolo ampio e verde che pareva senza confini, ed anzi non era un brolo, ma un gran prato, attraversato da un piccolo corso d'acqua, chiamato la rosta.
Dove il prato era in leggero pendio, l'acqua della rosta scorreva rapida e un po' torbida. Quel giorno, lungo la rosta, una cavalla bianca pascolava col suo cavallino. Mi guardai intorno. Non c'era anima viva. Una porticina tagliata nel muro del giardino, mezzo nascosta dal la vite selvatica, comunicava col prato, ed era chiusa con un catenaccio. Discesi dalla montagnola con aria indifferente, cercando di camminare sull'erba anzichè sulla ghiaia, per non far rumore: in pochi passi fui alla porticina, tirai il catenaccio che non resistette, uscii. Ero fuori, nel gran prato senza confini. Ai miei piedi l'acqua correva fresca e rapida. Ero sola, lontana dagli occhi di tutti. Sopra la mia testa il cielo settembrino, limpido, senza ombre.
Ebbi l'impressione mai provata della libertà, della felicità, della vita. Mi misi a correre di qua e di là senza scopo, saltando le roste, immergendomi fino alla cintola nel più fitto dell'erba. In certi punti il prato era molle, quasi paludoso; e bisognava scandagliarlo con un bastoncino prima di avventurarsi a passare. Piccole farfalle gialle si levavano dall'erba. All'improvviso mi balenò l'idea di togliermi le scarpe e le calze. Certo, mi sarei divertita di più, e avrei potuto anche camminare nell'acqua della rosta. Detto fatto. Sedetti sul prato, in un posto abbastanza asciutto, ed allungai la gamba per assaggiar l'acqua, ma vi avevo immersa appena la punta dei piede, che la ritirai. Era molto fredda quell'acqua, e scorreva tanto in fretta che faceva quasi paura. Mentre stavo là perplessa, osando e non osando di ricacciare il piede nella corrente, il mio occhio fu colpito da qualchecosa che stava a pochi passi da me, sull'erba. Era la carogna d'un gatto, a zampe all'aria, col pelo irto, cogli occhi aperti.
Balzai in piedi, rabbrividendo di ribrezzo; raccolsi in fretta scarpe e calze, le rimisi nei piedi bagnati, mi allontanai a salti, dirigendomi vero la porticina del giardino. Ma ogni tanto mi voltavo; non so perchè; perchè era più forte di me; mi voltavo a guardare se quella cosa era ancora là, e se era ancora così cogli occhi aperti, colle zampe all'aria. A un tratto – come fu?... – non so; ritornai sui miei passi velocemente e mi ritrovai immobile, con gli occhi dilatati e febbrili, sul luogo di dov'ero fuggita. Forse esso non era morto... forse si muoveva ancora.... Raccolsi il bastoncino che avevo abbandonato sull'erba, e con esso, sforzandomi di rimanere sempre alla stessa distanza da quello, provai a toccarlo e a smuoverlo, riuscii a voltarlo, dall'altra parte. Indietreggiai inorridita. Un'ondata di fetore, un brulichio di vermi, la schiena ormai piagata, logorata, corrosa... E nello stesso tempo mi parve che esso, che pure era morto, si voltasse a guardarmi con quei suoi occhi vitrei, spalancati, terribi li, e mi dicesse: – Tutti dobbiamo morire: tutti. Anche tu, anche tu. guardarmi con quei suoi occhi vitrei, spalancati, terribi li, e mi dicesse: – Tutti dobbiamo morire: tutti. Anche tu, anche tu. Allora, come pazza, mi misi a correre, coi capelli dritti sul capo, tremando da capo a piedi, gettando urli laceranti.
In casa in quel frattempo dovevano essersi accorti della mia assenza, e correvano di qua e di là, chiamandomi, cercandomi, inquieti e angosciati. Vidi affacciarsi alla porticina del giardino la figura di mio padre, pallido, e la sua testa toccava quasi l'architrave; caddi fra le sue braccia, piangendo dirottamente, battendo i denti convulsa, avvampando di terrore e di febbre. Non riuscivano a capire di che si trattasse. Avevo perduto una scarpa; vedevano che ero bagnata, infangata, sudata e fredda. Mi misero a letto; deliravo; e per un mese fui tra la vita e la morte. Nel delirio imploravo – mi dissero poi, – come dibattendomi con angoscia da un invisibile nemico: – Non voglio! Non voglio!..
Quando, finalmente guarita, mi chiesero il perchè delle mie lagrime, dei miei urli di quel giorno, il perchè, in fine, della mia disperazione e del mio terrore, io non volli mai dir nulla, neppure a mio padre. No; non potevo parlare di quello che avevo veduto. Ma tutta la mia infanzia fu dominata da quella rivelazione; e solo più tardi, molto più tardi, riuscii a dare al mistero della morte un senso diverso, ed una immagine meno orrendamente sconsolata.