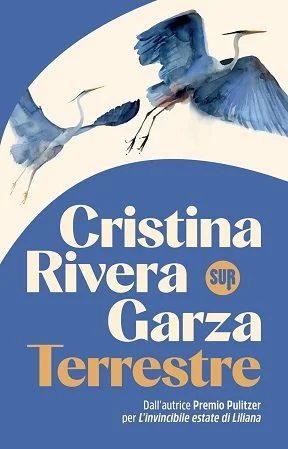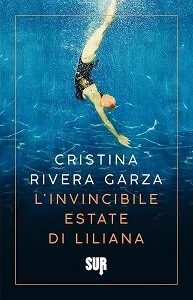di Alice Pisu
Con Terrestre (trad. Giulia Zavagna, SUR) Cristina Rivera Garza esplora le nuove frontiere della forma breve tra continui esperimenti di ridefinizione del passato e del futuro per coltivare una prospettiva plurale e decolonizzare lo sguardo. Il viaggio è lo strumento d’elezione per tornare all’infanzia, per evadere da contesti asfittici, per fantasticare sull’enigma dell’ignoto. La presenza ricorrente di giovani donne che in contesti diversi attuano continue sfide al sistema patriarcale definisce il tentativo di conquistare la libertà da ogni vincolo e emanciparsi dall’oppressione. Ogni pagina misura la necessità di scardinare il noto e al contempo celebra le potenzialità dell’immaginario come esempio di alta letteratura.
Ritenuta tra le voci più autorevoli del panorama intellettuale messicano contemporaneo, Cristina Rivera Garza definisce nella sua intera produzione un itinerario in continua evoluzione, retto sull’interconnessione di generi e le sperimentazioni formali dalla valenza politica, con invasioni del fantastico sul reale. Per il rilievo della sua opera è stata insignita di numerosi riconoscimenti internazionali, fra i quali il Premio Anna Seghers nel 2005, il Premio Roger Callois nel 2013 e il prestigioso «Genius Grant» della MacArthur Foundation nel 2020. Nel 2024, ha vinto il Premio Pulitzer per il miglior memoir con L’invincibile estate di Liliana, pubblicato da SUR nel 2023.
In Terrestre riprende e affronta da angolazioni diverse alcuni aspetti caratterizzanti il memoir, rivendicando un inno alla vita e alla sorellanza tra pagine che solcano l’avventura e il sogno e che sondano il riscatto dalla paura attraverso la trasgressione. Il sentore del pericolo adombra qualsiasi iniziativa femminile narrata nei racconti, dal viaggio senza meta all’autostop sulle strade del Messico, contrastato dalla vitalità e dall’entusiasmo giovanili che rappresentano la vera forza dirompente nel contemplare un mondo nuovo.
Lo sguardo femminista di Cristina Rivera Garza si rivolge alla dimensione selvatica della giovinezza per riconoscere il ruolo del desiderio nell’affrancarsi dal tormento e incoraggiare aneliti di indipendenza. Nell’intento di ridare centralità al pensiero, l’autrice sovverte ogni ordine precostituito e immagina il cambiamento nelle mani dei giovani. Nel racconto Il significato della pioggia le aule universitarie diventano incubatrici di utopie, spazi di confronto sulle rivoluzioni possibili mentre le file dell’Esercito Zapatista si ingrossano nel sud del paese. Le fantasticherie su una trasformazione radicale si scontrano con la difficoltà di accettare una realtà percepita come insensata tra cadaveri dopo le manifestazioni, inseguimenti, fughe per strada.
“Se potessimo fingere che tutto questo sia normale, far cadere la maschera”.
I molteplici riferimenti filosofici e letterari – da Ludwig Wittgenstein a Kate Hall – cadenzano un crescendo che si nutre di sguardi poetici diversi. Pregnanti in particolare i versi di Marosa Di Giorgio e Kim Hyesoon e pregevoli i rimandi cinematografici, in particolare all’opera di Agnés Varda e alla sua Mona Bergeron, per indagare le prevaricazioni sociali e di genere, il peso delle discriminazioni, la labilità delle relazioni, il rapporto con il tempo. La complessa simbologia scelta per tradurre le inquietudini interiori si ispira alle pagine di Cristina Peri Rossi e rende la raccolta un manifesto di libertà dalla valenza radicale. Tra i numerosi esempi di anticonformismo spicca quello rappresentato dal movimento popolare urbano di Città del Messico nell’opporsi alla corruzione, tutelare gli spazi autogestiti e favorire la democrazia partecipativa in funzione di una riduzione delle disparità sociali.
L’interesse per l’emarginazione di soggetti ritenuti non conformi rispetto a una presunta norma caratterizza l’intera produzione dell’autrice e, in relazione allo stigma della follia, si manifesta già nel romanzo Nessuno mi vedrà piangere (trad. Raul Schenardi, Voland), incentrato sulle condizioni degradanti subite dalle donne rinchiuse nel manicomio La Castañeda nel primo Novecento, attestate da documenti d’archivio e cartelle cliniche dell’epoca. Alla base della scelta tematica e formale l’intento di attuare un superamento della retorica della vittima per aprirsi alla speranza di un cambiamento.
La tensione tra diritti e libertà negate spinge l’autrice, in Terreste, a insinuarsi nelle dinamiche di vita di una comunità mennonita attraverso una prospettiva esterna incarnata da ragazze che irrompono in quell’immobilità, turbandola. Emerge ben presto l’impossibilità di comprensione in quel confronto tra vite reciprocamente inimmaginabili, con un chiaro riferimento a Donne che parlano di Miriam Toews. Le ragazze erano partite senza definire alcunché, mosse solo dall’urgenza di lasciarsi alle spalle le pareti scrostate del porcile dove si consumavano giorno dopo giorno, senza alcuna alternativa, interrogandosi senza sosta sulla possibilità di avere un destino diverso da quello prospettato sin dall’infanzia e da quello osservato in quella comunità.
“Per quanto tempo potremmo andare avanti noi, autonome, senza la benedizione di nessuno, a fumare sigarette e a guardare il cielo? Quanto tempo potremmo camminare così, senza tetto né legge?”
A definire la dorsale dell’opera sono le continue invasioni del fantastico in un gioco di dimensioni spaziali e temporali che porta chi legge a dubitare del vero per identificarne una nuova versione, surreale e estranea ma, al contempo, riconoscibile nella sua cornice.
Centrale l’attenzione riservata alle potenzialità lessicali nel dare forma a deviazioni e sottesi, ripetizioni continue, registri diversi, che nella peculiare musicalità della prosa di Cristina Rivera Garza traducono il complesso rapporto con lo spazio in funzione di una sua riappropriazione. Il rimando fisico definisce nella metafora del corpo/patria il continuo rispecchiamento interiore e traduce il contrasto tra le brutalità del passato e la quiete apparente del presente.
Che si tratti di strade polverose, di boschi fitti, di scorci metropolitani attraversati a piedi, in treno, o in auto, l’allestimento del paesaggio esaspera l’ambiguità del vero. In particolare lo scenario urbano messicano con i suoi epicentri nervosi rivela una tensione irrisolta nell’affermazione dei diritti di chi vive ai margini della società civile.
Nel racconto Quelli che mi aiutano a traslocare sono anche loro in movimento prende forma una riflessione sull’incapacità collettiva di rivendicare il diritto a un bene comune incarnato simbolicamente dal cielo. Al centro le vicende di due ragazzi che nel fantasticare sul destino ne scoprono la natura infedele, finendo per passare dalla percezione di immortalità a un disorientamento deleterio.
Lo studio del rapporto tra il tempo e il paesaggio portato avanti da anni dall’autrice in questo racconto profila una coesistenza di passato e futuro con mirabolanti aperture fantastiche che trovano nell’aderenza al terrestre un enigma irrisolvibile.
“Il paesaggio li aggredisce dai finestrini, incessantemente, senza mostrare segni di cedimento. Il paesaggio li colpisce, li minaccia, li meraviglia. Li segna. Il paesaggio, che si muove con loro, gli si incastra negli occhi e, poi, sotto la pelle. Processo di inoculazione. Questa è la sensazione. La luce dell’alba, i brandelli di cielo, gli accessi di pioggia, la polvere che ha percorso distanze enormi per arrivare qui, il suono delle cicale, le falene, lo sciame di libellule, i tratti bianchi al centro e ai lati della strada, i tratti gialli, le zanzare, i tralicci dell’alta tensione, le aree di sosta, gli hamburger, le patatine fritte, le coca-cole, le sigarette Marlboro, il rossetto, tutto è sottopelle. La distanza. Tutto è incancellabile.
È così che ti si infila un paese nel corpo? È così che ci rimane?”
Cristina Rivera Garza elegge luoghi simbolo corrosi dalla caduta delle ideologie e dall’assetto miope di un mondo politico distante dalle necessità del popolo. Gli ingrandimenti su aree urbane segnate da miseria e abbandono definiscono la natura permeabile dello spazio e tracciano un’alienazione investigata dall’autrice nel lambire il surreale per amplificare la denuncia sociale sottesa.
Emblematico il racconto Lavoro sul campo che identifica, attraverso il tratteggio di una peculiare sospensione, la dissociazione percepita da chi si sente dentro la città e fuori da essa, pur non avendola mai abbandonata. Prende forma una riflessione di sociologia urbana con la storia di una comunità che difende dallo sgombero un insediamento non autorizzato, per raccontare la vita in periferia a Città del Messico attraverso le differenze di classe, culturali e identitarie. I soggetti senza nome oltrepassano zone industriali, luoghi anonimi senza librerie né biblioteche, senza teatri e “senza domande metafisiche”, camminano rasoterra consapevoli di appartenere a quartieri popolari e zone dormitorio dove l’acqua potabile e il canto degli uccelli arrivano a malapena. La preghiera sommessa è che il vento si porti via tutto quel che umilia, che ferisce e sottomette, nella vana speranza di riscatto. Cristina Rivera Garza esalta le voci dal margine per ribaltare la prospettiva su esistenze ritenute irregolari, gravate dal duro contrasto all’abusivismo da parte delle istituzioni e delle forze dell’ordine.
“Le notizie dicono che qui nascondiamo guerriglieri centroamericani. Non dovete crederci. Non siamo guerriglieri, siamo paracadutisti. Non dovete crederci. Siamo lavoratori. Siamo disoccupati. Siamo gli scarti del capitalismo industriale.
Non dovete crederci. È il pretesto di cui hanno bisogno per radere tutto al suolo”.
È un luogo segnato dall’assenza di speranza quello che prende forma nei toni cupi, nel cielo torvo, nei raggi moribondi del sole che “lottano contro il grigio iridescente dell’atmosfera solo per trasformarsi in un fulgore privo di lucentezza” destinato a spegnersi. Tra continui interrogativi sul senso del vivere, si dispiega una riflessione sul trascendente, sui limiti della resistenza nel costante logoramento fisico e mentale generato da una condizione che non contempla salvezza, dove la luce appare colossale perché sul punto di morire.
“Veniamo da lontano. Veniamo dai libri che portiamo sotto il braccio. Veniamo dai cori che s’intonano alle manifestazioni. Siamo tantissimi e saremo di più. Veniamo dall’immaginazione. Ardente, l’immaginazione. Paralitica, l’immaginazione. […] Veniamo dalla mancata speranza. Veniamo dalla saturazione”.
L’opera è anche un’analisi sulle responsabilità della società verso la libertà interpersonale e collettiva e sul ruolo della cura come chiave del cambiamento.
La riflessione sul tempo che dominava L’invincibile estate di Liliana si rinnova qui nello scontro tra le tracce di un’esistenza anteriore e le vite potenziali, con enigmi, giochi di specchi, contrazioni e dilatazioni del passato e del futuro per definire una nuova concezione del tempo.
A confermare la straordinaria originalità di Cristina Rivera Garza è anche la capacità di sondare i risvolti della ferocia nelle ardite scelte formali come strumenti ulteriori per veicolare l’urgenza di un cambio di narrazione sull’abuso.
“L’aria: / una matassa di lisa violenza // l’aria e quei fiotti di luce fittizia navigata da grumi di polvere // l’aria e quel presentimento accennato del Golfo / il lontano odore di sale. // L’urlo. // Tu mi hai spezzato in due come un ramoscello / tu ti sei fermato a piangere accanto alla mia bocca e il mio sangue ti ha inondato le ciglia / tu sei la parola livido inscritta a lettere piccolissime nei miei enzimi”. (Lettere di acido ribonucleico).
Un altro esempio luminoso di alta letteratura è I leoni non sono qui che riprende il tema in forma sperimentale e si ispira alla poesia di Marosa di Giorgio per improntare sulla negazione l’intero racconto. L’esito è un testo inquieto, teso, che porta chi legge a concentrarsi sul significato della parola per immaginarne il contrario.
“Noi non ci amiamo, insistettero, ferrei, indistruttibili, le mani sui fianchi, invitandosi l’un l’altra a gettarsi di testa in un abisso. A questo non servono i viaggi di terra, non gli aveva risposto lei, imperterrita, serena, con la voce modulata dalle statue minuscole, a non andarsene una volta per tutte, a non levare gli ormeggi, a non concludere. Non si aspettava il colpo che non ricevette, né il modo in cui non cadde direttamente sulle fresche piastrelle a mosaico del pavimento, rannicchiandosi subito in posizione fetale, coprendosi d’istinto la faccia, mentre le scarpe da tennis non continuavano a darle calci sulla schiena, le gambe, le natiche”.
Il monito sotteso è di guardarsi dalle insidie nascoste nelle parole con cui si tende a ridurre a minoranza perché influenzano l’intera visione del mondo (aspetti trattati già dai primi anni Settanta e che in Italia sono stati affrontati tra gli altri da Alice Ceresa).
Con tali esperimenti formali Cristina Rivera Garza rivendica la necessità di immaginare un lessico sovversivo sulla violenza di genere e i femminicidi per decostruire modelli di potere oggettivanti attraverso un’attenzione nuova verso la politica del linguaggio. Lo spazio riservato a un reale cambiamento è reso nell’evoluzione fantastica, con un ricorso animale fondamentale nell’esaltare la libertà associata al volo.
Mirabile in particolare il racconto Uccellacce, ispirato a una poesia di Kim Hyesoon, con due airone che studiano all’università e che si comportano come due ragazze in giro, zaino in spalla, lungo le coste del Messico in autostop. Potrebbero volare ma, come nella poesia di Hyesoon, sono inibite dalle dimensioni delle loro ali che preferiscono tenere chiuse. Lo spettro del pericolo imminente nel salire a bordo con sconosciuti è il sottofondo costante di una prosa di straordinaria potenza espressiva, capace di lambire l’onirico, il surreale, il fantastico e l’iperrealistico.
“Ci abbandonammo al vento e a tutte le cose che il vento aveva toccato prima di arruffarci le piume scapolari. Ci lasciammo trasportare. Fiduciose. Una delle due cercò perfino di volare di spalle tentando la sorte o l’immaginazione. L’altra si distese nell’aria lunga com’era, oltre un metro di piume e muscoli e cartilagine che pendeva dal cielo. Quando le raffiche tornarono, violente e rumorose, prendemmo di nuovo a sbattere con vigore le membra e raddrizzammo il volo, che era puro smarrimento, immenso slancio, qualcosa che si fa perché sì. Perché potevamo”.
Con Terrestre Cristina Rivera Garza compone uno studio sulla politicizzazione del dolore attraverso una coralità di voci diverse, umane, animali, aliene, capaci di sollevare istanze necessarie a immaginare un sovvertimento radicale a partire dal rilievo assegnato al linguaggio. Un’elegia della libertà innocente, incorrotta, dettata dalla possibilità di rendere concreti desideri e utopie librandosi, finalmente, in volo.