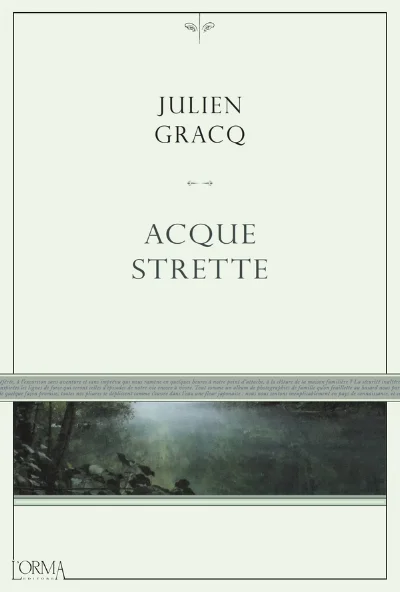di Andrea Cafarella
Un’anima che combatte per farsi anima tua
Il giro del giorno in ottanta mondi e Ultimo round ovvero intrugli stregoneschi che servono a guarire.
Che cosa importava a Van Gogh della tua ammirazione? Voleva la tua complicità, che tu cercassi di guardare come stava guardando lui, con gli occhi scorticati da un fuoco eracliteo.
«Morelliana, sempre» da Il giro del giorno in ottanta mondi
Ho conosciuto Julio Cortázar da grande. Mi consideravo già un lettore navigato, esprimevo pareri anche molto secchi, giudizi severi su questo o quell’altro autore, su tutti i libri che mi venivano consigliati, anche senza averli mai letti (vizio, da presuntuoso, che non mi toglierò mai). Sapevo cos’è Letteratura e cosa no, pensavo (questa ottusa convinzione invece sono riuscito a levarmela di dosso, fortunatamente). Poi, un bel giorno benedetto, presi in mano Rayuela. Quell’incontro cambiò totalmente la prospettiva che avevo avuto fino a quel momento di cosa significasse la parola «Letteratura». Imbattermi in quell’essere mastodontico, quella creatura vivente e multiforme, fu come per Achab al primo avvistamento di Moby Dick. La sensazione che si ha quando la caccia sta per cominciare.
Lessi Rayuela tutto d’un fiato, nell’ordine che suggerisce la «tavola d’orientamento» che apre il libro. Poi in modo lineare, dal primo al capitolo cinquantasei della prima sezione, «Dall’altra parte». Poi tentai di leggerlo in un ordine mio. E continuo: ogni anno, ogni sei mesi, ogni tanto, quando nell’incresparsi delle onde vedo uno spruzzo che mi pare provenga dallo sfiatatoio di Rayuela, allora riapro quel libro e inizio a leggere, e vado avanti, indietro, a destra, in alto e fino al fondo dell’ultima riga; e riprendo altri libri, cerco degli stralci in cui Julio abbia lasciato altre tracce che non ho ancora preso in considerazione. Urlo, bestemmio, appendo un doblone spagnolo all’albero di prora, perché qualcuno mi porti il cadavere di questo libro. Cerco ancora di capirlo davvero e fino in fondo… ottuso.
Poi, stanco, mi sdraio accanto a una grossa bitta, sopra una cima enorme, raccolta nelle sue spire, impregnatasi di sole e salsedine, che mi fa da giaciglio, e chiudo gli occhi, lasciandomi cullare dall’andirivieni delle onde. Mi arrendo. Ed è proprio quando mi arrendo, quando depongo le armi, l’arpione, e lascio che la prosa abissale di Julio fluisca dentro di me come un respiro. Quando mi fido di lui. In quel momento scopro il testone bianco di Moby Dick all’orizzonte, capisco qualcosa di nuovo, di me, comprendo davvero – anche se non saprei spiegarlo, ammesso che sia possibile – cosa è «Letteratura».
Ecco, l’incontro con Julio Cortázar ha significato, per me, proprio questo: l’inizio dell’ossessione, della caccia infinita e senza senso che porta alcuni di noi alla follia, all’esclusione, all’eremitaggio. Incontrare Cortázar può essere destabilizzante, trasformativo, perché significa conoscere uno stregone. Un alchimista della parola.
E la pratica alchemica è inesplicabile, non si basa sulle regole logiche e razionali cui siamo abituati. Bisogna crederci. Per comprendere la trasmutazione del piombo in oro, dobbiamo abbandonarci alle coincidenze, ai legami inaspettati, al dialogo mistico tra il sopra e il sotto, il dentro e il fuori. All’anima.
L’unico modo per leggere Cortázar è imparare, giorno dopo giorno, «a guardare, come lui, verso l’infinita apertura che aspetta e reclama» («Morelliana sempre» da Il giro del giorno in ottanta mondi).
Che tu generi figli o libri o figure o pentagrammi non avrai generato che frammenti, collages, grida rotte e lacrime senza testa.
Ma dappertutto, dappertutto è l’anima
l’anima che combatte per farsi anima tua
(un verso di Seferis di cui ho constatato mille volte la verità).
Posso chiamare ancora raccolta un insieme di luoghi-pensiero dove c’è un’anima che combatte per farsi anima mia, o tua?
G. Ceronetti, Tra pensieri
Si può dire che ogni libro di Cortázar sia un libro di frammenti, e un frammento, esso stesso, di un organismo più grande. Una prodigiosa opera immensa, una intera letteratura.
Parlandone da questo punto di vista, non può non venirci in mente uno dei predecessori di Julio, un tale Jorge Luis Borges. Uno che del frammento ne ha fatto una religione. Uno dei pochissimi grandi scrittori del novecento che non abbia mai scritto un vero e proprio romanzo. Uno che ha costruito libri e libri, che sono collage di pezzi di altri libri, di altri testi, di altre cose. Il Libro di sogni (Adelphi, 2015), il Libro del cielo e dell’inferno (con Adolfo Bioy Casares, Adelphi, 2011), il Libro degli esseri immaginari (con Margarita Guerrero, Adelphi, 2006), il Libro di sabbia (Adelphi, 2004), Storia universale dell’infamia (Adelphi, 1997), per citarne qualcuno. Ma tutti i libri di Borges sono delle «raccolte», degli «insiemi di luoghi-pensiero dove c’è un’anima che combatte per farsi anima» nostra.
Cortázar, non solo fa sua la lezione di Borges – come è d’obbligo per tutti gli scrittori argentini, e sudamericani, e probabilmente per tutti gli scrittori e basta – ma la porta alle sue conseguenze estreme e definitive. Ne esplora le potenzialità, in tutte le direzioni. Vive l’insegnamento del maestro, facendolo suo, assieme ai suoi fratelli, che in quegli anni si svestivano delle opprimenti regole estetiche che avevano dominato la storia artistica dell’uomo fino al novecento. Mischia la regola Borges alla sregolatezza del dadaismo, del cubismo, del futurismo, della musica nera che stava riconfigurando il concetto stesso di musica attraverso le improvvisazioni, evanescenti e sgrammaticate, dei giganti del jazz dei primordi.
Da queste mani, da questa voce, in questo contesto nascono Il giro del giorno in ottanta mondi e Ultimo round, rispettivamente nel 1967 e nel 1969. Due libri che sono un tutt’uno, di «grida rotte e lacrime senza testa», di frammenti di altri libri, di altre cose. Di Moby Dick e di Borges, e di Jules Verne e Charlie Parker. Contengono il suono della tromba di Armstrong e le opere più bislacche di Salvador Dalì. Due libri che sono uno solo, di cui non si può parlare singolarmente. E, nel loro insieme, uno degli esempi più chiari, efficaci, estremi ed esplicativi dell’intera opera di Julio Cortázar.
Sono libri di magia. Almanacchi per gli iniziati, scritti da un maestro. Due libri che sono parte di un insieme enorme, un corpo pulsante. Due libri che «respirano».
«Era un libro di grande formato, con la copertina che ricordava un giornale, e soprattutto diviso in due «piani» che si sfogliavano in maniera indipendente l’uno dall’altro». Chi scrive è Bruno Arpaia, e il testo si trova nella bandella dell’edizione Alet del 2007 di Ultimo round, ormai molto difficile da reperire. E parla, a sua volta, «dell’introvabile edizione del 1969, quella della Siglo XXI Editores messicana, stampata, chissà perché, a Torino». Ultimo round, come Il giro del giorno (come lo appuntava lo stesso Julio nelle sue lettere e nelle interviste), sono due libri talmente particolari che persino l’edizione era studiata dall’autore fino al minimo dettaglio. Erano dei volumi atipici, che dovevano potersi sfogliare in più direzioni, che prevedevano inserti di ogni tipo, collegamenti e rimandi all’apparenza del tutto illogici. Un libro da esplorare come una scatola più che come un tomo. «Un oggetto-libro del tutto anomalo per gli schemi di chi non guardasse il mondo con il suo stesso atteggiamento poetico e surrealista, con la sua onnipresente e profondissima ironia» (sempre Bruno Arpia nella bandella di Ultimo round).
Scrivo questo testo in occasione della ripubblicazione, in Italia, della meravigliosa traduzione di Eleonora Mongavero, per Sur edizioni che, da anni, si occupa dell’opera del maestro argentino di tutti i cronopios del mondo. Questa nuova edizione di Ultimo round arriva esattamente l’anno dopo quella de Il giro del giorno in ottanta mondi; e dopo un lungo percorso di pubblicazioni essenziali: libri fondamentali come Un certo Lucas, Componibile 62 e L’inseguitore (in un’edizione che lo accompagna alle illustrazioni di José Muñoz), libri minori ma non meno preziosi, come Correzione di bozze in Alta Provenza e Un certo Julio. Vita di Cortázar illustrata da Rep – che contiene una lunga intervista inedita, davvero interessante – e i tre volumi che raccolgono tematicamente il suo carteggio epistolare (Carta carbone, Chi scrive i nostri libri e Così violentemente dolce). (Contestualmente, segnaliamo altre importanti pubblicazioni degli ultimi anni, come Lezioni di letteratura (Einaudi, 2014), A passeggio con John Keats (Fazi, 2014) e l’indispensabile Le ragioni della collera (Fahrenheit 451) pubblicato nell’anno corrente, che raccoglie le sue poesie).
Eppure, questi due libri sono completamente diversi da tutti gli altri. Ogni libro di Julio è diverso da tutti gli altri, è vero, ma Il giro del giorno e Ultimo round hanno qualcosa di così estremo, di così anomalo e perturbante, che li pone in una posizione di ulteriore differenza, rispetto a qualsiasi altro libro di letteratura.
In effetti, quei due libri io li definisco come dei veri e propri «libri-almanacco». [...] Scrissi Il giro del giorno in ottanta mondi e Ultimo round perché avevo accumulato molti appunti sparsi: poesie (come sai, ho pubblicato poche poesie, perché le ritengo sempre molto personali), qualche racconto. All’improvviso, mi dissi: «Perché non fare qualcosa con Julio Silva, bravissimo pittore argentino e mio vecchio amico di Parigi? Perché non facciamo un libro per giocare, un grande almanacco?»
da L’altra parte (mimesis, 2014)
In questa densissima intervista di Joaquin Soler Serrano, Julio stesso parla di questi due libri come se fossero un insieme. E con la solita leggerezza che, giustamente, lasciava trasparire dalle sue parole quando ne parlava. La leggerezza che travolge il cuore di ogni cronopios che se ne accosti. Ultimo Round e Il giro del giorno sono dei libri-almanacco, dei libri-gioco. Bisogna leggerli ogni tanto, quando se ne ha voglia, e anche tutti d’un fiato, alla finestra, d’estate; oppure lentamente: venti trenta pagine al giorno. Poco importa, se sei un cronopios anche tu. Come anche Julio Silva, (pittore e scultore argentino a cui si deve l’idea da cui nascono Il giro del giorno in ottanta mondi, Ultimo round e altri libri di Cortázar in cui si uniscono testo e immagini) che potremmo dire co-autore concettuale di questi due libri. La letteratura di Julio è un gioco e, come tale, può e deve essere anche condiviso (e mi viene nuovamente in mente la co-autorialità tipica di un certo Borges).
In effetti, il gioco di Cortázar è condivisione: contaminazione, contagio. Servizio. Cibo. Julio cucina per e con i suoi amici e compagni, per e con noi. Cucina pozioni magiche con ingredienti stregoneschi molto particolari: «questo libro va componendosi come uno di quei misteriosi piatti di certi ristoranti parigini il cui primo ingrediente risale forse a due secoli fa, fond de cuisson al quale si sono via via aggiunte carni, verdure e spezie in un interminabile processo che conserva nel profondo il sapore accumulato in un’infinita cottura» scrive in uno dei frammenti de Il giro del giorno: «Un Julio parla di un altro» nel quale, come se fosse un diario, semplicemente appunta l’andazzo dei lavori.
Perché, sì, questi sono anche due libri-cantiere, attraverso cui, con un ascolto attivo, sincero e cronopicamente attento, possiamo comprendere, intuire dei segreti che illuminano tutta l’opera cortazariana. E sarebbe più corretto dire, in modo più preciso, che la ri-velano: cioè che la ricoprono di ulteriori enigmi e astuzie e ne impreziosiscono e alleggeriscono, così, paradossalmente – magicamente, la materia, arricchendo la complessità della sua intera opera.
Inoltre, in questi due libri-collage troviamo le sperimentazioni più ardimentose di Julio. Non è solo nella struttura, la sperimentazione. Il suo spirito dada, qui più che altrove, si è potuto sbizzarrire in modo assoluto: ci sono poesie, citazioni, stralci, notazioni di scritte sui muri, falsità, amenità, spazi bianchi, fotografie, illustrazioni, cianfrusaglie inutili e pezzi di vita.
«Sono opere vertiginosamente aperte, costantemente attraversate da quelli che Cortázar amava definire passaggi, di sentieri interrotti e distrazioni (tutto ciò che in qualche modo permette di evadere dal territorio di competenza dei famas, quei personaggi cortazariani fatalmente incaricati della difesa dell’ordine, della norma e dell’efficienza)». (L’altra parte) (scrive Tommaso Menegazzi, parlando di Rayuela, del Libro de Manuel e di Componibile 62, in un lungo discorso che parte da Il giro del giorno e Ultimo round, nell’introduzione all’edizione italiana della lunga intervista del 1977 di cui sopra: L’altra parte).
E se tutta l’opera di Cortázar è un insieme di frammenti, di quei «luoghi-pensiero» di cui parla Ceronetti, Il giro del mondo e Ultimo round ne sono l’esempio più illustre. Sono dei libri scoperti, sinceri, ineludibili. Non c’è finzione, o perlomeno la finzione, portata al livello più puro del gioco, si svela attraverso sé stessa, come un dettaglio minimo, nell’atteggiamento di chicchessia, che tradisce un aspetto profondo della sua personalità. Può essere parte di una tipica costruzione, della propria apparenza, attenta a ogni minuzia, o dell’inconsapevolezza sbadata, nella fretta che riserva all’atto di vestirsi, il più grande ritardatario; non ha importanza, finché noi non lo notiamo e non lo comprendiamo realmente.
A Julio Silva il 23 Agosto 1966
Lavoro molto al Giro del giorno in ottanta mondi, così si chiamerà il libro-collage che uscirà in Messico l’anno prossimo. Niente mi rende più felice che poter contare sui tuoi consigli e sul tuo aiuto per l’elaborazione grafica di quel libro, che sarà una specie di almanacco di testi brevi e molto diversi tra loro, un libro per cronopios. [...] Mi piacerebbe un libro molto arioso, con spazi bianchi da tutte le parti, vignette tra un testo e l’altro, strani disegnetti ai margini, e altre astuzie silviche e cortazariane. L’idea non ti terrorizza troppo, vero?
(Chi scrive i nostri libri, Sur, 2014)
Il J. di J.
«Questo libro mi capitò tra le mani trentacinque anni fa ed ebbi subito la sensazione di essere davanti a un libro di istruzioni per arricchire la vita». scrive il maestro Enrico Rava, in un testo intitolato: «Istruzioni per arricchire la vita» contenuto nella bandella de Il giro del giorno dell’edizione Alet del 2006. Anche lui, come Arpaia, racconta il suo primo incontro con questo libro, che lo «spinse, nel 1972, a intitolare il [suo] primo disco Il giro del giorno in 80 mondi».
Questi due libri, in effetti, hanno una caratteristica evidente, sulla pelle proprio: suonano come il lato A e il lato B di un disco jazz di altri tempi. Le pagine sanno del fruscio del vinile sovrastato dagli Hip e gli Square di Lester Young, che, ci dice Rava «altro non sono che i Cronopios e i Famas di Julio».
Il contatto, la comunione tra la letteratura di Julio e la musica nera dei primi anni del novecento è commovente, toccante. Un rapporto simbiotico che percorre tutta la cultura bohème di quegli anni, il dadaismo, le avanguardie.
Il giro del giorno in ottanta mondi inizia (e potremmo dire: Il giro del giorno e Ultimo round iniziano)con questa dichiarazione, palese, chiara: «Devo al mio omonimo [qui si riferisce a Julio Silva] il titolo di questo libro e a Lester Young la libertà di averlo modificato senza offendere la saga planetaria di Phileas Fogg, Esq.». Questa è una dedica esplicita quanto toccante a Lester Young e a quanto rappresenta effettivamente la musica jazz di quegli anni: la libertà. Affrontare i padri senza il timore reverenziale e classicista che aveva sempre vegliato, fino a quel momento, sull’operare di ogni artista. Non si tratta di prescindere da chi c’è stato prima, si tratta di non averne paura, si tratta di trovare nuove chiavi di lettura, anche riscoprendo certe nostre peculiarità, qualcosa che era stato trascurato, per esempio, da una certa mentalità colonialista, abituata a considerare solo l’analisi e la rielaborazione della cosiddetta «cultura occidentale». Si tratta di rivivere il rito antico africano. Certi ritmi, certe modalità d’esecuzione. L’abbandono e l’estasi, non per forza riferite all’onnipresente dionisiaco. Che poi, chiaramente, ha a che fare con quanto intendiamo per dionisiaco, ma non è dionisiaco. Il jazz è jazz. Libertà e improvvisazione. Non vuol dire nient’altro. Non vuol dire niente. Jazz non significa altro che jazz.
Ne Il giro del giorno in ottanta mondi troviamo brani, come quello dedicato ad Armstrong («Louis, grandissimo cronopio») o quello che racconta di Thelonious Monk («Il giro del piano di Thelonious Monk»), che sono testi che, da soli, valgono più di mille trattati jazz (suggerisce enfaticamente Enrico Rava). Per non parlare della chiusa, delicata e preziosissima, di Ultimo round: «Si può quel che si fa», di cui non dico niente per non rovinarvi la sorpresa, l’emozione della scoperta di un cristallo con all’interno una rosa.
Il jazz di Cortázar si trova nella struttura, in ciò che descrive, nella materia che usa e anche nel modo in cui la tratta. Il jazz è il suo metodo. Le sue scelte lessicali e ritmiche sono evidentemente jazz, non saprei in quale altro modo definirle. Basta leggere le due poesie in verticale, contenute in questi due libri: «Il rogo su cui arde una» e «Non ci sono più speranze di» per sentire, in quelle frasi tronche, monche come certe intuizioni di Miles Davis o di Coltrane, le sonorità di quegli anni, l’ululare di Howlin' Wolf davanti alla luna che illumina il Mississipi.
La tecnica di Cortázar è esattamente la stessa di Lester Young: la stonatura come armonia, l’improvvisazione, l’errore, la mancanza. L’incompleto, l’incerto. L’intuibile, la ricerca incessante di quel qualcosa «dall’altra parte delle cose» che possiamo raggiungere solo rischiando, inoltrandoci nel terreno sconosciuto di quanto ancora non sappiamo. Di quanto nessuno ancora ha fatto o ha visto. La caccia alla balena che nessuno è ancora riuscito a prendere.
In altre parole, la sua aspirazione era quella di donare alla sua prosa il fraseggio argenteo della tromba di Louis Armstrong («Armstrong – dirà lo scrittore nell’intervista – era uno dei miei dèi: i miei dèi appartengono a questo mondo, non ad altri»), la sua frenesia afrodisiaca, il suo discorrere bacchico, voluttuoso: «e poi la fiammata della tromba, il fallo giallo che lacera l’aria e gode avanzando e retrocedendo e verso la fine tre note scendenti, ipnoticamente d’oro puro, una perfetta pausa nella quale tutto lo swing del mondo palpitava in un attimo insopportabile.» [...] è possibile scorgere quella scintilla sciamanica e intimamente rivoluzionaria che, dai racconti «neofantastici» ai contro-romanzi, passando per il suo impegno politico e la sua inquietudine esistenziale e libertaria, caratterizza così profondamente la figura di Julio Cortázar. (Tommaso Menegazzi in L’altra parte)
La questione dei cronopios
«A quei tempi, avevo già letto quasi tutto Cortázar ed ero forse molto più cronopio di quanto lo sia adesso. Perciò fu semplicissimo entrare in quell’universo percorso da nessi apparentemente casuali, da accostamenti improvvisi e insoliti, eppure retto da una logica implacabile che teneva insieme racconti, poesie, saggi letterari e politici, fotografie, quadri, disegni, musiche, ritagli di giornale [...] ancora oggi mi aiuta a restare almeno un po’ cronopio, capace di guardare il mondo senza certezze cartesiane e di scoprire l’altra realtà, ludica e terribile, magica, barbara e cerimoniale, che solo i nostri paraocchi razionalistici ci impediscono di vedere». (dalla bandella di Ultimo Round) Cosa sono i cronopios? In tanti hanno provato a rispondere a questa domanda. Io credo che questa sia proprio una domanda da famas, una domanda che un cronopio non si fa e non dovrebbe mai farsi a un cronopio. A questa domanda Julio risponderebbe così: «con me il problema, come avrai già capito, è che quando mi si chiede qualche spiegazione è tempo perso, perché per me è molto difficile spigare delle cose che nemmeno io riesco a spiegare» (L’altra parte) raccontando, successivamente, il momento del concepimento dell’idea dei cronopios, come un’esperienza mistica, in cui degli esserini, i cronopios appunto, fluttuavano nell’aria, in un immenso teatro degli Champs Elysee, al termine di una serata in onore di Igor Stavinskji. Julio, rimasto solo, vede dei «personaggi indefinibili, come dei palloncini, che a [lui] sembravano verdi, molto comici, divertenti e amichevoli». Un cronopio è un cronopio, non è un semplice scellerato, un distratto, uno sbadato con la testa rivolta sempre al cielo. Un cronopio è un cronopio. Spiegare cosa sia un cronopio sarebbe come spiegare cos’è la magia (o il jazz, appunto). Si potrebbero scrivere e si sono scritti moltissimi libri, trattati antropologici e ricerche scientifiche sull’argomento, è vero. Si è voluto anche svalutare, nel tempo, il concetto di magia – come quello di cronopios – cercando d’incasellarlo in uno schema di stampo razionalistico e scientifico. Eppure, resiste – la magia e i cronopios, e il gioco, per fortuna – perché non può essere considerata in quelle stesse categorie, per cui, se ne svincola ed esiste lo stesso, volteggiando nell’aria quando uno sciamano, come Julio, ha una visione estatica. Ecco, i cronopios sono una visione allucinogena durante un rituale sciamanico. Possiamo provare a spiegarla, ma ne risulterà sempre limitata. Bisogna vederla per capire davvero cosa s’intende, cosa sono i cronopios.
In ogni caso, una spiegazione razionale molto completa ed esaustiva la da Italo Calvino, nella sua introduzione a Storie di cronopios e di famas. Anche se, io credo che Julio non avrebbe gradito, perché forse bisognerebbe solo tacere sull’argomento, o inventare un’altra storia che finisca con Calvino che fa qualcosa di stravagante, per dargli l’aria da cronopio che avrebbe sempre voluto avere.
Ve la riporto per correttezza. Ma vi avverto: un cronopio si fiderebbe di me e la salterebbe a piè pari.
«Dire che i cronopios sono l’intuizione, la poesia, il capovolgimento delle norme, e che i famas sono l’ordine, la razionalità, l’efficienza, sarebbe impoverire di molto, imprigionandole in definizioni teoriche, la ricchezza psicologica e l’autonomia morale del loro universo. Cronopios e famas possono essere definiti solo dall’insieme dei loro comportamenti. I famas sono quelli che imbalsamano ed etichettano i ricordi, che bevono la virtù a cucchiaiate col risultato di riconoscersi l’un l’altro carichi di vizi, che se hanno la tosse abbattono un eucalipto invece di comprare le pasticche Valda. I cronopios sono coloro che si lavano i denti alla finestra, spremono tutto il tubetto per veder volare al vento festoni di dentifricio rosa; se sono dirigenti della radio argentina fanno tradurre tutte le trasmissioni in rumeno; se incontrano una tartaruga le disegnano una rondine sul guscio per darle l’illusione della velocità».
La poesia è un gioco
A Francisco Porrùa
Parigi, 21 gennaio 1967
Sono contento di ciò che mi dici sul Giro del giorno, che è lungi dall’essere un libro «importante» ma al contrario contiene, credo, molte pagine divertenti.
Chi scrive i nostri libri, Sur, 2014
Julio considerava Il giro del giorno e Ultimo round come dei giochi. In un modo tutto suo, però. Come tutto, nel mondo di Julio. Nel gioco del mondo di Julio. L’inversione dei valori, nei suoi libri e nella sua prosa (intendo proprio tecnicamente parlando), è il gioco principale, la regola assoluta. Tutto ciò che è tremendamente profondo, viene alleggerito per arrivare in superficie. E quanto appare frivolo viene caricato di significato per scintillare come il dettaglio, sul fondo, che tutto spiega, con la limpidezza del respiro meditativo: l’attenzione per le cose piccole ed essenziali: l’aria che entra ed esce dalla bocca, attraversandoci.
E, se questo è vero, l’impressione che Julio considerasse questi due libri come opere minori, di raccolta, giochetti facili, è del tutto falsa. In questi volumi troviamo alcune delle riflessioni più importanti di Cortázar su qualsiasi cosa, e specialmente sulla poesia, sull’arte, sulla letteratura.
Come il lungo saggio che Julio dedica a un libro fondamentale, che Cortázar amava, Paradiso («Per arrivare a Lezama Lima» da Il giro del giorno). Oppure il bellissimo omaggio che fa a Borges («The smiler with the knife under the cloak»), che è anch’esso un insieme di frammenti. E ancora il testo – fondamentale per ogni scrittore e lettore, soprattutto di racconti – che era già apparso in Bestiario (Einaudi): «Del racconto breve e dintorni», che è diventato un po’ un manifesto letterario di un certo modo di concepire la misura breve in narrativa, di concepire il racconto, el cuento, di cui Julio (e questo mi riporta sempre a Borges) è considerato maestro indiscusso ed eroico pioniere. Mi sembra bello, in questa sede, leggerne un estratto – a mio parere molto significativo rispetto al discorso che sto cercando di portare avanti – insieme:
«Ogni volta che mi è toccato rivedere la traduzione di un mio racconto (o tentare quella di altri autori, come nel caso di Poe), ho sentito quanto l’efficacia e il senso del racconto dipendessero da quei valori che danno alla poesia e al jazz il loro carattere specifico: la tensione, il ritmo, la pulsazione interna, l’imprevisto dentro parametri pre-visti, quella librerà fatale che non ammette alterazione senza una perdita irreparabile. I racconti di questo tipo rimangono come cicatrici indelebili nel corpo di ogni lettore che li meriti: sono creature viventi, organismi completi, cicli chiusi, e respirano».
In questi due libri c’è il jazz, la letteratura, il gioco, c’è la boxe, ci sono i viaggi, il tempo, le cose intime e quelle che devono essere di tutti.
Ci sono tante poesie, quelle che Julio aveva sempre considerato troppo personali per la pubblicazione. E c’è tantissima sperimentazione. C’è della poesia visiva, diremmo oggi. Ci sono dei giochi, direbbe Julio, come il brano «Poesia permutante» (da Ultimo Round) dove l’autore mette insieme dei componimenti i cui versi possono essere letti in qualsiasi ordine, creando molteplici possibilità. Di nuovo: i frammenti, la libertà. Queste poesie multiformi sono precedute da un brano che, come fossero istruzioni per l’uso, spiega il processo e le modalità di fruizione dei testi. Con una spaventosa ironia, quasi prendendosi in giro da solo.
L’autoironia, a mio modo di vedere, è una delle più grandi possibilità di autoanalisi. Imparare a non prendersi troppo sul serio per ritrovare una serietà più profonda, che vada aldilà.
«Dico giochi con la serietà che hanno i bambini quando pronunciano questa parola. Ogni poesia degna di questo nome è un gioco» scrive, sempre in Ultimo round.
Il gioco di Cortázar, direbbero i famas, si avvicina al paignon platonico. No, il gioco, in Cortázar, trascende la discussione filosofica. Nemmeno la affronta, nemmeno la vede: lo sa. Esattamente come i bambini: d’istinto. I bambini sanno già cos’è il gioco, giocando. Sanno che «niente è più rigoroso di un gioco; quando giocano con un aquilone o ai quattro cantoni, i bambini rispettano le regole con una diligenza che non riservano a quelle grammaticali». (da Ultimo Round) Come uno stregone sa che niente è più rigoroso e serio del rituale magico. In questo senso la poesia è un gioco. La letteratura è un gioco. La vita è un gioco. In un’equazione mistica che raggiunge la penna di Cortázar e fa questo concetto parola. Lui, forse più di ogni altro, ci ha insegnato a sovvertire le regole grammaticali per seguire quelle del suo gioco: la Rayuela, ovvero Il gioco del mondo. Fino alla Fine del gioco, come se non ci fosse niente di più importante e rigoroso.
Il giro del giorno in ottanta mondi e Ultimo round sono tra gli esempi più estremi della macchina creativa cortazariana. Non seguono le regole usuali, eppure hanno una struttura, fatta di corrispondenze improbabili, che risulta impeccabile. I brani fluttuano l’uno accanto all’altro cronopicamente, senza una ragione precisa e nell’unico ordine possibile: quello giusto.
Stanno insieme per magia, come gl’amanti. Eh sì, sono anche romantici i cronopios. Disperati e romantici, da far schifo. Bevono, i cronopios. Sbadigliano e inventano macchine per leggere romanzi smontabili che parlano di ogni cosa in ordine sparso, in ordine di cuore. Cercano una cura, i cronopios.
Infatti, i libri di Julio sono intrugli stregoneschi che servono a guarire. Sono per gli altri i libri di Julio. «Istruzioni per arricchire la vita». Costellazioni di cose che stanno dall’altra parte delle cose. Manuali per cronopios, senza capo né coda, tutto unito nell’ordine, apparentemente casuale, in cui si configura l’universo intero. Sono come i tarocchi: una macchina filosofica in grado di leggere le trame del cosmo, che però si basa sull’intuizione e sulla capacità di sentire e interpretare del consultante (nella prosa di Julio però, questa frase avrebbe l’accento su quanto suoni ridicola, con la grande autoironia che io non possiedo).
Il giro del giorno e Ultimo round sono libri preziosi e imprescindibili, che ci ricordano di quando eravamo bambini e di quando eravamo cronopios; che ci dimostrano, di nuovo che esiste la magia, che esiste l’anima; che c’insegnano a guardare con gli occhi di Van Gogh. Che ci sussurrano ancora, dal regno dei morti, che c’è «un’anima che combatte per farsi anima tua». Questi due libri sono un messaggio importante per tutti i cronopios: non smettiamo mai di cercare.
«Se, tra le cose che ho scritto, qualcuna è servita per mostrare l’altro lato delle cose ai miei lettori e ai miei amici, è facile intuire che ciò costituirebbe la più grande ricompensa cui possa ambire. Personalmente continuo ad avvertire la presenza di qualcosa che si trova dall’altra parte delle cose, per questo non smetterò mai di cercare».
(L’altra parte)