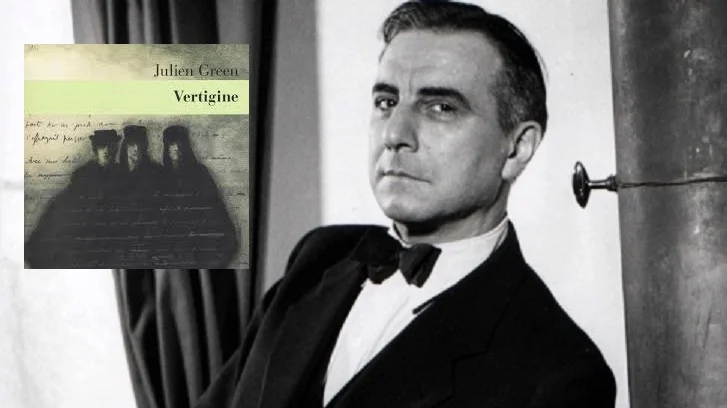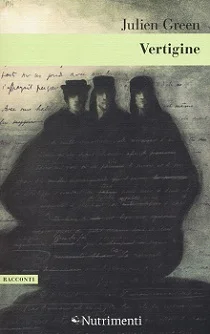Vertigine, edito da Nurimenti. Venti racconti di Julien Green, tutti inediti in Italia, che esplorano strade differenti e sperimentano vari modi di mettere in scena il mistero, il fantastico e il perturbante. Prose che attraversano tutto il periodo d'oro dello scrittore francese, composte tra il 1920 e il 1956 e raccolte in volume nel 1984. In questa edizione si ripete l'esperienza di traduzione collettiva inaugurata con Viaggiatore in terra. A interpretare la scrittura di Julien Green sono cinque voci diverse, tre esperti traduttori (Giuseppe Girimonti Greco, Lorenza Di Lella e Francesca Scala) affiancati da due narratori colti e raffinati come Ezio Sinigaglia e Filippo Tuena.
Vi proponiamo un estratto dal libro: 'La ribelle', tradotto da Giuseppe Girimonti Greco.
Segue una approfondita nota al testo tratta da 'Nota ai testi' scritta da Giuseppe Girimonti Greco e Ezio Sinigaglia.
La ribelle
[…]
I miei genitori morirono quand’ero piccola, e furono le sorelle di mio padre, Hélène e Simone, entrambe zitelle, ad allevarmi. Zia Hélene era alta e robusta, aveva il volto rubizzo e gli occhi di un azzurro così chiaro che, sotto la luce, era difficile distinguere il contorno delle iridi. Si vestiva in modo sciatto, ma non senza una punta di civetteria vagamente ridicola. Si pettinava sempre in fretta e furia, cosicché qualche ciocca le ricadeva sempre, scompostamente, sulla fronte; ma non mancava mai di appuntarsi un paio di fiori finti nella crocchia e non disdegnava neppure i boccoli posticci, che distribuiva a casaccio in cima alla testa o sulle tempie. Indossava solo abiti di seta o satin. Nutriva per il panno la stessa avversione che taluni hanno per il velluto, e quando glielo avvicinavano lanciava dei gridolini di ribrezzo. Ma, a dispetto della pregiata qualità dei tessuti, i suoi vestiti erano sempre macchiati o lisi.
Mia zia Simone, invece, era, all’opposto della sorella, estremamente curata. Era una donna secca e molto alta, dal viso severo e dai lineamenti tesi come per effetto di una perenne stanchezza. Portava dei corsetti di tela bianca e delle gonne di sargia e, quando cuciva, si metteva sempre una specie di piccolo grembiule d’alpaca, che fissava con degli spilli. Con lei parlavo di rado perché mi metteva in soggezione. Non c’era volta che non mi rispondesse senza prima sospirare in modo sgradevole. Eppure era con lei che passavo la maggior parte del tempo. Anche perché zia Hélène usciva verso le tre e rincasava molto tardi, cosicché io non la rivedevo se non l’indomani a pranzo.
Più di una volta mi azzardai a chiedere a zia Simone che cosa mai facesse zia Hélène nel pomeriggio, ma lei rispondeva sempre che non erano affari miei. Zia Simone non sorrideva mai. Seduta nel vano di una finestra, cuciva senza sosta per due o tre ore di seguito, e passava il resto del suo tempo seduta alla scrivania del salotto a sistemare carte e documenti e a scrivere su un grande quaderno rilegato in panno nero. “Devo fare i conti, devo mettere in ordine i conti” era il genere di frase che pronunciava più spesso quando era con la sorella. Credo che lavorasse per la Grande Maison de Blanc di Parigi.
All’epoca abitavamo in rue de Passy, vicino alla fermata da cui partivano gli omnibus diretti alla Borsa. Ogni quarto d’ora quelle pesanti vetture gialle passavano sferragliando e scendevano per la stretta rue Guichard con un tremendo frastuono. Mi appostavo alla finestra del salotto perché da lì potevo comodamente vederli sfrecciare. Mi bastava scostare rapidamente la tendina di tulle prima che zia Simone riuscisse a redarguirmi con voce aspra: “Non lo vedi che così la spiegazzi?”. Questo passatempo era ormai diventato per me una specie di mania. Non mi perdevo neppure una partenza e, non appena sentivo quello schiocco di frusta così familiare, mollavo tutto e mi precipitavo alla finestra. Quei vecchi omnibus avevano un che di regale che mi mandava in visibilio, e ogni volta che ne vedevo uno applaudivo. “Ma che ti prende? Sei impazzita?”, mi diceva allora zia Simone.
Ero convinta che non mi volesse bene, ma il suo atteggiamento nei miei confronti era di fatto piuttosto strano, perché, sebbene si rivolgesse a me senza nessuna tenerezza e non si sognasse mai di compiacermi in alcunché, in realtà mi accudiva con infinita premura. Dedicava un’attenzione scrupolosa ai miei pasti; se starnutivo o tossivo, potevo star certa di esser subito presa per mano e accompagnata in camera mia, per essere messa a letto all’istante. Non uscivo mai da sola, neppure per attraversare la strada. Ma in questa sua sorveglianza incessante zia Simone non metteva un briciolo di affetto o gentilezza. Sembrava che si occupasse di me per puro senso del dovere, e per giunta con una sorta di risentimento. Ricordo, ad esempio, che, nel porgermi il cappotto, non mancava mai di strattonarmi e di tirarmi per le braccia con una sorta di rabbia rattenuta.
“Ma così le fai male”, diceva zia Hélène quando assisteva a queste manifestazioni di rude sollecitudine. Ma zia Simone non replicava e anzi, per soprammercato, mi pizzicava con le unghie mentre mi agganciava il colletto di pelliccia di pecora.
Tutto il mio affetto, pertanto, si riversava inevitabilmente su zia Hélene, che mi faceva mille carezze e mi chiamava “la mia gattina”. Ogni giorno mi faceva dei regalini, scelti sempre in modo tale da riempirmi di gioia: di solito erano quelle statuine di terracotta che all’epoca venivano chiamate “sorprese”, perché erano cave e sigillate di sotto da una membrana di carta e contenevano un anellino di piombo, una biglia, un sonaglio, o qualsiasi altro oggetto abbastanza piccolo da potervi entrare; bucavi la membrana, trovavi la sorpresa, e in più ti restava la statuina, cosicché il regalo era doppio.
Zia Hélène si divertiva a spiare la mia reazione quando aprivo quei regali e si interessava con infantile entusiasmo al loro contenuto. Le si increspava il viso, gli angoli degli occhi le si sollevavano all’insù e il bianco dei denti le balenava fra le labbra aperte in un largo sorriso che le dava un’aria al tempo stesso comica e feroce.
[…]
Se dovessi elencare tutte le umiliazioni che mi furono inflitte all’istituto Sainte-Marie, non finirei più; mi limiterò pertanto a raccontare lo stretto indispensabile per far capire la piega che alcuni di questi episodi hanno dato al mio carattere. Nelle scuole per ricchi gli allievi poveri sono da sempre vittima di tenaci pregiudizi. Guai al bambino malvestito, che ha una cartella di finto cuoio o dei quaderni dozzinali! Il disprezzo dei compagni si trasmette inevitabilmente agli insegnanti, e questo sentimento di avversione è destinato a diventare così forte che neppure tutta la carità cristiana di questo mondo basterebbe a contrastarlo.
Io venivo orrendamente vestita da zia Simone, che, quando mi rifaceva il guardaroba, non aveva come obiettivo né l’eleganza né lo stile. Per lei qualsiasi cosa andava bene, purché non sentissi freddo. E così mi toccava portare dei vestiti da grande adattati alle mie misure, e se il taglio era perlopiù accettabile, la stoffa produceva immancabilmente un effetto comico, perché di solito si trattava dei vecchi capi di zia Hélène, che zia Simone, dopo aver fatto qualche modifica e aver aggiunto qualche orlo, mi costringeva a mettere. Potete dunque immaginare quale potesse essere la mia sofferenza quando alla messa della domenica dovevo farmi vedere con addosso, per esempio, un sontuoso abito di velluto color malva! E con quale trepidazione mi infilavo il grembiule di alpaca nero che, grazie al cielo, era identico a quello di tutte le altre.
Ma questi sono soltanto dettagli di poca importanza. Apparivo ridicola non appena mi toglievo il grembiule, ma per il resto del tempo, vale a dire per quasi tutta la giornata, non ero diversa dalle mie compagne, se non per il fatto che ero di gran lunga la più graziosa di viso e di corpo. Ero sicura di me, rispondevo con intelligenza e senza esitazioni a tutte le domande che mi venivano rivolte dalle più grandi o dalle maestre. Ma avevo anche un’aria riservata e un po’ altera che faceva uscire dai gangheri le mie coetanee perché vi scorgevano le tracce della mia superiorità. Ovviamente, non perdevano occasione di farsi beffe di me quando andavamo a messa la mattina: spesso mi chiedevano per celia il nome della mia sarta, oppure mi strattonavano per le maniche facendo finta di volerne ammirare da vicino la stoffa. Siccome non rispondevo mai a queste provocazioni, le risate di quei piccoli demoni si convertivano in ferocia, e molte di loro mi riempivano le braccia di pizzicotti quando eravamo costrette ad accalcarci per entrare nella cappella.
Tuttavia, ero riuscita a farmi qualche amica, fra le allieve più grandi, che però appartenevano tutte a ceti sociali più elevati del mio. Avevano apprezzato il mio aspetto riservato e gradevole sin dal mio primo giorno, ed erano state loro che, vedendo che non giocavo mai con le mie coetanee, erano venute a cercarmi per chiedermi di passare del tempo insieme. Soltanto il timore di allungare questo racconto ben oltre i limiti che mi sono prefissa mi impedisce di indugiare su queste amicizie. Le grandi mi vezzeggiavano a loro piacimento e mi facevano mille moine, come per risarcirmi dell’astio che mi riservavano quelle della mia età. Facevano a gara a chi doveva cedermi la sua cioccolata delle quattro, un santino con l’orlo di merletto, oppure un paio di nastri colorati; mi subissavano di domande sui miei gusti, sui miei progetti per il futuro, sulla mia famiglia. Cosicché potevo contare su quattro o cinque ragazze fra i quindici e i sedici anni che avevano nei miei confronti ogni genere di premura e che si accapigliavano per me, perché erano gelose del mio affetto e ciascuna di loro avrebbe voluto essere la sola a beneficiarne.
Una in particolare cercava di compiacermi più delle altre. Il suo vero nome era Andrée Decluze, ma la superiora la chiamava Sauvageonne per via dei suoi modi che denotavano un’indole al tempo stesso timida e selvatica. Sembrava sempre in preda all’ansietà e incapace di spostarsi senza correre, il che le faceva prendere note di demerito in continuazione. Bastava guardarla per farla arrossire e veder spuntare sul suo viso un’espressione colpevole. A ciò si aggiunga un faccino d’angelo, due occhi neri che si allungavano leggermente verso le tempie e uno sguardo pieno di mestizia. Era piuttosto magrolina, e non aveva delle belle mani; si muoveva in modo impacciato; i suoi gesti goffi tradivano l’incessante controllo che esercitava su sé stessa. Tuttavia, quando stavamo insieme, aveva dei momenti di abbandono, si chinava su di me, mi cingeva la vita e mi parlava con una voce esitante, come per effetto di un’emozione trattenuta. Mi piaceva quel tono, e poi nulla al mondo mi lusingava e mi incantava quanto l’idea che qualcuno potesse trovarmi piacevole e legarsi a me. Questo, non altro, stava alla base del mio carattere. C’era, nel mio cuore, un immenso bisogno d’affetto, che pareva inesauribile e che mi rendeva inquieta e infelice quand’ero da sola. A quell’età poco m’importava di essere amata da persone di mio gradimento, e volevo bene a chiunque fosse disposto a ricambiarmi. Un giorno la madre superiora mi strinse a sé, e io mi misi a piangere, non perché mi sentissi triste, ma per un improvviso accesso di tenerezza in cui si mescolavano gioia e gratitudine. Le parole gentili avevano il potere di commuovermi profondamente, e non dimenticavo mai nulla di ciò che mi si diceva. Essendo così sensibile, come potevo non corrispondere ai sentimenti di amicizia di Sauvageonne? Conservavo con cura i piccoli regali che mi faceva ogni giorno, mettevo nastri e santini sotto chiave nella mia scatola come se fossero state reliquie. Un superstizioso timore mi spinse a tenere nascosta la scatola in fondo al mio bauletto, sotto la biancheria e i libri. Le attribuivo virtù mistiche. Mi figuravo che, se accidentalmente fosse stata aperta da mani estranee, avrei perso all’istante anche l’amicizia di Sauvaegonne, e la paura continua che un incidente tanto increscioso potesse davvero verificarsi conferiva alla mia felicità un che di raro e dolcissimo.
Sauvageonne, per la quale non avevo segreti, trovava del tutto naturale l’importanza che attribuivo alla mia scatola. Le piacevano il mistero e gli intrighi, pertanto si trovò presto d’accordo con me circa l’opportunità di consegnarmi furtivamente i regali che aveva in serbo per me. Anzi, si spinse ben oltre, perché, mentre io mi limitavo a sottrarre agli sguardi indiscreti la scatola e il suo contenuto, lei, per prudenza, smise addirittura di parlarmi e di abbracciarmi in presenza delle altre. Dietro un’apparente ingenuità, celava un’indole tanto astuta quanto impulsiva. Tutte le mattine, in cappella, una mano cercava la mia e mi infilava tra le dita un bigliettino accuratamente ripiegato in quattro. Era così che Sauvageonne comunicava con me, per darmi ogni giorno un appuntamento in qualche angolo defilato del cortile, in fondo al prato o dietro le aiuole di lillà che fiancheggiavano il refettorio.
Questi piccoli maneggi la divertivano oltre ogni dire. Finché eravamo insieme alle compagne, Sauvageonne si sforzava di mostrarsi gelida nei miei confronti, tanto che ogni volta circolava la voce che avessimo bisticciato, ma, non appena arrivavo nel luogo convenuto, mi gettava le braccia al collo e mi prodigava un affetto pari all’indifferenza di poco prima. Mi diceva di sederle accanto, all’ombra dei cespugli, e mi parlava per ore di sé e dei suoi progetti per il futuro. A sentir lei, era destinata all’esistenza più brillante e felice che si potesse immaginare. Avrebbe abitato in un quartiere del centro di Parigi, in un sontuoso palazzo, e avrebbe ricevuto ogni giorno un’incredibile quantità di visite. Avrebbe avuto molti spasimanti. Come ogni gran dama della città, sarebbe stata caritatevole e si sarebbe prodigata in opere di beneficenza.
Ma ormai la ascoltavo con minore interesse rispetto al passato. Qualcosa mi diceva che in realtà parlava perlopiù a sé stessa, e che quei suoi progetti per l’avvenire avrebbe potuto tranquillamente confidarli a qualsiasi altra compagna. Chissà. Forse non attribuiva più la stessa importanza alla mia amicizia… Non mi faceva più regali, e mangiava la sua barretta di cioccolato senza mai avere la premura di dividerla con me. Seduta per terra, con le gambe incrociate sotto la gonna, parlava di continuo giocherellando con le trecce senza più neanche guardarmi. Certe volte, però, come per il riaffiorare dell’antico sentimento, all’improvviso mi attirava a sé e mi stringeva al petto, ma ormai era lontana l’epoca in cui mi infilava furtivamente un nastro colorato nella tasca del grembiule mormorandomi, tutta rossa in viso, qualche parola confusa all’orecchio.
Non riuscivo proprio a spiegarmi il perché di quel cambiamento. La sera, quando aprivo il mio bauletto per prendere le pantofole, guardavo con tristezza la scatola in cui avevo l’abitudine di conservare i regali che ricevevo. Era una piccola scatola di latta che mi era stata data da una sorvegliante, sul cui coperchio era ancora ben visibile una nota marca di cioccolatini. Fino a un mese prima, mi sembrava tanto preziosa. Ma adesso… non era forse ridicolo tenere tanto a un oggetto così dozzinale? E quei pezzi di nastro? Valeva davvero la pena continuare a preservarli da ogni contatto? Le mie compagne ne avevano di molto più belli!
Diventavo sempre più malinconica. Avevo l’impressione che le amiche che ancora mi restavano fra le più grandi non mi frequentassero più tanto volentieri. In ogni caso, non si accapigliavano più per parlare con me, come quel primo giorno, e mi lasciavano tranquilla. D’altro canto, non mi piacevano più quegli appuntamenti che Sauvageonne mi dava. Quel sapore clandestino che aggiungeva alla nostra amicizia mi infastidiva. Avrei voluto che tutto tornasse come agli inizi, che lei ricominciasse a parlarmi in pubblico e a prendermi la mano davanti alle più grandi, perché essere amata mi riempiva di orgoglio e non chiedevo di meglio che di essere la prediletta di tutti quanti e di fare, per così dire, la parte della bella principessina.
In ogni caso, se è vero che l’affetto di Sauvageonne non era più così vivo come all’epoca del mio arrivo in convento, di certo mi voleva ancora molto bene, e le sarebbe stato difficile rinunciare a vedermi tutti i giorni, solo che adesso non mi parlava più con lo stesso calore di prima, e a poco a poco aveva perso quella timidezza che i primi tempi mi aveva tanto lusingato e commosso. Stava cambiando; aveva spesso un tono imperioso, che usava per impormi di ascoltarla e di seguirla attentamente quando si abbandonava ai suoi verbosi monologhi.
Questa ragazzina che all’inizio avevo creduto taciturna era in realtà una gran chiacchierona e, come tante altre fanciulle della sua età, aveva la mania delle confessioni.
Per ben tre settimane ci vedemmo praticamente tutti i pomeriggi, e a quanto ricordo lei non faceva altro che confidarmi tutto ciò che le passava per la testa. Mi accorsi presto che ogni dieci frasi finiva, in un modo o in un altro, per mettersi a parlare d’amore, suo argomento prediletto. Contava i mesi che la separavano dal momento in cui avrebbe lasciato l’istituto e sembrava fermamente convinta che, nel corso della settimana successiva alla partenza, qualcuno l’avrebbe chiesta in sposa. Senza il minimo imbarazzo, mi faceva il ritratto fisico e morale del suo principe azzurro, e sembrava più che certa che esistesse realmente e persino che la stesse aspettando da qualche parte in città. Ne parlava con la sicurezza di chi ha un chiodo fisso e riesce a trarre dalla propria ossessione un tono in certo qual modo autorevole.
Non ci misi molto a rendermi conto che, avendomi confidato pressappoco tutto ciò che aveva da dirmi, ormai non ricavava più lo stesso piacere di prima dalla mia compagnia; si aggiunga a questo che facevo fatica a starle dietro perché ero decisamente troppo piccola per trovare interesse in un argomento di conversazione come il matrimonio. Una mattina, a messa, non mi diede il consueto bigliettino. Appena uscita dalla cappella, andai da Sauvageonne per chiederle spiegazioni, ma lei si limitò a farmi una specie di smorfia, sollevando le sopracciglia e sporgendo la testa in avanti, come per dire che non poteva farci niente. A partire da quel giorno non mi parlò più.
[…]
Trauma, scrittura e rimozione in un memoriale inattendibile
(La ribelle)
Il racconto La ribelle è forse il più greeniano dell’intera raccolta. In un’intervista rilasciata al curatore di Histoires de vertige per la Pléiade, Green, nel mettere a fuoco uno dei temi portanti della raccolta, quello dell’infanzia violata dagli adulti, fa emergere una parola-chiave, “révolte”, che può costituire una buona chiave di lettura per spiegare il senso di molti dei suoi racconti: “E allora [i bambini] si ribellano, diventano dei ribelli perché non hanno altro modo di difendersi. È una ribellione interiore, […]”. A Green però sta a cuore anche un’altra categoria di personaggi, quella delle donne “abbandonate nella loro solitudine, disprezzate”. Questa definizione si adatta a molti personaggi femminili di Vertigine, ma in modo quasi programmatico sintetizza la condizione in cui viene a trovarsi l’eroina – per così dire – eponima della Ribelle. Anche in questo racconto l’incipit ci presenta una voce narrante prigioniera di uno spazio angusto (una squallida camera d’albergo). La premessa della derelitta narratrice (tipico esempio di narratrice inattendibile) sgombra il campo dallo spettro freudiano del romanzo di formazione che pretende di spiegare il presente attraverso i traumi infantili: “Non sono il tipo di donna che si diletta a spiegare tutta la sua vita – inclinazioni, passioni, colpe – attraverso sporadiche impressioni risalenti all’infanzia” (a p. 105 dell’edizione Nutrimenti). Eppure il racconto che la “ribelle” si accinge a fornirci è, né più e né meno, un memoriale (quasi maupassantiano) reso necessario dall’urgenza di ristabilire una verità esistenziale proprio a partire da “impressioni” molto remote. L’andamento della novella eccede quasi la misura del racconto, o meglio: ne forza la struttura, dal momento che la storia si articola, in realtà, come un vero e proprio Bildungsroman in nuce. La prima fase di questa sorta di romanzo breve coincide con la prima infanzia della protagonista, non certo felice, ma a suo modo serena. La descrizione dell’ambiente domestico è estremamente dettagliata, e molto rilievo viene dato ai due personaggi delle zie, che creano un vivido contrasto in termini iconografici: da un lato Hélène, frivola, appassionata di letteratura rosa e crudelmente tiranneggiata dall’“idea fissa” del “piacere”, e dall’altro Simone, austera, severa e ossessionata dal “bilancio domestico” (p. 110). La transizione dallo spazio domestico alla dimensione opprimente del collegio femminile, teatro di umiliazioni e sofferenze patite in silenzio dalla protagonista, è quanto mai violenta. Tanto più che si tratta di una scuola per famiglie ricche, cui la “ribelle” è ammessa “per pura condiscendenza”, “per carità cristiana” (p. 113).
Il sadismo (vero e proprio filo conduttore della raccolta) e la cattiveria si mostrano in questa novella sotto vari aspetti, e si accompagnano a disparate manifestazioni di classismo, invidia, gelosia, egoismo: inizialmente la ragazzina è vittima della “rude sollecitudine” (p. 107) di zia Simone, sua zelante e burbera tutrice; poi subirà l’ostilità delle sue coetanee, la mendace benevolenza di facciata della madre superiora, l’ipocrisia delle maestre e la morbosa curiosità delle suore infermiere (dispensatrici, tuttavia, di letture edificanti). Le ragazze più grandi la fanno sin dall’inizio oggetto di capricciose premure, che colpiscono dritto al cuore una “personcina” ipersensibile e assetata d’affetto. La più volubile di tutte è Sauvageonne, cui alla fine toccherà, tuttavia, la parte del capro espiatorio. Lo scioglimento del racconto prevede dunque un inopinato rovesciamento di ruoli. Nello spazio carcerario del convento, la collettiva malevolenza delle “avversarie”, grandi e piccole, porterà alla rovina (l’ignominiosa espulsione) la ragazza “selvaggia” (questo il significato del nomignolo Sauvageonne che ha soppiantato il vero nome di Andrée Decluze), sospettata di blasfemia (dalle compagne in preda a una crisi di isteria collettiva) e di tendenze viziose (dalle suore malpensanti); e lascerà nel cuore dell’eroina una ferita insanabile. Nel finale la “ribelle” descrive minuziosamente l’ennesimo, decisivo trauma, che determina l’istantanea fine dell’età dell’innocenza e segna il suo ingresso in una stagione adulta contrassegnata dalla malinconia, dal disincanto, e – soprattutto – da una profonda, invincibile allergia verso “ogni forma di religione” (p. 129), cui si associa una strenua misoginia (inutile dire che qui Green presta alla sua eroina tratti autobiografici, sia pur deformati). Resta aperta la questione del rimorso, vero e proprio fulcro assiologico del testo. In questo ci sembra che il resoconto della ribelle sia la tipica narrazione elaborata dal cosiddetto narratore inattendibile: quando lo scandalo dell’amicizia particolare fra lei e Sauvageonne diventa di dominio pubblico, in quel vero e proprio panopticon che è il collegio Sainte-Marie, la protagonista “non riesce neppure a domandarsi quale colpa poteva aver commesso”; segue un istante di vertigine; poco prima sente dentro di sé “un turbamento così forte” da resistere al passare del tempo. Gli istanti di vertigine (smarrimento e deliquio, che peraltro contagiano anche comprimarie e comparse) si succedono a ritmo serrato, fino ad obnubilare la mente della ragazza: dinanzi alle accuse e ai minacciosi moniti della superiora è “troppo turbata per capire quelle parole che le sembrano del tutto prive di senso” (p. 128). Si noti anche che diversi altri momenti del racconto sono, significativamente, contrassegnati dal motivo del non-capire. Ma questa refrattarietà cognitiva sfocia, agli occhi del lettore, in un non-voler-capire. La ragazza si rifiuta di comprendere quale sia veramente la colpa da lei commessa, che non è, ovviamente, di natura sessuale, dal momento che consiste, in realtà, nel fatto di essere stata la diretta responsabile della rovina dell’amica: un escamotage della psiche che ci offre una perfetta metafora della rimozione.