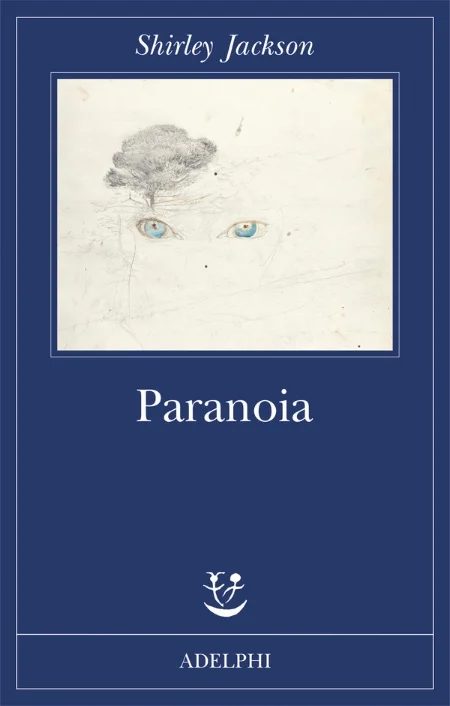di Shirley Jackson
edizioni Adelphi
Traduzione di Silvia Pareschi
pp. 205 Euro 18
di Fabrizia Gagliardi
C'è un aspetto dell'orrore che da sempre affascina i suoi estimatori. Ed è la capacità di fondarsi su regole canoniche, per la maggior parte consolidate in una lunga tradizione narrativa, e di utilizzarle per trovare continuamente linfa vitale. Stephen King va a caccia dell'ipocrisia americana, l'aspetto più superficiale e rozzo, la paura dello straniero, la vera entità del male che non si abbina sempre col mostro ma è prodotta dall'odio umano. Il male cosmico che si rivela nella sua essenza incontrollata e che sfugge alla razionalità umana nelle storie di Lovecraft. La contemplazione del bello che si accoppia sempre con la tragicità della dipartita per E- A. Poe. Si noterà come non mi sono limitata ad elencare trame e personaggi, anche se è facile individuare un filo rosso che collega questi autori grazie a scenografie caratteristiche dell'orrore (il vampiro, il non morto, la casa infestata, l’atmosfera gotica o straniante), ma mi sono concentrata sul percorso personalissimo all’interno del già noto.
«Se fosse stata l’unica storia da me scritta o pubblicata ci sarebbero state persone che non avrebbero dimenticato il mio nome» così Shirley Jackson parlava di come ha concepito La Lotteria. Il racconto è comparso New Yorker il 26 giugno del 1948 e suscitò scalpore: la rivista ricevette numerose lettere di protesta e alcuni lettori minacciarono di disdire l'abbonamento per essere rimasti profondamente offesi dalla storia. Il clima benpensante della classe media veniva punto nel vivo, mentre il racconto preannunciava quasi quello che di lì a pochi anni sarebbe stata la caccia per il dilagare del comunismo. Lo scorcio del piccolo villaggio, ritratto nella sua quotidianità, si trasforma ben presto in un'atmosfera di indicibile violenza. Proprio ne La Lotteria sono racchiusi i punti cardinali della scrittura di Shirley Jackson e di un modo inedito di concepire l'orrore. L'accumulo di dettagli – i bambini che radunano i sassi, le chiacchiere del paese – crea un effetto straniane: l'adesione alle convenzioni umane, che da sempre si espleta in azioni socialmente condivise, costruisce un riflesso opposto dalle tinte macabre, in cui tutte le promesse di normalità conducono alla follia.
Lo si noterà anche in Paranoia, la raccolta di racconti da poco pubblicata da Adelphi con la traduzione di Silvia Pareschi. Qui, però, oltre a quattro racconti inediti si leggerà anche una Jackson impegnata nella vita famigliare e in saggi sull'arte dello scrivere. Vale la pena seguire i racconti della raccolta per ricostruire la parabola di Shirley Jackson all’interno dell’orrore.
L’orrore secondo Shirley Jackson
Paranoia è il racconto che apre la raccolta e immediatamente riconosciamo l’abilità con cui l'autrice dissemina la narrazione di dettagli descrittivi che diventano distintivi, per dare vita propria al personaggio: Mr Beresford conserva il suo contegno con una rasatura perfetta, i pantaloni stirati nonostante la giornata di lavoro e la convinzione di tornare a casa per ammirare la quotidianità movimentata dal compleanno della moglie. Tutto in ordine fin quando non si accorgerà della piccola inclinazione della realtà: un uomo misterioso e mai visto inizierà a pedinarlo, e seminarlo non sarà facile.
Lo stile della Jackson incamera nella sua semplicità un'osservazione maniacale dei dettagli. Il grido d'aiuto di molti dei suoi personaggi nasce dal desiderio d’inclusione in una sfera sociale per la quale s’agghindano con maschere forzate, fin quando saranno costretti ad affrontare la loro vera natura o l'entità distorta di tutto quello che hanno intorno. Se dovessimo definire uno dei temi principali dell'autrice questo sarebbe sicuramente l'emarginazione dapprima disperatamente negata poi anelata come unica oasi di stabilità, almeno apparente.
Accade anche nel racconto Mrs Spencer e gli Oberon in cui una donna, attenta alle apparenze, è assillata dalle manie di persecuzione per una famiglia che rischierà di vanificare l'educazione, le regole e le abitudini imposte dalla donna al marito e ai figli. La parte finale del racconto si avvicina pericolosamente a un sogno ricorrente in cui più si cerca di raggiungere una meta, più questa si allontana come se fosse un’entità evanescente presente solo nelle ossessioni del sognatore:
Se rimaneva immobile sentiva distintamente cantare «O mia cara, o mia caaara Clementina», e una voce – senz’altro quella di Irma– che gridava «Popcorn! Popcorn!». Dovrò tornare indietro di nuovo, pensò; non so come, ma deve essermi sfuggita. Le scarpe erano rovinate, lo sapeva, e per fortuna non aveva cambiato i collant; aveva le mani sudice e graffiate dallo steccato, i capelli inzaccherati e il rossetto sbiadito. Gli Oberon me la pagheranno, pensò. Pagheranno ogni minima cosa; domani dirò a Harry di cacciarli via dal paese; aspettate e vedrete, disse silenziosamente agli Oberon, aspettate e vedrete cosa vi farò.
Poche volte il soprannaturale sarà esplicitamente dichiarato. Le storie più riuscite sono quelle dove esso assume un significato nuovo e del tutto distante da quanto canonicamente "mostrato" in un racconto dell'orrore: il soprannaturale affiora come realtà altra dalla mente del protagonista.
Vale la pena citare L'incubo di Hill House, un gorgo oscuro che si allargherà non tanto per strane presenze e fantasmi quanto per il suo annidarsi nella mente umana. «Hill House è abominevole, è infetta: vattene subito di qui» penserà la protagonista, Eleanor Vance. Eppure qualcosa nella vicenda della ragazza spinge il lettore a costruire un legame simbiotico tra lei e la dimora infestata: Eleanor è libera per la prima volta dopo un rapporto asfittico con la madre, ormai defunta, è ferma a uno stadio infantile, sempre sognante; non è mai stata felice e riempie il suo percorso verso Hill House con fantasticherie di case dall'entrata maestosa, tazze di stelle e gatti bianchi. Il professor Montague l'ha convocata a Hill House perché lei ha vissuto un fenomeno di poltergeist quando era piccola, ma questo aspetto avrà poca rilevanza rispetto alle ramificazioni della mente di Eleanor.
Nessun organismo vivente può mantenersi a lungo sano di mente in condizioni di assoluta realtà; perfino le allodole e le cavallette sognano, a detta di alcuni. Hill House, che sana non era, si ergeva sola contro le sue colline, chiusa intorno al buio; si ergeva così da ottant'anni e avrebbe potuto continuare per altri ottanta. Dentro, i muri salivano dritti, i mattoni si univano con precisione, i pavimenti erano solidi, e le porte diligentemente chiuse; il silenzio si stendeva uniforme contro il legno e la pietra di Hill House, e qualunque cosa si muovesse lì dentro, si muoveva sola.
Persino uno degli incipit più belli della letteratura horror, uno di quelli che ha ispirato Stephen King, raccoglie la sfida della narrazione classica delle case infestate: una sfida che non cede allo stereotipo, popolando la casa di voci, spostamenti sinistri e porte mai viste, ma è la progressiva perdita del senso di realtà che attecchirà proprio sulla più debole. «Non ho mai posseduto niente che avesse la minima importanza; puoi fare qualcosa?», «Sta cercando di formulare le frasi in modo da fare il più possibile buona impressione», il monologo continuo nella testa di Eleanor e le apparenze che cercherà di mantenere, creando uno sdoppiamento continuo. Anche per il lettore diventerà difficile discernere tra reale e soprannaturale.
Una moltiplicazione delle personalità in realtà c’era già stata con un romanzo precedente: Lizzie (traduzione di Laura Noulian, Adelphi, 2014).
Elizabeth Richmond, ventitré anni, non aveva amici, né genitori, né conoscenti e nessun progetto che non fosse sopportare l’ineludibile intervallo antecedente la sua dipartita.
Succube persino dello spazio vitale che occupa, la protagonista subisce tacitamente i soprusi della zia e il prosciugamento di ogni ambizione a fronte, però, di una vita interiore vivissima, estremamente ironica e intelligente. Tutte caratteristiche che si divideranno tra le diverse personalità di Elizabeth. Lei diventerà un mezzo potente per veicolare la condizione della donna insieme a una serie di pregiudizi sociali. Il dottore che l’ha in cura ricorda la pomposità delle spiegazioni psicanalitiche dell’Interpretazione dei sogni, senza che la razionalità dei suoi studi riesca a trovare un vero e proprio rimedio. È chiaro il contrasto velato di quell’amara ironia caratteristica della Jackson in cui la superficialità e il facile giudizio s’impongono sulla complessità umana.
Il muoversi ai margini di una cornice di cui sono malvolentieri protagonisti determina le stranezze dei suoi personaggi, lo straniamento dalla realtà e l’emarginazione che li collega a un mondo infantile. I bambini sono involucri misteriosi, della stessa sostanza delle fate, entità fantastiche che si collocano sempre tra l’innocenza e una vena demoniaca.
La dimensione favolosa che riserva un lato oscuro è rievocata anche nell’ultimo lavoro pubblicato. In Abbiamo sempre vissuto nel castello Merricat Blackwood è la voce narrante di una vita trascorsa nei confini della casa d’origine, lontano dagli sguardi sospettosi del paese. La protagonista, la sorella e lo zio sono gli unici superstiti di un misterioso avvelenamento che ha coinvolto la famiglia anni prima. L’equilibrio di Merricat si basa proprio su incantesimi ripetuti contro gli estranei, riti magici con lo scopo di allontanare ogni possibilità di contatto con l’esterno. Tutto, però, è vanificato dall’arrivo del cugino Charles che minerà l’equilibrio dell’ambiente domestico scagliandosi proprio contro Merricat.
La negazione della realtà e il rifugio nell’immaginazione, più che una fuga, costituiscono una reazione: mostrare la semplicità e la purezza di chi non ha rinunciato alla capacità di guardare il mondo con occhi diversi. La danza macabra che ossessiona la Jackson sta nel riporre nell’immaginario il nucleo fondante della persona, nel rimanere per gli altri profondamente inconoscibile ma facilmente incasellabile in luoghi comuni rigorosamente classificati dalla ragione.
Scrittrice, donna, moglie, madre
«Trovo molto difficile distinguere tra vita e finzione» ammette Shirley Jackson in Come scrivo, uno dei saggi sulla scrittura contenuto in Paranoia. Ed è strano sentirlo dire da chi si dedica a un genere che si alimenta della sospensione dell’incredulità pur rimanendo, nel suo caso, saldamente ancorato alle cose terrene. Se da una parte è inevitabile attingere a piene mani alle vicissitudini della realtà, dall’altra la Jackson ci tiene a rimarcare una distanza: «Detesto scrivere pezzi autobiografici: se il materiale è noioso non bisognerebbe infliggerlo a nessuno, e se interessante dovrei usarlo per un racconto» (da Pensamenti autobiografici contenuto in Paranoia). La creazione del narratore si configura come una dimora privata sprovvista di porte: un luogo a lui familiare al quale però si affacciano sconosciuti che arredano le stanze a proprio piacimento. La realtà del narratore, per quanto minuziosa e ben ammobiliata possa essere, deve essere predisposta al completamento che opererà il lettore. Per Shirley Jackson, come ho scritto, si trattava di prendere alcune debolezze umane che hanno a che fare col pregiudizio, l’emarginazione, una velata superbia borghese, e portarle alle estreme conseguenze. L’ambiente quasi sempre domestico delle sue storie ci dà un’idea della vita quotidiana degli anni Cinquanta e Sessanta. Lei era completamente immersa nel ruolo di madre e amministratrice della casa senza celare l’ironia dietro la vita con i figli (in Paranoia ci sono i sipari della cena in Pericoli e gioie dell’uscire a cena con i figli, In lode del silenzio a tavola) e con il marito, Stanley Edgar Hyman, critico letterario.
Mio marito recensisce libri per mestiere, e io vorrei presentare un reclamo. So che è dura di questi tempi, con le ragazze pronte ad agguantare i buoni partiti appena escono dalle superiori, ma io non credo di essermi meritata un recensore di libri. Mia madre si aspettava qualcosa di meglio per me. Ora mi rendo conto, ripensando ai fatti degli ultimi anni, che la gente sposa i recensori con la speranza che si tratti di un lavoro temporaneo, che prima o poi il poveretto troverà un posto migliore, per esempio come venditore di aspirapolvere.
(da Un florilegio di florilegi, contenuto in Paranoia)
Negli scritti che raccontano la vita domestica non riconosceremo l’indizio della depressione o della dipendenza da alcol e sigarette, ma leggeremo della capacità di fare di ogni utensile da cucina, di ogni faccenda di casa, di ogni momento in cui i bambini sono a letto, un’occasione per raccontarsi storie. Shirley Jackson anche se a suo agio nella vita di donna di casa, si raccontava storie come se fosse una possibilità reazionaria, una delle libertà alla quale concedersi completamente senza costrizioni dettate dalle convenzioni. Si stupiva perché trovava simboli, piccoli indizi che disseminava nelle sue opere che creavano una eco costante di temi ricorrenti. Eleanor, un’eterna bambina, e la sua conquista di libertà a un prezzo molto alto, Merricat e il suo essere perennemente infantile, Lizzie e la frammentazione dell’io.
Era un modo per la Jackson di disseminare il sé e rivisitarlo continuamente, come a voler lasciare una traccia distintiva. In questo troviamo il nucleo della sua teoria sulla scrittura: riportare anche scrivendo la sua vita o la realtà così com’era avrebbe creato solo un’altra gabbia. Lei ha, invece, attivato un meccanismo di sublimazione in grado di riporre nell’orrore una giustizia, una sorta di adeguata conclusione al sottile confine dove l’immaginazione, per una volta, ha la meglio sulla realtà.